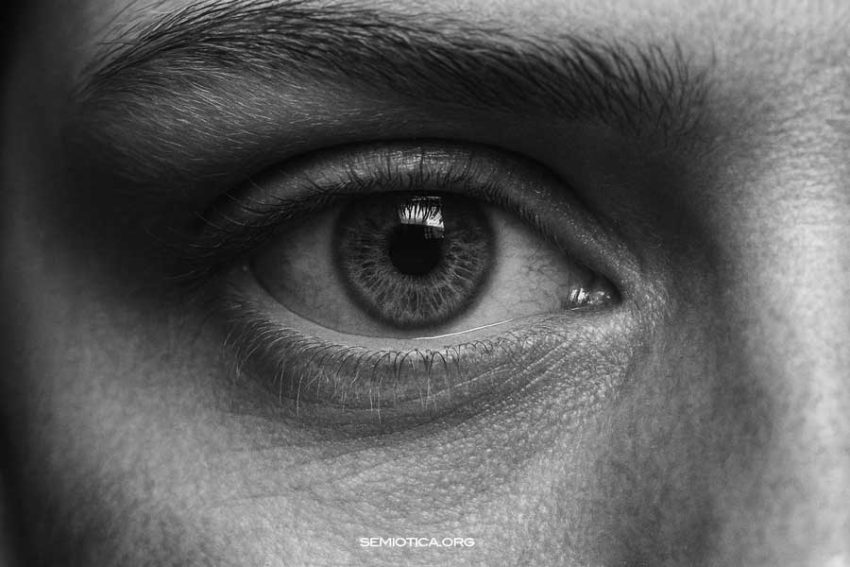Patrizia Magli mostra come il valore non si limiti a una funzione tassonomica o a una proiezione timica individuale, ma possa costituirsi come sistema assiologico all’interno di un testo. L’assiologia è la struttura valoriale profonda che sostiene il racconto: una forma di organizzazione dei contenuti, derivata dall’investimento della categoria timica su una categoria semantica.
Tutto parte da una tassonomia, cioè da una struttura classificatoria basata su opposizioni semantiche organizzate in quadrati logici: ad esempio /bianco/ vs /nero/, oppure /vita/ vs /morte/. La tassonomia di per sé è neutra: non comporta valutazione. Ma nel momento in cui i poli tassonomici vengono investiti dalle marcature timiche di euforia e disforia, si genera un sistema assiologico.
L’assiologia è dunque una tassonomia valorizzata. In molte culture occidentali, il bianco è associato a valori positivi come «purezza» o «luce», mentre il nero è legato al lutto e alle tenebre. Ma questa attribuzione non è universale: in epoche o culture differenti, le associazioni possono rovesciarsi. Il bianco, ad esempio, in certe società è colore del lutto. Lo stesso vale all’interno dei testi, dove i valori cromatici, morali o ideologici possono essere ridefiniti secondo logiche proprie.
Ogni testo è un microcosmo assiologico. Può articolare i suoi valori in modo conforme o in opposizione ai valori dominanti del contesto culturale. A volte l’assiologia messa in scena è condivisa dai personaggi e dalla collettività rappresentata. Altre volte, invece, il soggetto narrativo assume una posizione divergente, dando luogo a un sistema personale di valori.
Quando l’assiologia è interiorizzata e orienta il comportamento del soggetto, si parla di ideologia. In questo senso, Greimas intende l’ideologia non come dottrina astratta, ma come percorso sintagmatico che guida l’azione del soggetto nel racconto. L’ideologia non ha solo struttura paradigmatica, ma direzione narrativa: è una ricerca di valore, una dinamica che articola passaggi da un polo all’altro.
Magli analizza l’esempio de I due amici di Maupassant. All’inizio del racconto, durante l’assedio prussiano di Parigi, la città è in uno stato di /non vita/, e anche la natura appare svuotata. In questa condizione, due uomini ricordano i tempi in cui pescavano insieme: è un richiamo alla /vita/ perduta. Quando decidono di riprendere quell’attività, accettano di rischiare la morte pur di ritrovare un momento di libertà e normalità. Scoperti, sono messi di fronte a una scelta: collaborare con il nemico e salvarsi (/disonore/, /ubbidienza/), oppure morire per difendere un principio (/onore/, /libertà/).
Il racconto mostra così un movimento valoriale che attraversa il quadrato logico:
/vita/ → /non vita/ → /morte/ → /non morte/ → /vita/
Questa trasformazione assiologica rivela che i due personaggi accedono a una forma superiore di vita, quella dell’eroismo e del senso morale, attraverso la morte.
L’assiologia del testo viene così caratterizzata dinamicamente: non solo come sistema stabile, ma come campo di forze attraversato da soggetti, scelte, tensioni. L’ideologia è, in questo senso, la narrazione di una posizione soggettiva rispetto a un sistema di valori.
Riferimento bibliografico: Patrizia Magli, Semiotica. Teoria, metodo, analisi, Marsilio, 2004.