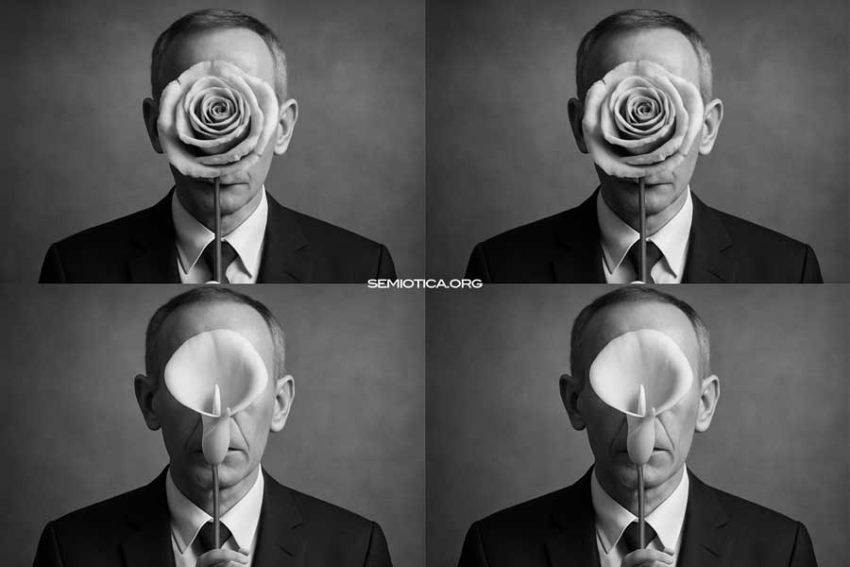Nel corso del Novecento, osserva Ugo Volli, il concetto di ideologia ha subito un processo di generalizzazione e neutralizzazione semantica, che ne ha progressivamente modificato il senso. A testimoniarlo non sono soltanto le analisi teoriche, ma anche le definizioni offerte dai principali dizionari: Treccani, Sabatini-Coletti, De Mauro. In essi compaiono due nuclei principali di significato. Da un lato, l’ideologia è intesa come sistema coerente di idee e valori orientato all’azione sociale o politica; dall’altro, come strumento dottrinale e programmatico di un partito o di un gruppo.
A partire da questa duplice accezione, Volli richiama una tesi che ha avuto ampia risonanza negli anni Settanta e Ottanta: la cosiddetta crisi delle ideologie. L’idea si diffuse in particolare dopo il fallimento del socialismo reale, la convergenza apparente degli obiettivi politici (democrazia, giustizia, ecologia) e la dissoluzione delle “grandi narrazioni”. Autori come Colletti e Fukuyama arrivarono a proclamare una vera e propria fine dell’ideologia, se non addirittura la “fine della storia”.
Ma questa dichiarazione si rivela, per Volli, prematura e infondata. L’ideologia non è scomparsa: si è trasformata. Ha perso il suo carattere totalizzante ed esplicito, ma ha assunto una forma più diffusa, frammentaria e modulare. La funzione tradizionale dell’ideologia come fondamento di un intero sistema politico ha lasciato spazio a “ideologie parziali”, spesso focalizzate su singoli temi. Queste ultime non indicano più la conquista del potere come obiettivo primario, ma si configurano come griglie interpretative fortemente normative, capaci di marcare e distinguere identità e posizionamenti.
Volli nota che l’ideologia, oggi, assume più frequentemente una funzione aggettivale che sostantiva. Il termine “ideologico” è spesso usato in senso negativo, per descrivere un atteggiamento rigido, dogmatico, preconcetto, che adatta i fatti a uno schema prefissato. Lo mostrano con chiarezza anche i dizionari dei sinonimi e contrari, dove “ideologico” è accostato a “dottrinario”, “concettuale”, “teorico”, mentre i contrari sono “pragmatico”, “realistico”, “pratico”.
Questa mutazione semantica, rileva Volli, porta con sé una perdita della dimensione collettiva e mobilitante dell’ideologia, così come l’avevano definita Marx, Gramsci, Althusser. Tuttavia, sopravvive un nucleo fondamentale: l’ideologia continua a indurre comportamenti e giudizi condivisi, spesso senza che vi sia consapevolezza. Mantiene il suo carattere pratico, la sua funzione normativa, la sua capacità di orientare l’azione. Non sparisce: si ramifica.
Riferimento bibliografico: Ugo Volli, Avventure semantiche dell’ideologia: dalla teoria delle idee ai movimenti identitari, in Interrogare il senso. Verso una semiotica critica, Nomos Edizioni, 2024.