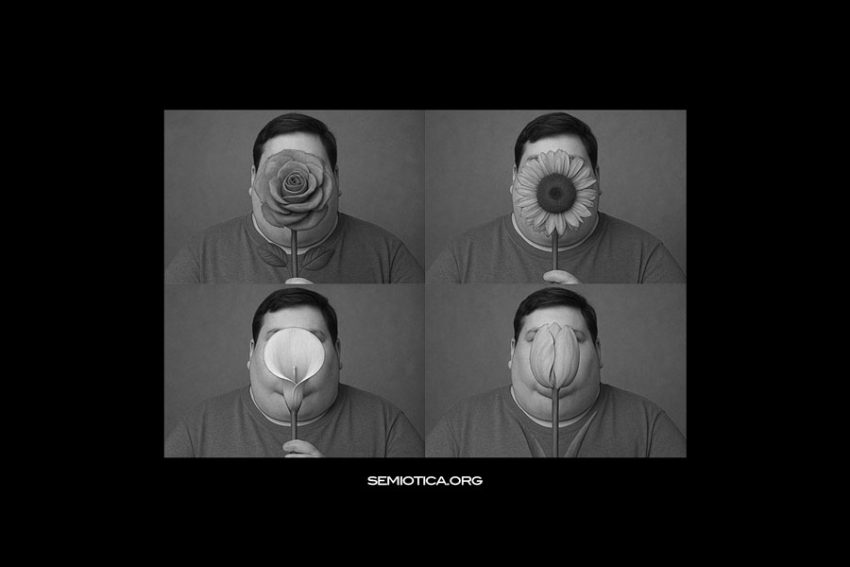Nel testo estetico, la gestione dell’attenzione del fruitore è una componente fondamentale. Daniele Barbieri osserva che l’attenzione non è un presupposto invariabile della fruizione, ma una variabile che può essere modulata e costruita dal testo stesso. Il testo estetico, in particolare, è quello in cui l’attenzione non dipende tanto dalle informazioni trasmesse quanto dalla forma interna attraverso cui esse vengono organizzate.
Quando l’attenzione volontaria extratestuale è assente o marginale, il testo deve farsi carico di costruire una dinamica tensiva sufficiente a trattenere il fruitore. Barbieri propone quindi una definizione operativa: è estetico un testo in cui l’attenzione volontaria extratestuale gioca un ruolo marginale nel determinare la continuità di attenzione del fruitore.
Uno dei meccanismi più efficaci in questa costruzione tensiva è il gioco tra aspettative forti e forme deboli. Leonard Meyer ha chiamato indebolimento della forma (weakening of form) quella condizione in cui il fruitore sa che “deve accadere qualcosa”, ma non è in grado di prevedere che cosa. La tensione non è data da una previsione precisa, ma da una necessità vaga di avanzamento.
Nel testo estetico, questa tensione indifferenziata può diventare un momento chiave. Barbieri spiega che una detective story, per esempio, non può concludersi senza svelare il colpevole. Il lettore sa che l’attesa sarà risolta, ma non sa come: la forma narrativa complessiva agisce come termine percettivo, anche se i singoli sviluppi restano imprevedibili.
Barbieri distingue poi due situazioni che vanno tenute separate:
- Da un lato, esistono i luoghi fisiologici del testo in cui le forme sono ancora deboli (ad esempio, l’inizio), dove è normale che l’aspettativa sia generica.
- Dall’altro lato, ci sono momenti costruiti strategicamente per creare una tensione generata proprio dalla mancanza di coordinate formali.
In questi casi, il testo può recuperare l’attenzione del fruitore anche da un punto di crisi: “il termine percettivo più vago appare come un’ancora di salvezza verso una recuperata prospettività”. È l’effetto di quei momenti — come spesso accade nei romanzi di Agatha Christie — in cui tutte le ipotesi del lettore vengono smontate, e l’unica certezza è che “sta per arrivare una spiegazione”. Quando Hercule Poirot comincia a rivelare la verità, proprio il precedente smarrimento rende la sua parola particolarmente pregnante.
A questa dinamica si collega un’altra nozione chiave: quella di rilievo. Barbieri definisce il rilievo come l’insieme degli elementi che contribuiscono in modo decisivo alla costruzione del significato globale del testo. L’evento testuale che riesce a risolvere una condizione di forma estremamente indebolita — quello, cioè, che introduce coerenza dove prima c’era disorientamento — acquisisce un massimo rilievo. Più è forte il contrasto tra indebolimento e risoluzione, maggiore sarà il rilievo dell’evento che produce tale svolta.
Il rilievo, quindi, non è un dato “oggettivo”, ma una costruzione interna alla dinamica tensiva del testo. Il suo effetto si genera nell’interazione tra aspettative, retorica e attenzione. Non basta creare tensione: è necessario che questa tensione interagisca con la costruzione del rilievo per produrre un senso compiuto. Solo così il testo può coinvolgere pienamente il fruitore, conducendolo fino alla chiusura finale.
Riferimento bibliografico: Daniele Barbieri, Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo, Milano, Bompiani, 2004.