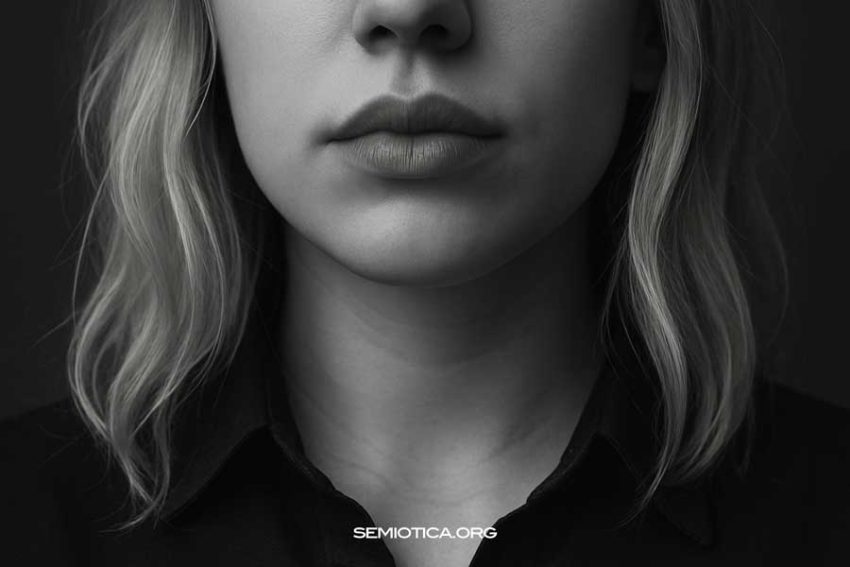Valentina Pisanty rilegge il Trattato di semiotica generale di Umberto Eco a diciassette anni dalla sua prima lettura. Una rilettura che, nella sua apparente assenza di meraviglia, produce uno spiazzamento inatteso. «Si ritrovano molti concetti familiari», afferma, «che oggi ci sembrano largamente condivisibili, però effettivamente poco che ci faccia fare un salto sulla sedia». Una condizione che entra in contrasto con la “meraviglia” provata al primo incontro con il testo, e che solleva una domanda cruciale: come si spiega questa perdita di efficacia teorica?
Una prima risposta — di ordine soggettivo — è che la ripetuta frequentazione del testo ne abbia attenuato l’effetto. Ma Pisanty suggerisce anche una spiegazione collettiva: il Trattato, avendo fatto scuola, ha contribuito a costruire il nostro stesso linguaggio. I concetti introdotti da Eco sono entrati così profondamente nel lessico disciplinare da sembrare ormai ovvi. «È noto che le scoperte di ieri sono i luoghi comuni di oggi».
Eppure, pur in questo processo di naturalizzazione, alcune formulazioni del Trattato si presentano ancora oggi come problematiche. Pisanty fa l’esempio dell’impiego «piuttosto lasco della parola “convenzione”», usata da Eco per designare fenomeni eterogenei, dall’istituzione ex novo di un codice alla cristallizzazione di inferenze. Una distinzione che sarà poi meglio articolata in testi successivi, ma che nel Trattato risente del contesto storico e teorico in cui fu elaborata.
Un secondo nodo teorico riguarda la celebre definizione della semiotica come “teoria della menzogna”. Definizione che, secondo Pisanty, permette in modo brillante di includere tra i segni, ad esempio, «l’orgasmo femminile», che può essere simulato, ma non «quello maschile» nella sua manifestazione visibile, poiché non suscettibile di simulazione. Tuttavia, Eco stesso osserva nel Trattato che i segni naturali — in quanto privi di emittente consapevole — non possono essere usati per mentire. Ne deriverebbe una contraddizione, poiché la menzogna implica necessariamente intenzionalità.
Tale contraddizione, spiega Pisanty, si può superare adottando una prospettiva morissiana: quella del segno come costruzione dell’interprete. In questa visione, non conta tanto l’origine naturale o artificiale del segno, ma il fatto che qualcuno lo riconosca come tale. Se si riformula la definizione di Eco — «il segno è ciò che può essere usato per mentire» — in chiave interpretativa, diventa: «segno è tutto ciò che, dal punto di vista di chi lo interpreta, avrebbe potuto essere usato per mentire». Una ridefinizione coerente con l’approccio inferenziale e interpretativo che Eco stesso sviluppa nel prosieguo della sua opera.
Anche in questo caso, conclude Pisanty, la forza teorica del Trattato si conferma nella sua capacità di suscitare interrogazioni attuali, benché in forma diversa. Non più come rottura o rivelazione, ma come sistema già assimilato che, proprio per questo, richiede oggi nuovi strumenti per essere riattivato criticamente.
Fonte: Valentina Pisanty, Tavola rotonda sull’eredità del “Trattato di semiotica generale” di Umberto Eco, organizzata in occasione del XXXIV congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS) nel 2006.