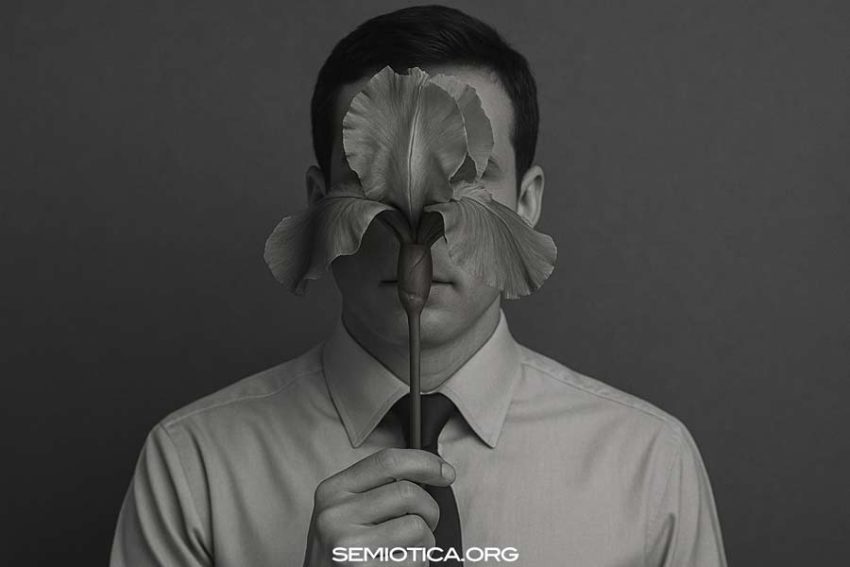Federico Montanari insiste su un aspetto del pensiero di Paolo Fabbri che appare centrale per comprendere il ruolo epistemologico della semiotica nel rapporto con le altre scienze umane e sociali: la sua natura testuale e autoriflessiva. Già nel saggio del 1973 (Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e malocchio della sociologia), Fabbri affermava che «riflettersi nelle altre discipline le dà il diritto di autoriflettersi». Questa espressione indica una dinamica complessa di rispecchiamento: la semiotica osserva le altre discipline e, in tale processo, elabora la propria immagine e la propria posizione epistemica.
Secondo Montanari, tale riflessione implica non solo intermediazione tra saperi, ma una vera e propria rappresentazione culturale di sé. È un processo che Fabbri lega a Lotman e alla sua concezione del testo come modello della cultura. Si tratta di una visione in cui ogni disciplina è attraversata da subculture, secondo la definizione di Peter Galison: comunità di pratiche teoriche e sperimentali che coesistono all’interno di uno stesso dominio scientifico.
Montanari richiama anche Ian Hacking, autore molto citato da Fabbri, per il quale osservare è anche “be observant”, ovvero essere capaci di vedere la propria disciplina riflessa nelle altre. Si tratta di una forma di osservazione autorappresentativa: la disciplina si vede specchiata in pratiche diverse, e al tempo stesso offre se stessa come superficie riflettente. Tale processo produce categorie, modelli e concetti capaci di trasformare l’oggetto stesso dell’osservazione. Come nella scienza, l’atto dell’osservare non è mai neutro, ma costitutivo del senso.
In questo quadro, la nozione di testo assume un ruolo cruciale. Per Fabbri – osserva Montanari – i fenomeni socio-culturali si presentano sempre in forma testuale. Non si tratta di “oggetti delimitati”, ma di istanze dinamiche, con un proprio campo tensionale. Il riferimento a Halliday è esplicito: ogni testo è «an instance of social meaning in a particular context of situation». Il testo è dunque evento, caso, forma situata della significazione.
Questa visione testuale si traduce anche in una forte attenzione per la dimensione relazionale, secondo l’approccio dello strutturalismo e del post-strutturalismo, ma sempre vincolata a una materialità semiotica concreta. Montanari ricorda che per Fabbri il testo è forza, movimento, conflitto, non semplice supporto. Da qui il rifiuto di modelli statici o meramente descrittivi, e l’attenzione per l’arte come laboratorio semiotico.
Riprendendo Nelson Goodman, Fabbri legge l’opera d’arte come esperimento epistemico. Essa non rappresenta semplicemente la realtà, ma ne riorganizza gli elementi e ne produce la forma. L’arte diventa “marking off new elements or classes”, costruisce categorie, distingue, crea. La sua funzione è diagnostica e prognostica: individua i tratti dominanti di un’epoca e ne anticipa gli sviluppi. «Nature is a product of art and discourse», scrive Goodman. Un’affermazione che Fabbri fa propria nel pensare l’arte – e la semiotica – come potere costruttivo e non solo descrittivo.
In definitiva, Montanari restituisce l’immagine di una semiotica che è strutturalmente testuale, teoricamente relazionale, epistemologicamente autoriflessiva. Una disciplina che non si limita a osservare il mondo, ma che, riflettendosi negli altri saperi, costruisce sé stessa come oggetto e come metodo. Un campo, potremmo dire, sempre in atto.
Riferimento bibliografico: Federico Montanari, La semiotica e le “altre”, in «Versus», n. 133, 2/2021, pp. 273-284.