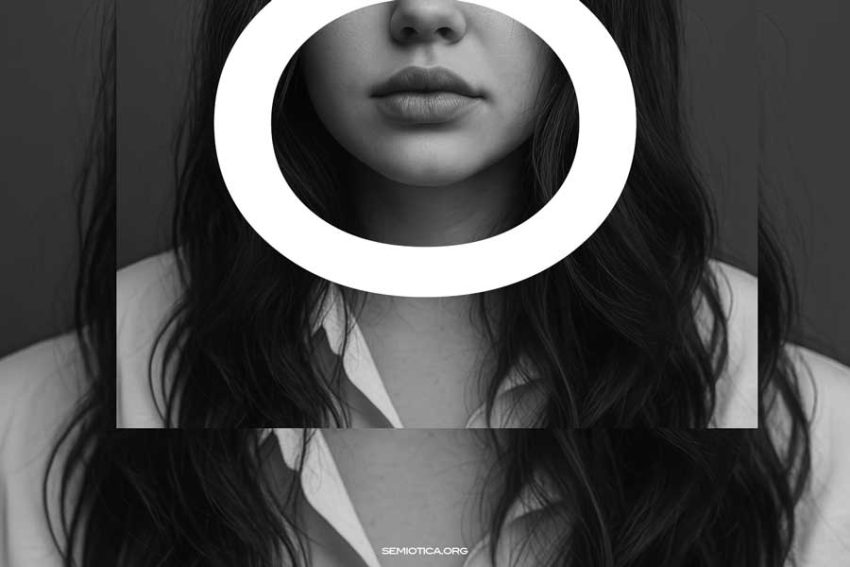La riflessione sull’essere non può restare separata dall’indagine semiotica. Umberto Eco afferma che la semiotica non deve interrogarsi solo su come usiamo i segni per riferirci a qualcosa, ma anche su che cosa ci induce a produrre segni. Si tratta di affrontare il rapporto tra semiosi e ciò che precede o eccede la produzione del significato.
In questa prospettiva, Eco riprende la distinzione peirceana tra Oggetto Dinamico e Oggetto Immediato. Il primo non è direttamente accessibile, ma è ciò che «ci spinge a produrre un representamen», generando la catena degli interpretanti. È dunque ciò che attiva la semiosi, pur restando inafferrabile: «l’Oggetto Dinamico rimane sempre come una Cosa in Sé, sempre presente e mai catturabile, se non per via, appunto, di semiosi».
Eco descrive questa spinta originaria come un impulso esercitato dal Qualcosa che ci obbliga a parlare, pensare, nominare. «Produciamo segni perché c’è qualcosa che esige di essere detto», scrive. E aggiunge, con espressione volutamente brutale: «l’Oggetto Dinamico è Qualcosa-che-ci-prende-a-calci e ci dice “parla!”».
Questa dinamica viene illustrata attraverso il concetto di indicalità primaria o attenzionalità primaria, mutuato da Peirce. Si tratta di una fase ancora presemiotica, in cui l’esperienza sensibile viene improvvisamente selezionata, isolata, percepita come degna di attenzione. Prima ancora della produzione di un segno, si verifica un gesto mentale: nel magma delle sensazioni, qualcosa «ritagliamo su quello sfondo generale, decidendo che vogliamo parlarne».
L’indicalità primaria si distingue da ogni uso convenzionale del segno: precede la codifica, l’intenzionalità comunicativa, persino la percezione categoriale. È l’atto per cui, ad esempio, ci accorgiamo che «ci fa male il piede», ma solo dopo essere stati colpiti da una sensazione confusa. È anche l’atto con cui attirare l’attenzione di un altro, «non necessariamente per parlargli ma anche solo per mostrargli qualcosa che dovrà diventare segno».
Eco propone un’interpretazione semiotica dell’esperimento classico di Quine sulla “traduzione radicale”: prima che due individui stabiliscano una convenzione linguistica, si verifica un gesto di attenzione comune verso un evento. Non è ancora semiosi, ma ne è la condizione.
La riflessione si spinge oltre. Prima ancora dell’attenzione pienamente formata, Eco postula un’«attenzione in dormiveglia», un’attitudine in agguato che fa già parte del Qualcosa. L’essere, allora, non è solo ciò a cui ci riferiamo: è ciò che ci impone di iniziare a riferirci. È il fondamento muto, ma operativo, che precede ogni costruzione linguistica e ogni interpretazione.
Questa posizione sposta l’interesse della semiotica verso la soglia aurorale della significazione. La semiosi non comincia nel linguaggio, ma nel contatto con qualcosa che obbliga a significare, anche se non può ancora essere nominato.
Riferimento bibliografico: Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco, Milano, Bompiani, 1997.