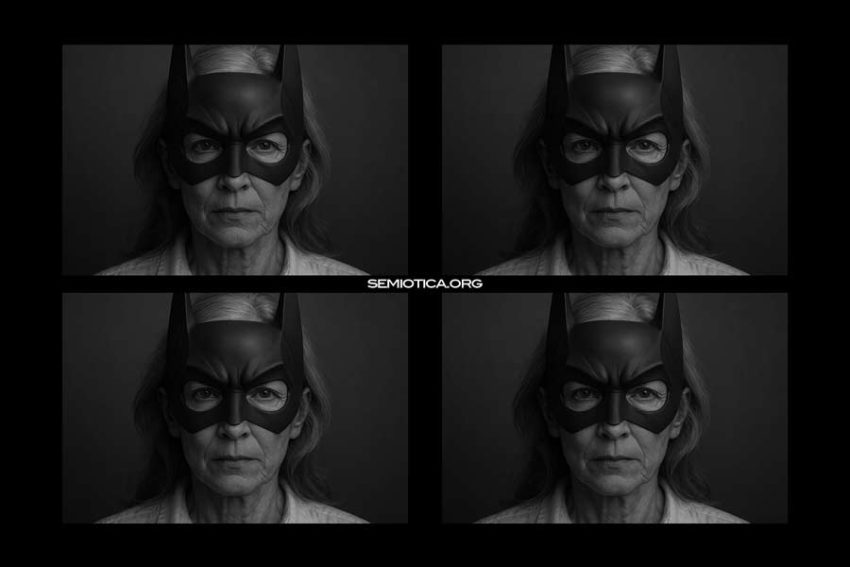Che cosa accade nei primissimi istanti della semiosi, quando un interprete si trova di fronte a un Qualcosa di inatteso? Umberto Eco affronta questa domanda nel tentativo di definire ciò che accade prima che entrino in gioco le regole del riconoscimento. Come ricorda Valentina Pisanty, nelle parabole disseminate in Kant e l’ornitorinco — da Marco Polo e il rinoceronte fino all’ornitorinco stesso — Eco racconta varianti di uno stesso schema narrativo: l’incontro con un fatto sorprendente che mette in crisi le categorie disponibili.
Per Eco, seguendo una riflessione già presente in Peirce, la sorpresa non nasce dall’irregolarità, ma dal manifestarsi di una regolarità imprevista. Quando qualcosa non si adatta alle griglie categoriali note, l’interprete può forzare la percezione oppure iniziare un processo di riformulazione delle proprie rappresentazioni. È in questo snodo che si colloca il tentativo di Eco di pensare una fase originaria della semiosi, una sorta di momento aurorale in cui l’interprete è costretto a registrare un dato dissonante, come nella formula esemplare: “eppure è nero”.
Ma come rendere conto di questo istante pre-abduttivo senza cadere nell’intuizionismo? La nozione di intuizione, intesa come pensiero non derivato da altri pensieri, è programmaticamente esclusa da una semiotica ispirata a Peirce. Ogni esperienza, anche la più elementare, è costituita da primità, secondità e terzità. Pisanty nota che, se pure si cercasse di scomporre infinitesimalmente il processo, dovrebbe esistere un punto — un fotogramma — in cui dalla pura secondità dei corpi collimanti emerge una scintilla di terzità: per esempio l’istante in cui una sensazione viene riconosciuta come prurito e poi interpretata come “sono stata morsicata da una zanzara”.
Eco propone di pensare questa fase iniziale in termini di iconismo primario, ovvero di una corrispondenza strutturale tra le caratteristiche dell’Oggetto e le predisposizioni del dispositivo interpretante. Le metafore che utilizza sono numerose e suggestive: “la disponibilità naturale di qualcosa a incastrarsi con qualcos’altro”, “una serratura che cerca e trova la propria chiave”, “predisposizione all’incastro”, “uno stato fisico per cui una struttura è disposta a interagire con un’altra”.
Apparentemente, queste sono metafore meccaniche. Ma Pisanty osserva che, prestando attenzione ai verbi metaforizzanti, emerge un elemento ulteriore: la tendenza a proiettare intenzionalità sugli oggetti. È lo stesso slittamento che si ritrova nella nozione echiana di intentio operis, secondo la quale il testo “vuole dire qualcosa” in virtù della propria coerenza interna.
Questo porta a una domanda decisiva: chi o che cosa garantisce che un Qualcosa e un Qualcun altro siano predisposti all’incastro? Se si prende sul serio la metafora, allora l’origine del senso non sarebbe puramente nella resistenza dell’oggetto, ma in forze o abiti — predisposizioni all’azione — che precedono il contatto stesso. In altre parole, si attribuisce alla terzità un ruolo originario, anteriore al processo inferenziale.
Secondo Pisanty, questa soluzione non risolve del tutto il problema dell’intuizionismo. Lo stesso Eco, nel tempo, sembra prenderne atto, introducendo una distinzione tra pertinentizzazione molare (fenomenologica) e molecolare (cosmologica), per descrivere i momenti in cui il soggetto coglie la propria firstness. È solo nel momento in cui l’evento produce un’esperienza — ad esempio una sensazione fastidiosa al braccio — che si può dire che la soglia della semiosi è stata varcata.
Affinché ci sia interpretazione, infatti, non basta un Qualcosa da interpretare. Occorre anche Qualcuno che lo interpreti, e che lo faccia sulla base delle proprie predisposizioni, abiti, interessi. Ma, come nota Pisanty con onestà teorica, a questo punto si è già in piena terzità, e dunque il problema dell’origine resta aperto.
Fonte: Valentina Pisanty, “No, We Kan’t. Percezione, linguaggio e realtà in prospettiva semiotica”, in occasione del Convegno “Percezione, cognizione e semiotica”, Bologna, 2017.