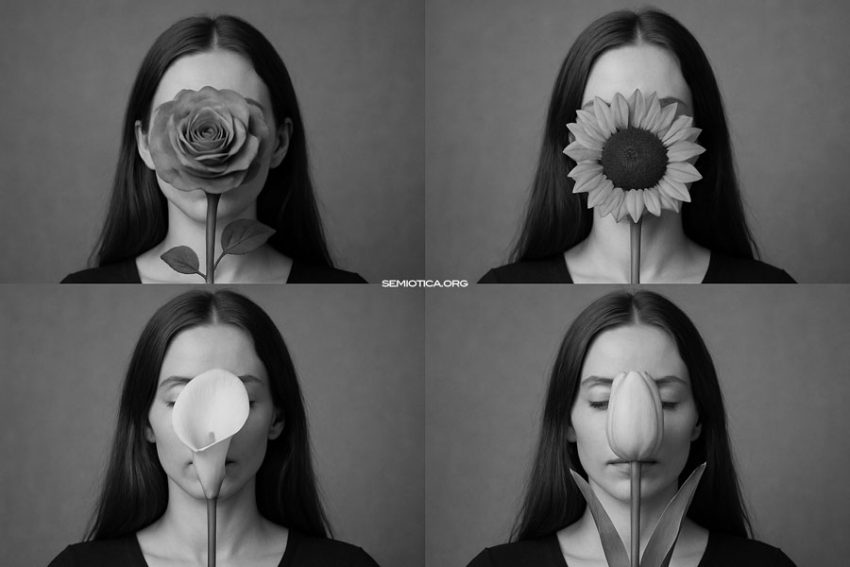Erano gli anni in cui chiunque si occupasse di semiotica si sentiva in dovere di virgolettare la parola “realtà” con un gesto delle dita. L’idea che la natura fosse un costrutto culturale e che la verità costituisse un semplice effetto di senso circolava non solo nell’accademia ma anche nei media, nella cultura popolare e nel senso comune, alimentando derive scettiche e in certi casi paranoiche. Ma secondo Valentina Pisanty, non si trattava tanto di uno scontro tra strutturalismo e senso comune, quanto piuttosto dell’esito dogmatico di teorie nate per essere contro-intuitive e divenute poi luoghi comuni: ipotesi radicali come il faut tuer le référent o il n’y a pas de hors-texte, spesso fraintese, finirono per cristallizzarsi in slogan.
È in questo contesto che Umberto Eco elabora il proprio “realismo negativo”, recuperando da Peirce e Popper la nozione di Oggetto Dinamico come termine a quo della semiosi. Per Eco, «affinché ci sia interpretazione, occorre che vi sia qualcosa da interpretare». La semiosi presuppone dunque un elemento resistente, un Qualcosa che si dà come già presente, anche se sempre mediatamente.
Eco lo descrive come ente o evento “obsistente”, nel senso peirceano del termine, e lo definisce nei termini di una negatività operante: una realtà che non si conforma docilmente alla volontà dell’interprete, ma al contrario lo costringe a fare i conti con vincoli esterni. È un oggetto che “ci tira per la giacca”, che “ci resiste”, fino a “ostruire il cammino” o manifestarsi come “porta chiusa” o “puro No”.
Le metafore disseminate in Kant e l’ornitorinco – il Qualcosa-che-ci-prende-a-calci, ci bombarda, ci resiste – evocano una realtà rigida, recalcitrante, che non può essere piegata ai desideri interpretativi. In opposizione alla proposta di Richard Rorty, secondo cui gli oggetti dovrebbero “battersi in modo da adattarsi ai propositi dell’interprete”, Eco insiste invece sul fatto che l’Oggetto si fa conoscere proprio quando rifiuta di adattarsi. È in questo rifiuto che si manifesta il suo essere “realmente efficiente ma non immediatamente presente”.
In questa prospettiva, l’Oggetto è ciò che induce l’interprete a ridimensionare le proprie strategie, a riformulare le proprie griglie interpretative. È, allo stesso tempo, punto di partenza e punto di rottura. Anche quando si tratta di oggetti culturalmente interpretati – come nel caso delle testimonianze – essi operano come secondità ineludibili: sono presenze che non si possono ignorare.
Pisanty sottolinea che l’elaborazione di Eco si colloca polemicamente contro i decostruzionisti, che rivendicavano una libertà assoluta dell’interprete e una concezione della realtà come costruzione discorsiva priva di resistenza. E anche, seppur più tacitamente, contro gli strutturalisti, che avevano a lungo concepito il testo come unico orizzonte possibile.
Ma Eco, nel suo tentativo di tenere insieme le due prospettive, recupera un’idea di realtà duplice: da un lato come sistema di vincoli, dall’altro come orizzonte di possibilità. Se da una parte l’esperienza si presenta come ciò che limita le proiezioni interpretative, dall’altra è anche ciò che le rende possibili, come “un bagno amniotico” o “un magma”, per usare le immagini liquide provenienti dallo strutturalismo.
Secondo questa prospettiva, la materia dell’esperienza appare tanto più modellabile quanto più forti sono le strutture linguistiche che la formano. Tuttavia, ciò non esclude un punto d’attrito, un’irruzione dell’inaspettato, un incontro che obbliga a ristrutturare le categorie. In questo senso, Eco propone di considerare l’Oggetto come vero e proprio stimolo originario della semiosi.
Fin da Opera aperta, l’autore si interroga su ciò che stimola e al tempo stesso argina l’interpretazione. Il problema non è solo che la percezione è mediata dalle strutture linguistiche e culturali: è che, a volte, qualcosa ci costringe a metterle in discussione. È in quell’istante – lo shock percettivo – che si apre una breccia nel sistema, e con essa la possibilità di una nuova interpretazione.
Fonte: Valentina Pisanty, “No, We Kan’t. Percezione, linguaggio e realtà in prospettiva semiotica”, in occasione del Convegno “Percezione, cognizione e semiotica”, Bologna, 2017.