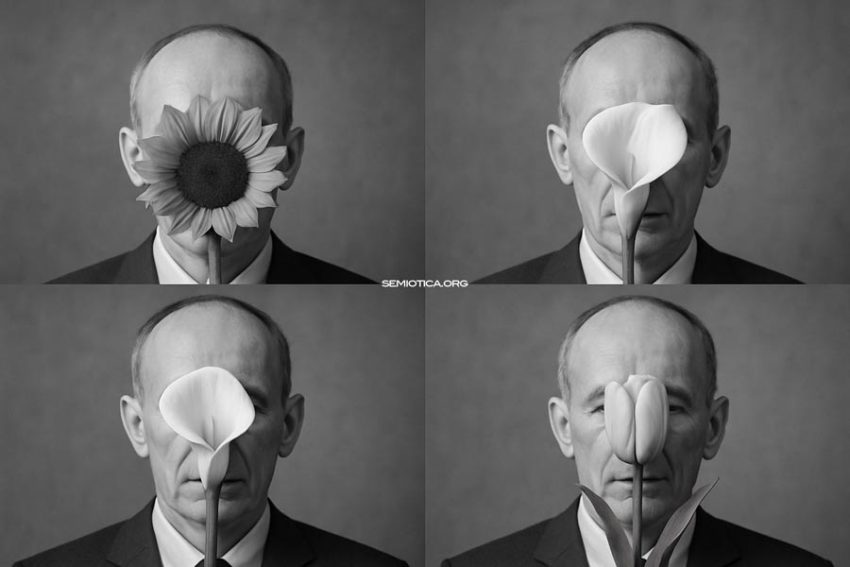La ripetizione, nel testo estetico, è un fenomeno complesso e dinamico. Daniele Barbieri — riprendendo la teoria di Leonard Meyer — sottolinea che la ripetizione psicologica non esiste mai, perché ogni nuova occorrenza modifica il soggetto che la riceve. Il fruitore è sempre diverso, proprio in virtù dell’esperienza accumulata durante la fruizione stessa. Per questo, ogni ripetizione ha effetti nuovi: suscita aspettative, consolida strutture o crea tensioni inattese.
Barbieri distingue tre principali modalità della ripetizione:
1. Ripresa
La ripresa si verifica quando un termine percettivo già incontrato ritorna nel testo, senza che venga riproposta l’intera forma a cui inizialmente rinviava. In questi casi, il termine è ormai sufficientemente riconoscibile da evocare direttamente quella forma. La ripetizione della forma completa diventerebbe dunque ridondante, e proprio questa ridondanza acquista un significato: segnala che la forma è divenuta autonoma, simbolicamente carica.
Barbieri osserva che, quando la forma originaria viene ripresentata integralmente, essa non rimanda più solo a sé stessa, ma anche al contesto testuale in cui era comparsa la prima volta. Il suo ritorno implica una rielaborazione interpretativa, una risonanza che coinvolge l’intero tessuto narrativo, metrico o retorico che la circondava.
2. Sfondo
La ripetizione di sfondo è quella che avviene su elementi percettivi marginali, ai quali il fruitore presta attenzione solo in modo indiretto. Lo sfondo opera come base di contrasto, una condizione di uniformità che consente alle configurazioni in primo piano di risaltare. Quando questa uniformità si rompe, la ripetizione diventa visibile e acquista rilievo.
Un esempio evidente è dato dalla metrica italiana, dove l’alternanza tra sillabe accentate e atone crea uno schema ritmico costante. Nel componimento L’infinito di Leopardi, Barbieri segnala due rotture di questa aspettativa: “mi fingo; ove per poco” e “il pensier mio”. Proprio perché inserite in uno sfondo regolare, queste deviazioni acquisiscono forza tensiva.
3. Iterazione ostinata
La iterazione ostinata è la ripetizione in primo piano. Qui, a differenza dello sfondo, la ripetizione genera saturazione: il fruitore attende una trasformazione, ma questa non arriva. L’effetto è quello di una tensione prolungata, che cresce di intensità quanto più si prolunga l’assenza di risoluzione.
Barbieri, seguendo Meyer, spiega che ogni forma percepita sul primo piano si configura come termine percettivo di una forma più complessa. La sua ripetizione impedisce lo sviluppo, bloccando l’attesa della forma successiva. Questo è uno dei meccanismi fondamentali dell’effetto di crescendo.
Due segmenti de L’infinito offrono esempi potenti di iterazione ostinata. Nel secondo segmento, la sequenza “Ma sedendo e mirando, interminati / Spazi di là da quella, e sovrumani / Silenzi, e profondissima quiete” introduce una serie di sintagmi che ritardano la comparsa del soggetto e del verbo: la sospensione della chiusura rafforza l’intensità semantica. Nel terzo segmento, invece, l’elenco “e mi sovvien l’eterno, / E le morte stagioni, e la presente / E viva, e il suon di lei” produce un continuo slittamento della chiusura: ogni volta sembra che stia per arrivare, e ogni volta viene rimandata. L’effetto è una tensione crescente, che culmina nella conclusione del testo.
È importante sottolineare, con Barbieri, che la ripetizione non è mai una ripetizione dell’identico: essa avviene sempre in un contesto diverso, su livelli diversi, con implicazioni diverse. Può esserci identità a livello sintattico, ma non metrico; o a livello semantico, ma non lessicale. Quando la ripetizione coinvolge più livelli formali contemporaneamente, l’effetto tensivo si intensifica.
La ripetizione, dunque, non è una semplice strategia retorica, ma una struttura fondamentale dell’organismo testuale. Nelle sue diverse forme – ripresa, sfondo, iterazione – essa modula le aspettative, costruisce ritmo, genera sorpresa e determina il rilievo degli eventi testuali.
Riferimento bibliografico: Daniele Barbieri, Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo, Milano, Bompiani, 2004.