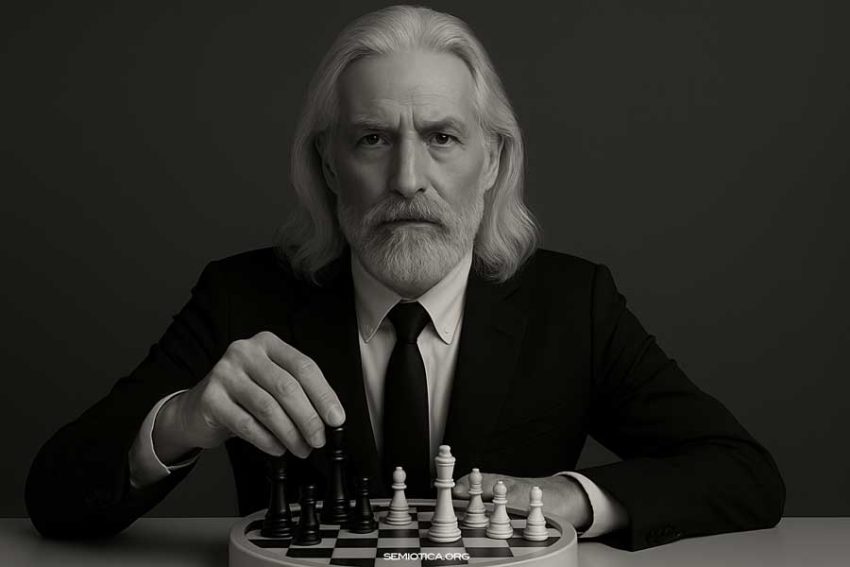Un aspetto centrale della teoria semantica di Patrizia Violi, come messo in rilievo da Stefano Traini, riguarda il rapporto tra regolarità e variazione nel significato linguistico. Violi sostiene che, se possiamo parlare di una competenza semantica, allora dobbiamo postulare una certa stabilità nei significati: una sorta di blocco di significati standard, regolari, convenzionali, che rende possibile la comunicazione linguistica. Ma, nello stesso tempo, questa stabilità non può che coesistere con la variabilità e la plasticità del linguaggio.
La lingua, scrive Violi, vive di rigidità e innovazione, di strutture condivise e flessibilità contestuale: è abbastanza rigida da garantire la comprensione del termine sedia, ma sufficientemente elastica da permettere, in un contesto appropriato, di chiamare “sedia” anche una pila di libri. Le possibilità creative del linguaggio, dunque, non negano l’esistenza di una dimensione stabilizzata, ma piuttosto la presuppongono.
Questo equilibrio tra regolarità e variazione porta Violi ad affrontare un problema teorico cruciale: il problema del contesto. Secondo Traini, si possono distinguere due grandi prospettive sul rapporto tra significato e contesto:
- una prospettiva esternalista, in cui il significato è determinato dall’ambiente, dalla situazione e dai riferimenti extralinguistici;
- una prospettiva internalista, in cui il significato si costruisce all’interno della mente, secondo strutture logiche e cognitive.
Nel solco della prima prospettiva, Violi insiste sulla centralità dell’esperienza fenomenologica, che attribuisce rilevanza diversa alle entità in base alla nostra interazione con esse. Ad esempio, il termine gatto ha una salienza molto maggiore nella vita quotidiana di molti parlanti rispetto a uranio, e questa differenza si riflette nel peso che attribuiamo alle competenze referenziali associate a ciascun termine.
Traini riporta le osservazioni di Diego Marconi per mostrare come le competenze linguistiche possano variare sensibilmente da un individuo all’altro: un chimico ha una conoscenza specialistica dell’amianto, molto diversa da quella della maggior parte dei parlanti. Tuttavia, anche un non esperto può avere una competenza referenziale sufficiente a riconoscere l’amianto, pur ignorandone la struttura chimica.
Violi accetta questa distinzione, ma ne sposta l’accento sul piano dell’esperienza vissuta: ciò che conta non è l’accumulo di informazioni, ma la rilevanza fenomenologica delle entità, cioè il loro peso esistenziale e culturale. In questo modo, si giustifica anche la diversa importanza sociale di certe competenze semantiche: saper distinguere un cane da un gatto è considerato più fondamentale (e socialmente condiviso) che saper distinguere una varietà di uccelli o piante.
La conclusione che ne deriva è che il significato linguistico non può essere separato dalla vita della lingua nella comunità e dal modo in cui questa lingua riflette la nostra esperienza del mondo. La competenza semantica appare così come un sapere medio, culturalmente condiviso, che si stabilizza attraverso l’uso ma resta aperto alla variazione, all’innovazione, alla negoziazione pragmatica.
Riferimento bibliografico: Stefano Traini. Le due vie della semiotica: Teorie strutturali e interpretative (Strumenti Bompiani)