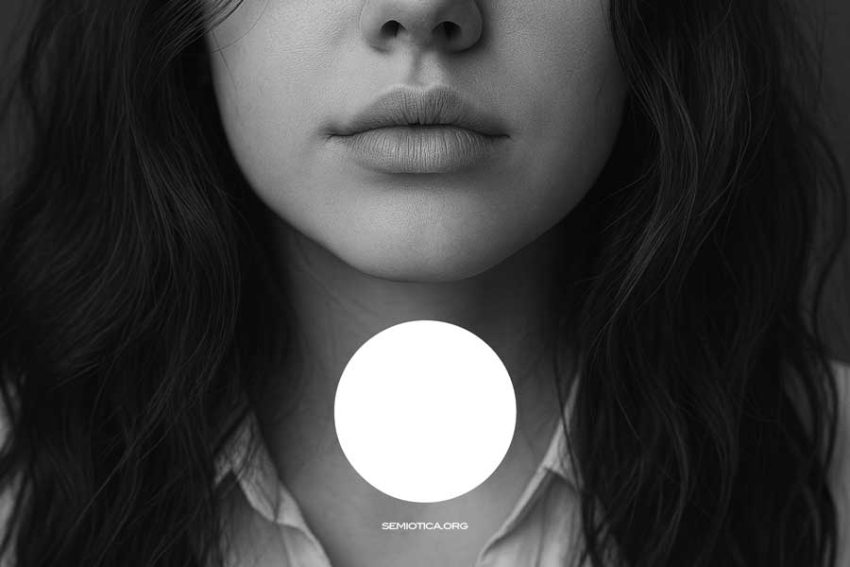Max Weber, nel tentativo di individuare idealtipi religiosi funzionali alla propria interpretazione dello sviluppo capitalistico, elabora una contrapposizione tra ascesi e misticismo. Il primo viene associato all’attività, il secondo alla passività, secondo uno schema che egli stesso articola così:
Ascesi / Misticismo = Attivo / Passivo.
Da questo punto di vista, il mistico appare a Weber come colui che vive “di bacche nei boschi o di elemosine”, estraniato dal mondo, immerso esclusivamente nel proprio sé. L’asceta, invece, è colui che “per mezzo della sua condotta razionalizzata è trascendentalmente macerato” ma, proprio per questo, secondo il mistico, resta invischiato nelle contraddizioni del mondo. E viceversa: l’asceta giudica il mistico come colui che, pensando solo a se stesso, vive in un’incoerenza perpetua, poiché – essendo in vita – non può evitare di provvedere alla propria sussistenza.
Galofaro mostra come questa rigida dicotomia venga smentita dalla realtà dei testi e delle esperienze storiche. Numerosi scrittori spirituali sono sia mistici sia asceti: Hildegard von Bingen, Simone Weil, Caterina da Siena, Teresa di Lisieux, Marthe Robin, e gli stessi Wittgenstein e Padre Pio testimoniano un impegno attivo nel mondo, spesso in contesti di crisi sociale o guerra. L’idea di una passività totale del mistico è pertanto una semplificazione.
Questa semplificazione, secondo Galofaro, rappresenta una “ideologia semiotica”, cioè una selezione sistematica di tratti di significato funzionale a uno scopo teorico esterno al corpus analizzato. Weber, riducendo la complessità del discorso religioso a un modello utile a dimostrare la relazione tra ascesi protestante e capitalismo, finisce per narcotizzare la “paradossalità” del discorso mistico, che invece si costruisce all’interno di un universo semantico contraddittorio.
Galofaro osserva che l’opposizione proposta da Weber è costruita su un’antinomia semantica rigida. Tuttavia, in testi religiosi autentici, tali opposizioni spesso si dissolvono in “termini complessi” che uniscono le proprietà contraddittorie. Riprendendo la definizione di Greimas e Courtés, il termine complesso si configura come il risultato della coesistenza sintattica di contrari (“both… and”), una struttura ben documentata nella tradizione filosofica e religiosa, come mostrato dagli studi di V. Brøndal.
L’analisi semiotica testuale, al contrario dell’approccio sociologico, privilegia l’esame puntuale dei testi e dei loro meccanismi interni di significazione, evitando generalizzazioni eccessive. Essa consente di cogliere come il misticismo, lungi dall’essere mera passività, sia spesso un luogo di produzione attiva di senso, in risposta alle condizioni storiche e corporee vissute dal soggetto.
Secondo Galofaro, Weber riduce le pratiche religiose alla ricerca della salvezza individuale, trascurando che per molti asceti e mistici Dio resta un’entità sovrana che non può essere obbligata a concedere la grazia. Il loro sforzo spirituale non mira a ottenere, bensì a trasformare la propria soggettività attraverso una gerarchia di senso: spirito, ragione e anima che governano corpo, passioni e materia. Questa struttura semiotica gerarchica – che Galofaro associa al concetto hjelmsleviano di “classe di classi” – è ciò che dà senso all’esperienza ascetica.
Infine, l’autore introduce una distinzione particolarmente rilevante: mentre l’ascesi si esprime nel corpo e non richiede scrittura, il misticismo ha bisogno della scrittura per legare l’esperienza sensibile a valori spirituali. Da questo punto di vista, scrivere la mistica è parte costitutiva del suo stesso essere, una forma di “lavoro semiotico” sul corpo e sull’anima, il cui scopo è la produzione e il riconoscimento del senso.
Riferimento bibliografico: Galofaro, Francesco. “Mystics at war: Padre Pio and Ludwig Wittgenstein” Semiotica, vol. 2025, no. 265, 2025, pp. 137–160. https://doi.org/10.1515/sem-2025-0091