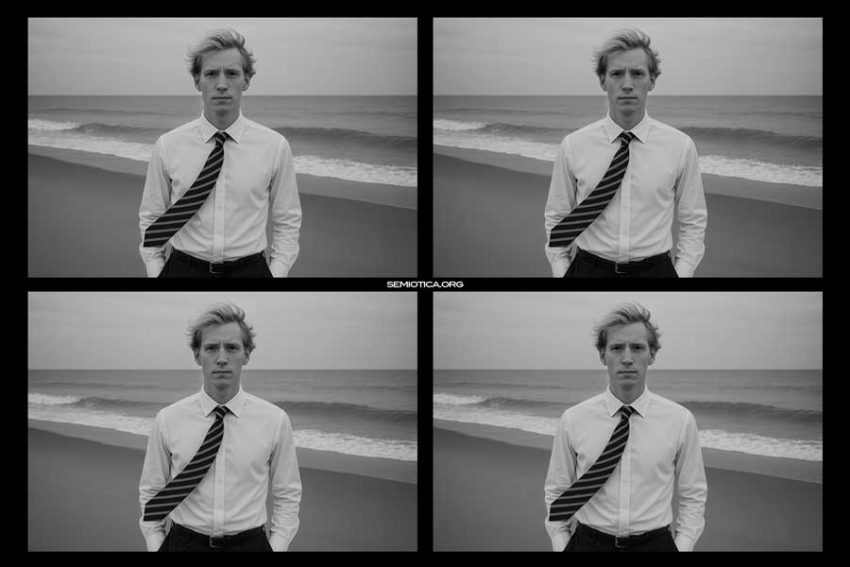Il passaggio dall’effetto di realtà all’effetto di verità implica un cambiamento significativo nell’orizzonte teorico: non si tratta più soltanto di sembrare reale, ma di apparire vero. Isabella Pezzini mostra come l’effetto di verità non si limiti a una corrispondenza tra enunciati e stati del mondo, ma coinvolga una dimensione più sottile: quella della rivelazione, della perspicuità, dell’esperienza riconosciuta.
In ambito semiotico, questo slittamento si traduce in un’attenzione privilegiata al discorso e alla sua costruzione strategica. In luogo della verità intesa come adeguazione al referente, emerge il concetto di verosimiglianza come parametro di credibilità, profondamente influenzato da fattori culturali e dalla rappresentazione che il testo si fa del proprio destinatario. Scrive Greimas:
“Se la verità non è altro che un effetto di senso, la sua produzione consiste allora nel far-sembrare vero”, ovvero nel costruire un discorso capace di essere letto come vero.
L’adesione del destinatario avviene solo se vi è corrispondenza tra testo e aspettative, tra simulacro e universo assiologico del lettore.
Il discorso figurativo diventa allora uno dei luoghi privilegiati per l’analisi di questi effetti. In questa prospettiva, Denis Bertrand mostra come il realismo o il naturalismo non siano altro che canoni di leggibilità storicamente determinati. L’efficacia simbolica di un discorso dipende dalla sua capacità di mobilitare figure riconoscibili, integrandole in configurazioni narrative compatibili con l’esperienza del destinatario. È questa capacità di generare omologazioni a fondare la comunità di senso e, con essa, l’efficacia sociale del testo.
Anche Jacques Geninasca interviene nel dibattito sottolineando che la significazione non può mai essere intesa come un dato immediato. I legami tra un’opera e ciò che la precede – la biografia dell’autore, gli eventi storici, le fonti testuali – sono sempre mediati da una costruzione discorsiva. Le figure del mondo non sono risultati, ma punti di partenza dell’interpretazione. La significazione nasce dall’organizzazione narrativa che le dispone in relazione reciproca.
Il dettaglio, in questa logica, non è importante in quanto tale, ma per la posizione che occupa all’interno della configurazione testuale. È in questa relazione che si produce la verità del discorso, una verità che può benissimo prescindere dalla conformità al reale e che, tuttavia, conferisce esistenza e identità all’enunciatore.
La realtà, come mostra Geninasca, è sempre presa soggettiva. La sua verità si misura, infine, non come adeguazione ma come efficacia: il sentimento di realtà prodotto nel soggetto, la trasformazione assiologica che da esso deriva. Nella comunicazione estetica, ciò che si significa non è l’oggetto, ma gli stati timici e modali del soggetto. Il significato coincide con il modo in cui il soggetto sente e si sente dentro il discorso.
Riferimento bibliografico: Isabella Pezzini, L’efficacia del testo. Effetti e affetti nella semiosi