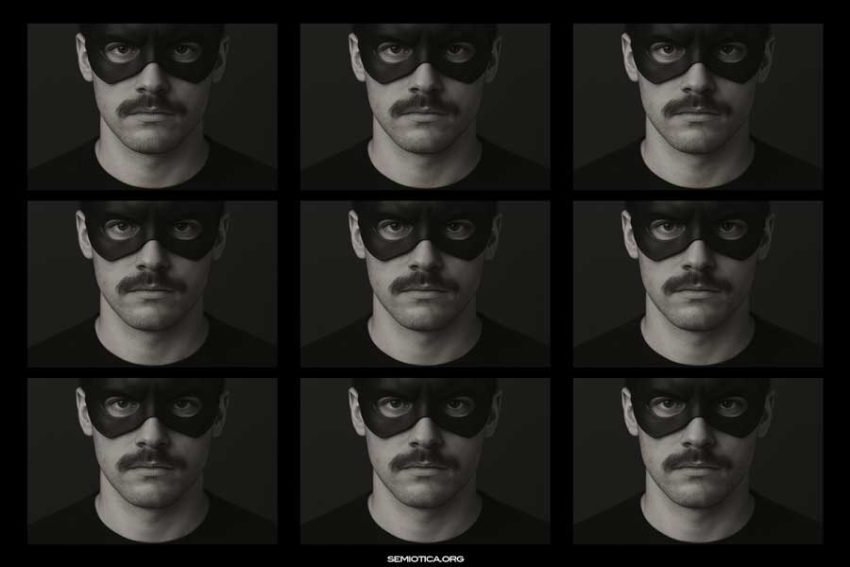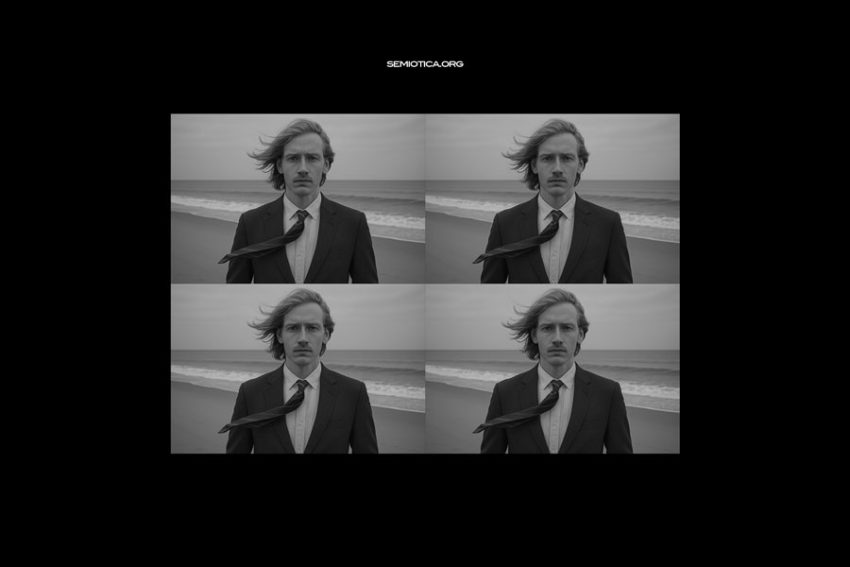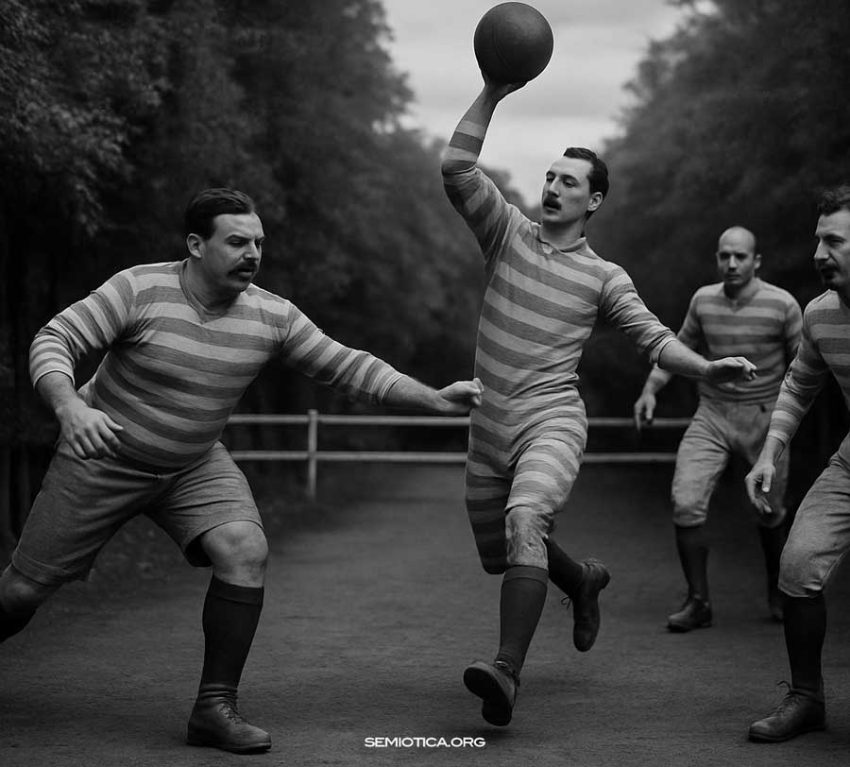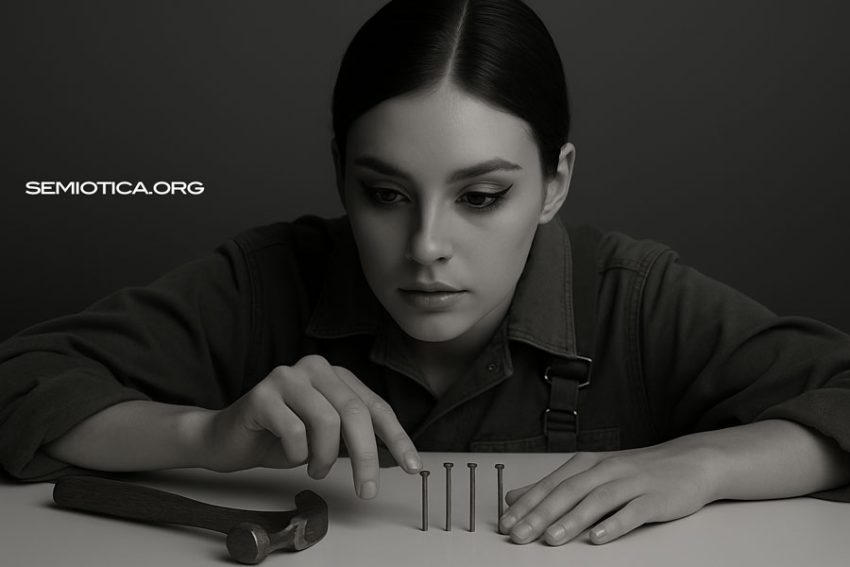Anna Maria Lorusso propone una rilettura del Trattato di semiotica generale come testo che prefigura — e in parte già realizza — un orientamento verso una semiotica della cultura. L’idea che Eco abbia dato vita a una semiotica strutturale, opposta a una semiotica interpretativa, appare infatti riduttiva. Già nel Trattato, sostiene Lorusso, è possibile rintracciare una teoria…
Tag: Retorica
Le origini dell’ermeneutica tra filologia, esegesi e allegoria
Secondo Roberto Pellerey, le teorie del segno e del linguaggio si erano occupate di definire l’interpretazione come attività capace di attribuire significati ai segni. Tuttavia, nel momento in cui il problema si sposta dal piano filosofico a quello metodologico — quello della pratica effettiva della lettura dei testi — si entra nel dominio specifico dell’ermeneutica. Questa pratica…
Rappresentazioni di genere ed enunciazione televisiva: il ruolo dell’esperto
Tra la metà degli anni Novanta e i primi anni Duemila, la RAI promuove una serie di ricerche sulle sue trasmissioni, coinvolgendo l’Istituto di Comunicazione del IULM per uno studio specifico sulla rappresentazione della donna nei programmi televisivi. I risultati di questo progetto confluiscono nella pubblicazione Una, nessuna … a quando centomila? La rappresentazione della donna…
L’effetto di realtà: dal dettaglio inutile all’illusione referenziale
Uno degli effetti testuali più celebri e discussi nella letteratura semiotica è quello cosiddetto di realtà, concettualizzato da Roland Barthes nel saggio L’effet de réel (1968). Isabella Pezzini ripercorre l’origine e le implicazioni di questo effetto, a partire da una critica alla nozione tradizionale di mimesi. Se già i formalisti e la narratologia avevano posto in secondo piano…
Gerarchie di forme e chiusure testuali
Nel momento in cui osserviamo un testo nella sua interezza, possiamo riconoscere al “punto di vista della fine” un valore particolare. Daniele Barbieri sottolinea che, una volta conclusa la fruizione, il testo viene interpretato sulla base delle strutture che è possibile individuare a partire dalla sua conclusione. Questo punto di vista consente interpretazioni più stabili…
Dominio, frame e spazio mentale: la schematizzazione nella teoria della metafora
Per comprendere la metafora come connessione tra due domini concettuali distinti, è necessario chiarire che cosa si intenda esattamente per dominio e come questo concetto si distingua da nozioni affini quali image schema, frame e spazio mentale, ampiamente utilizzate nella teoria della metafora concettuale. Volkhard Krech osserva come il termine “dominio” non venga usato in modo univoco. In senso generale,…
Teorie del segno e del linguaggio nell’antichità classica
La riflessione sull’interpretazione, già presente nella filosofia antica, si sviluppa lungo due direzioni parallele: da un lato la teoria del segno, dall’altro la teoria del linguaggio. Entrambe concorrono a costruire un quadro complesso in cui si articola il rapporto tra significati, segni e realtà. Nel primo caso, l’interpretare è visto come un ragionamento inferenziale che consente di…
Metafora e relazioni di senso: distinzioni semiotiche fondamentali
Volkhard Krech, nel chiarire il funzionamento della metafora all’interno della comunicazione religiosa, ne sottolinea la natura processuale e sistematica. La metafora non va intesa come un singolo segno isolato, ma come una connessione tra due domini concettuali distinti, in contrapposizione alle relazioni di senso che avvengono entro un singolo dominio. Secondo i criteri proposti da Lakoff e…
Soggettività, metafora e inferenza: verso una semiotica cognitiva ed estetica
Paolo Fabbri propone una convergenza tra due approcci a lungo ritenuti inconciliabili: da un lato la semiotica dell’inferenza e della cognizione, rappresentata da Peirce; dall’altro, la semiotica della narratività e della metaforicità, legata alla tradizione di Greimas. Il punto di contatto, sostiene Fabbri, è la teoria dell’enunciazione. Nella definizione peirciana, ogni segno rinvia a un altro…
Retorica, semiotica della cultura e ideologia
Anna Maria Lorusso imposta la sua riflessione sul rapporto tra retorica e semiotica collocando al centro la questione dell’ideologia come forma normalizzata del senso. In questa prospettiva, la retorica non è più solo un repertorio di figure o un arsenale di strumenti persuasivi, ma una pratica interpretativa che, attraverso la semiotica della cultura, porta alla…