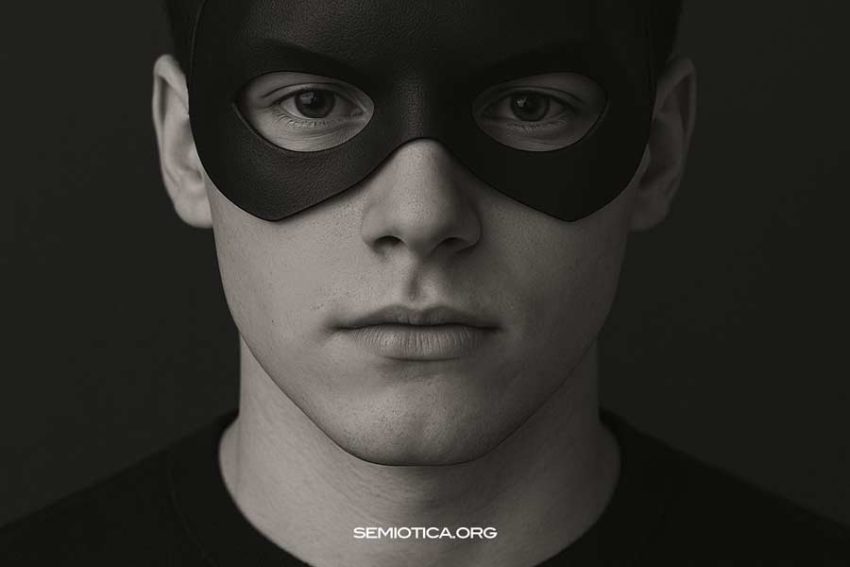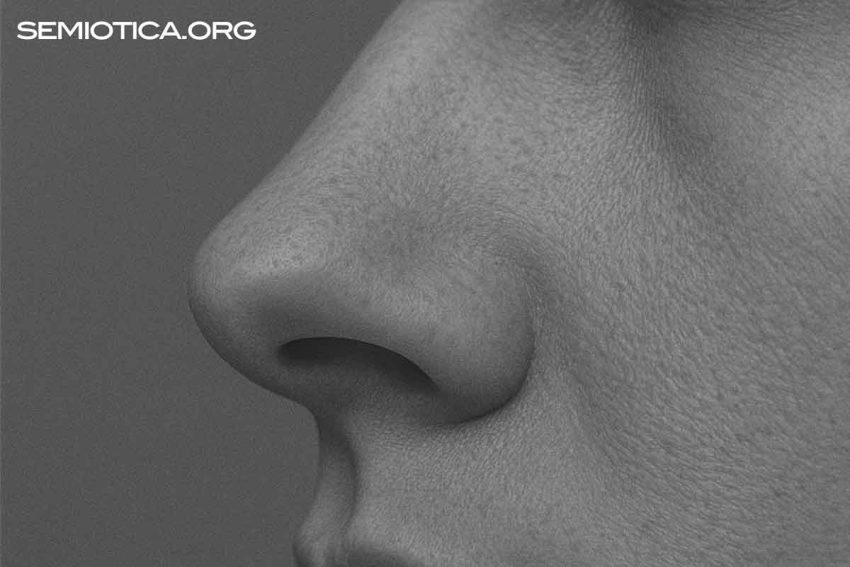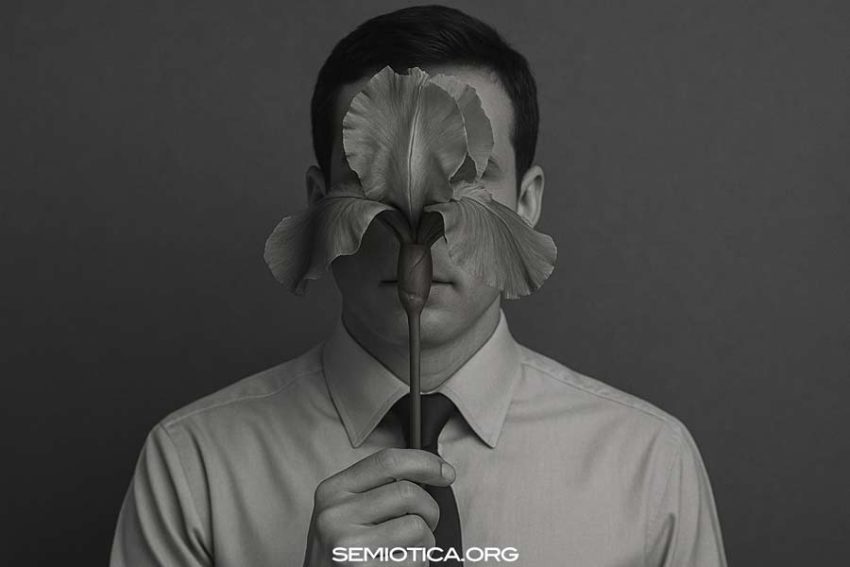Tra le intuizioni più originali contenute nel saggio di Paolo Fabbri del 1973*, Federico Montanari individua quella che Fabbri chiama “dispatching concettuale”. Il termine, derivato dalla cibernetica e dalle teorie dell’informazione, indica un’operazione di distribuzione, smistamento e connessione: un concetto che, a distanza di decenni, appare non solo attuale ma quasi profetico. Per Fabbri, la semiotica…
Tag: Paolo Fabbri
La semiotica come scienza della realtà
Gianfranco Marrone riflette sul debito che il pensiero di Bruno Latour intrattiene con la semiotica. Latour ha lavorato a stretto contatto con studiosi come Paolo Fabbri e Françoise Bastide, applicando modelli semiotici consolidati — in particolare quelli dell’enunciazione e della narratività — alla sociologia della scienza e all’etnografia della tecnica. Non si tratta soltanto di…
La svolta glossematica: segmentare il senso, articolare il significato
La svolta semiotica. Paolo Fabbri individua nella glossematica di Louis Hjelmslev una risorsa teorica decisiva per ripensare radicalmente il concetto di segno. Se la tradizione semiologica si era fondata su una concezione dualistica e arbitraria del segno saussuriano — rapporto tra significante e significato —, la glossematica introduce un’architettura completamente diversa. Per Hjelmslev, infatti, ogni…
Una teoria articolata: i quattro livelli della ricerca semiotica
Per affrontare in modo rigoroso il rapporto tra semiotica ed ecologia, Gianfranco Marrone propone di partire da un nodo teorico fondamentale: l’articolazione della ricerca semiotica su quattro livelli distinti ma interrelati. Il modello di riferimento è quello delineato da Algirdas Julien Greimas nella Sémantique structurale e successivamente sviluppato da Paolo Fabbri, in particolare ne Le tournant sémiotique (La svolta semiotica)….
I limiti del concetto di segno: una critica epistemologica
Paolo Fabbri mette in discussione uno degli assunti più radicati della semiotica tradizionale: l’idea che il segno sia un’unità omogenea e analizzabile in sé. Il concetto stesso di segno, osserva, rischia di trasformarsi in un ostacolo epistemologico. Secondo Fabbri, la nozione corrente di segno si fonda su una concezione lessicale del significato. Quando si parla…
Critica della content analysis: la sfida semiotica alla sociologia dei media
Nel suo saggio del 1973 (Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e malocchio della sociologia), Paolo Fabbri solleva una critica decisa verso i modelli di comunicazione dominanti nella sociologia dell’epoca, in particolare verso la content analysis, che egli definisce riduttiva e inadeguata a cogliere la complessità del testo. Come ricorda Federico Montanari, la posizione…
Dalla semiologia alla semiotica: rottura, dissoluzione e genealogie
Nel ricostruire la storia della semiotica come disciplina, Paolo Fabbri propone di cominciare da una svolta: quella che ha trasformato una riflessione antica sul segno in una disciplina autonoma dotata di una propria consistenza teorica. È solo a partire dagli anni Sessanta che si può davvero parlare di “semiotica” in senso moderno. Fabbri identifica due…
Semioticizzare la cultura: abiti, stereotipi e semiosfera
Nel confrontarsi con l’eredità del paradigma testuale, Claudio Paolucci sottopone a critica radicale l’idea secondo cui qualunque realtà culturale possa essere trattata come un testo. Questa estensione indiscriminata, osserva, ha condotto la semiotica cosiddetta “maggiore” a omogeneizzare oggetti radicalmente eterogenei, come romanzi, zuppe al pesto, città, strategie di mercato, pubblicità e miti, annullandone le differenze culturali…
Autoriflessività e testualità: percorsi epistemologici della semiotica
Federico Montanari insiste su un aspetto del pensiero di Paolo Fabbri che appare centrale per comprendere il ruolo epistemologico della semiotica nel rapporto con le altre scienze umane e sociali: la sua natura testuale e autoriflessiva. Già nel saggio del 1973 (Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e malocchio della sociologia), Fabbri affermava…
Sguardo semiotico e malocchio sociologico: una teoria dell’osservare secondo Paolo Fabbri
Nel saggio del 1973 intitolato Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e malocchio della sociologia, Paolo Fabbri propone un titolo provocatorio che ancora oggi – osserva Federico Montanari – risulta decisivo per ridefinire le relazioni fra la semiotica e le altre scienze umane e sociali. Il confronto implicito tra lo “sguardo” e il “malocchio”…