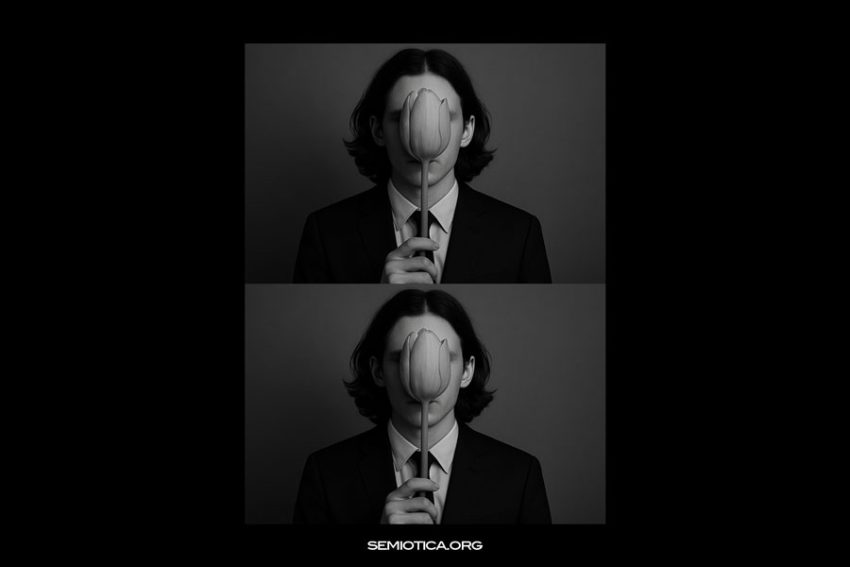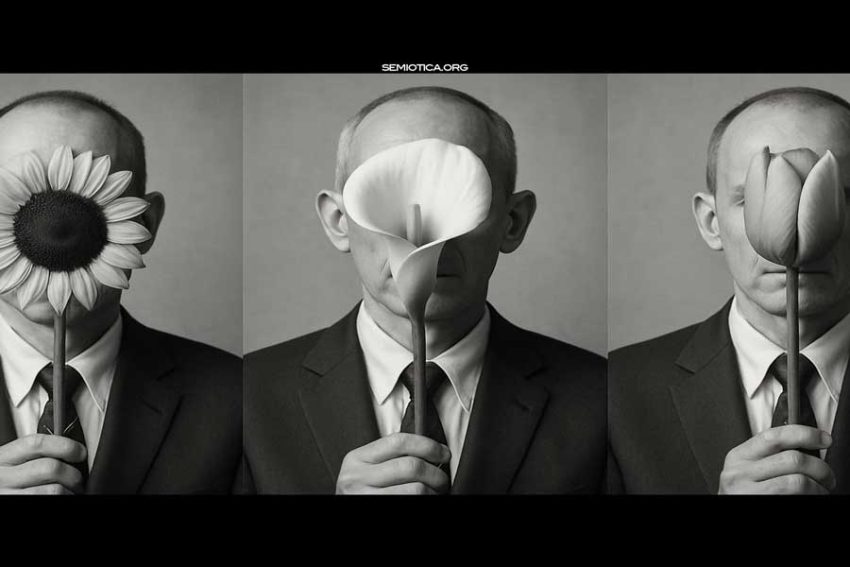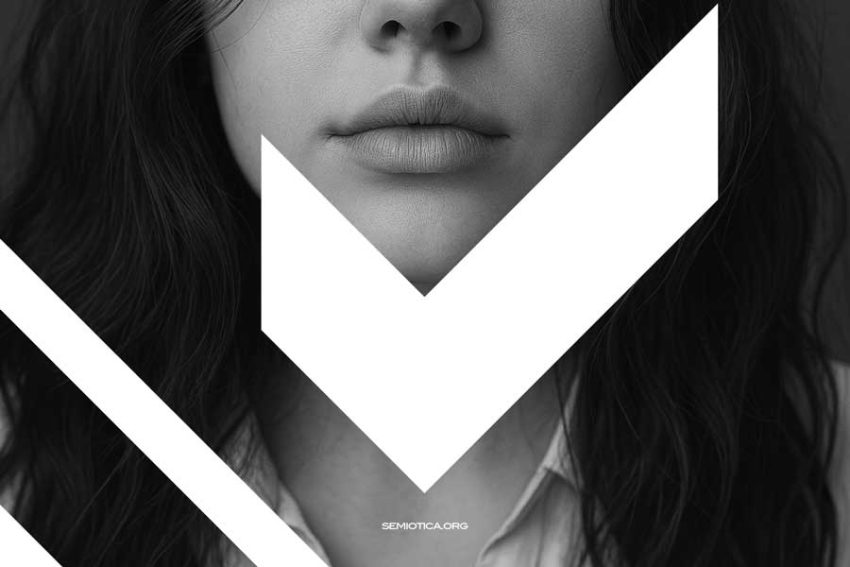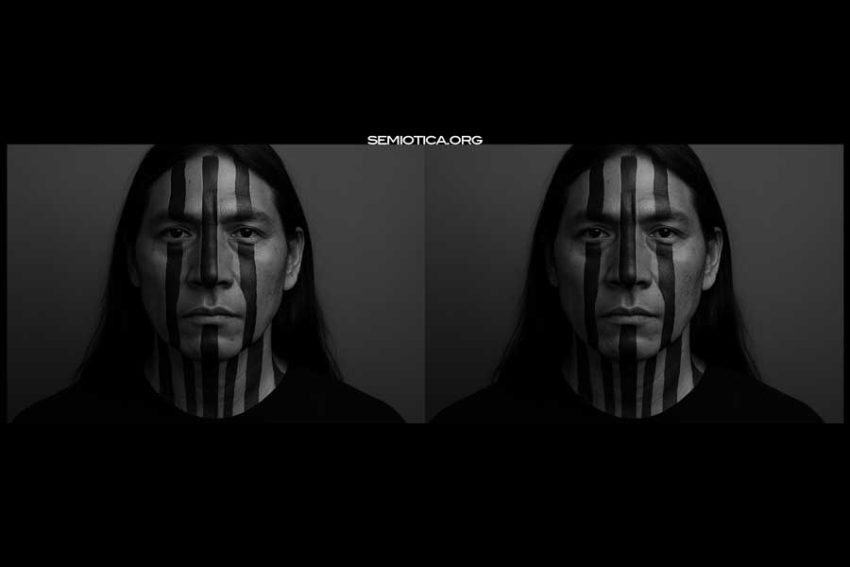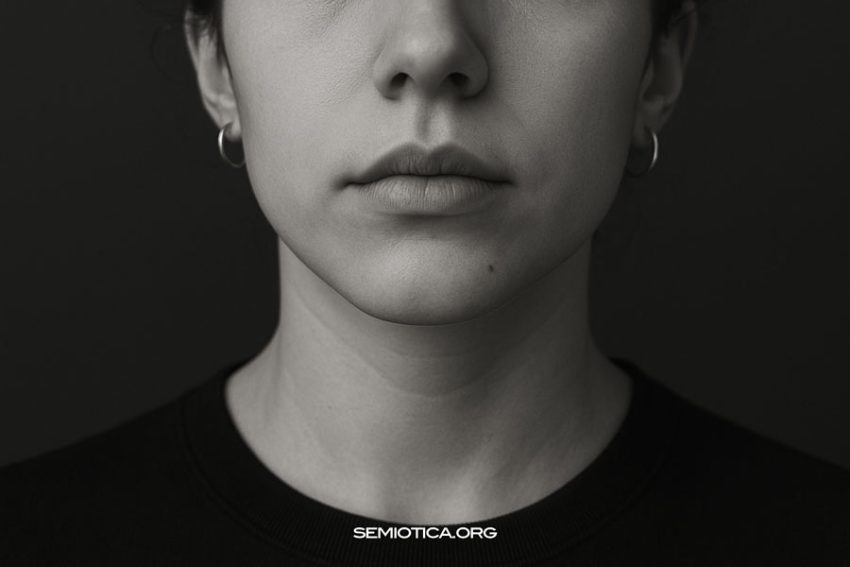Che cos’è la semiotica? È una domanda che non trova una sola risposta, perché, come osserva Stefano Traini, non emerge «un unico modo di concepire la semiotica, né una definizione univoca di questa disciplina». Che cos’è, allora, la semiotica? Per Greimas, è «essenzialmente una metodologia con cui analizzare i testi», una pratica di ricerca con una…
Tag: Jurij M. Lotman
Il conflitto come principio generativo della semiosi secondo Lotman
Il conflitto non è un incidente o una deviazione nel pensiero di Jurij Lotman, ma ne costituisce un principio strutturale. In un passaggio cruciale, il semiologo afferma che “quando tendenze opposte coincidono, non abbiamo a che fare con un’assenza di conflitto, ma con un particolare caso di conflitto”. È questa la chiave per comprendere quanto…
Esplosione e lenta trasformazione: Lotman sulla dinamica culturale
Lotman invita a pensare lo sviluppo culturale non solo come successione di fasi, ma anche come convivenza sincronica di ritmi diversi: in uno stesso sistema semiotico possono coesistere strati soggetti a scosse improvvise e strati che mutano per gradi. Esempi semplici lo mostrano bene — la moda può rivoluzionarsi in un anno, la struttura fonologica…
Sistema ed esplosione: le due chiavi di Lotman
Nella raccolta La cultura e l’esplosione Lotman riprende due problemi fondamentali per ogni sistema semiotico. Primo: il rapporto tra il sistema e ciò che gli sta fuori. Per Lotman la cultura è un insieme di lingue; il mondo extra-semiotico è extralinguistico e va trasformato in contenuto dalle lingue stesse. Perciò la traduzione è centrale: interpretare il reale…
Dal segno al discorso: verso una semiotica della traduzione
L’impostazione proposta da Jakobson, pur rappresentando un’apertura fondamentale verso la semiotica, rimane saldamente ancorata a una prospettiva linguistica. Nei tre tipi di traduzione da lui individuati — intra-linguistica, inter-linguistica e inter-semiotica — è sempre la lingua verbale a costituire il punto di partenza e il garante della traducibilità: ognuna delle tre traduzioni è traduzione di…
Enunciazione, interpretazione e l’eccedenza della testualità
Pierluigi Basso affronta una delle tensioni centrali nell’eredità del Trattato di semiotica generale: il rapporto tra enunciazione e interpretazione, spesso intesi in maniera oppositiva nella storia della disciplina, e la questione, ad essi collegata, della testualità come oggetto e come prodotto della semiotica. Nel dibattito semiotico, nota Basso, le categorie di enunciazione e interpretazione sono state talvolta contrapposte come alternative epistemologiche….
Il conflitto tra stili interpretativi: razionalità e mistero
Nelle culture fondate su testi sacri o fondativi, il contrasto tra stili interpretativi differenti rappresenta il cuore di questioni politiche fondamentali: chi ha diritto di interpretare i testi sacri, e quindi di esercitare un’autorità sulla comunità? Quali destinanti hanno il potere di sanzionare tali interpretazioni? Jenny Ponzo propone di immaginare tali culture come semiosfere (Lotman) con una struttura semplice: al centro…
Ideologia e falsificazione nell’epoca del digitale assoluto
Secondo Massimo Leone, una filosofia della comunicazione digitale ispirata alla semiotica deve interrogarsi sulle ideologie che accompagnano la nascita e la diffusione delle nuove tecnologie del senso. Anche l’intelligenza artificiale, benché presentata come strumento tecnico, è costruita su preconcetti culturali circa la natura dell’intelligenza, i suoi obiettivi e le sue modalità di espressione. In quanto…
La semiotica come teoria generale della cultura?
Nel rileggere il Trattato di semiotica generale, Stefano Traini si sofferma su uno dei nuclei più emblematici e al tempo stesso problematici dell’opera di Umberto Eco: la definizione di semiotica come “teoria generale della cultura”. Il titolo stesso dell’introduzione — Verso una logica della cultura — risulta, secondo Traini, particolarmente evocativo e ancora attuale. La proposta di Eco,…
Il confine dell’abito: semiotica dell’interpretazione e sospensione della regolarità
Claudio Paolucci sviluppa una densa riflessione sul concetto di interpretazione, interrogandosi sulla natura dell’abito culturale e sul punto preciso in cui può darsi un atto interpretativo. In questa prospettiva, l’interpretazione non è considerata come un semplice riconoscimento del senso, ma come un momento di crisi, di sospensione dell’automatismo, in cui l’abito non funziona più in modo trasparente….