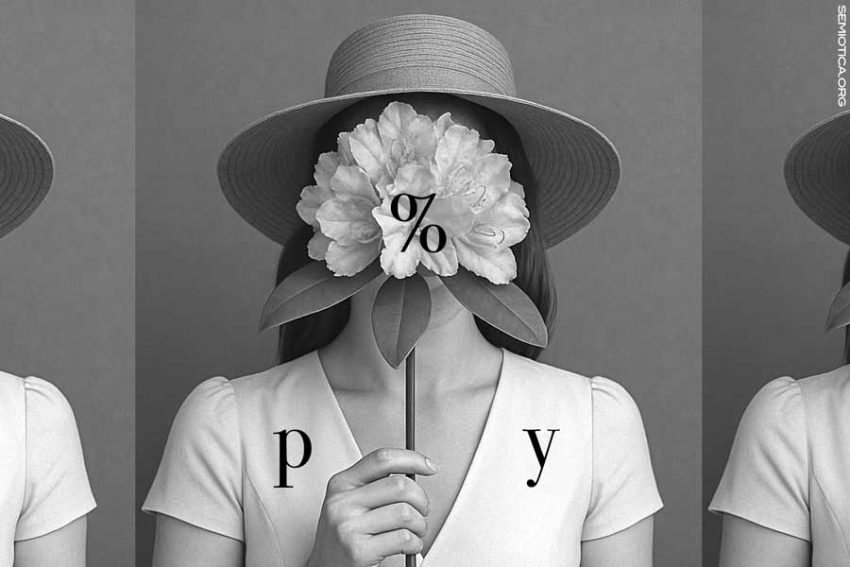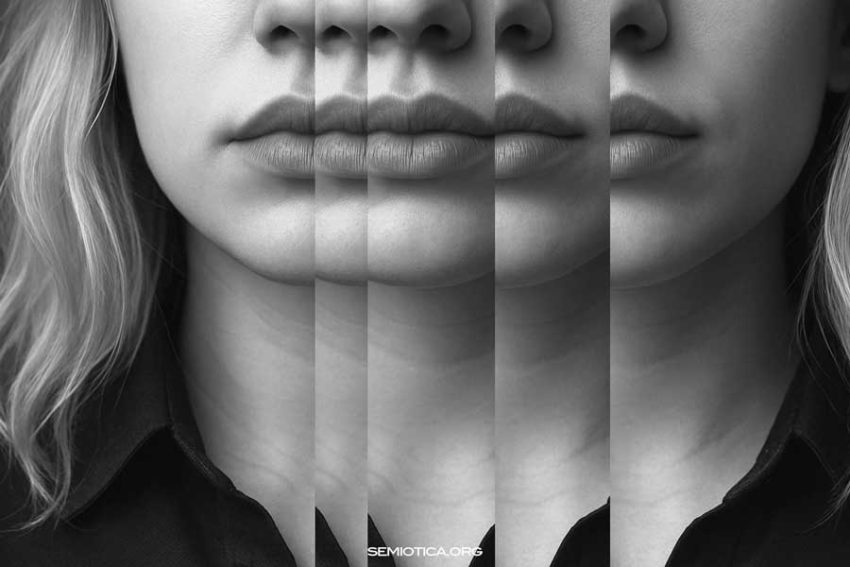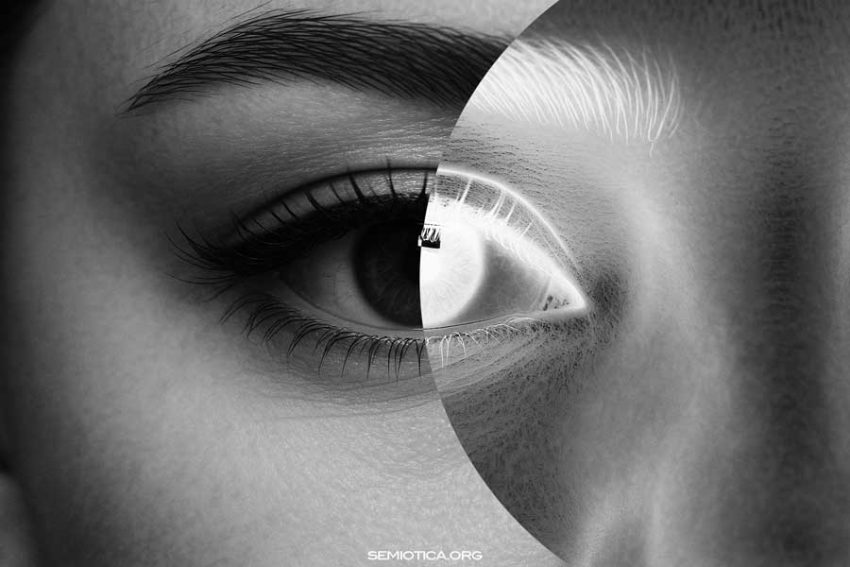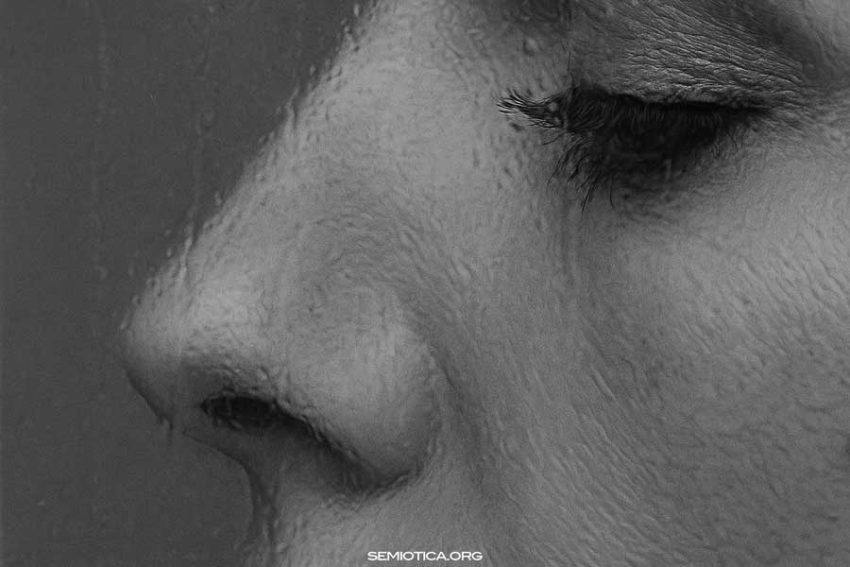Patrizia Violi affronta la questione delle pratiche come uno dei nodi centrali della ricerca semiotica contemporanea. L’attenzione per oggetti “più estesi del testo” implica una ridefinizione dei criteri con cui si costruisce l’oggetto d’analisi. In questo quadro, le pratiche non si presentano come entità immediatamente delimitate, ma come configurazioni che richiedono un lavoro di selezione…
Tag: Enunciazione
Il discorso cognitivo come racconto
Il discorso scientifico può essere considerato, in una prima approssimazione, come una forma di racconto. Non si tratta di una metafora ornamentale, ma di una ipotesi analitica che permette di descrivere il funzionamento del sapere in termini di trasformazione. Ogni discorso cognitivo mette in scena un passaggio: da uno stato iniziale di mancanza, definito come…
Benveniste. La polarità io/tu come condizione del linguaggio
La soggettività, per Émile Benveniste, non si costituisce in solitudine. Essa presuppone una relazione originaria che è interna al linguaggio stesso. «La coscienza di sé è possibile solo per contrasto»: l’io non può essere enunciato se non nel rivolgersi a un altro, che nell’allocuzione assume la forma del tu. Questa condizione dialogica non è un fatto…
L’enregisterment e la tipizzazione delle forme visive
Maria Giulia Dondero introduce il concetto di enregisterment per descrivere i processi attraverso cui le forme visive diventano riconoscibili, condivise e trasferibili. Il termine, proveniente dall’antropologia linguistica, viene messo in relazione con la teoria semiotica della prassi enunciativa per spiegare come gli stili visivi si costituiscano attraverso dinamiche di sedimentazione e tipizzazione. Nel testo, l’enregisterment viene inteso come un…
Enunciazione e passaggio alle strutture discorsive
Nella teoria greimasiana, l’organizzazione del senso non si esaurisce nelle strutture profonde o nelle dinamiche narrative. Un ruolo decisivo è svolto dall’enunciazione, l’istanza che consente alla semiotica di articolare la generazione del senso in una dimensione discorsiva. Patrizia Magli e Maria Pia Pozzato osservano che, nel percorso generativo, l’enunciazione interviene come un livello di mediazione…
La prassi enunciativa come metodo di analisi delle immagini
Maria Giulia Dondero propone di affrontare la questione degli stili visivi generati dall’intelligenza artificiale attraverso la teoria della prassi enunciativa, una nozione sviluppata all’interno della semiotica continentale e, più precisamente, nella tradizione della Scuola di Parigi. Questa teoria fornisce il quadro concettuale per comprendere come un’immagine non sia mai un semplice oggetto isolato, ma un risultato che…
L’imitazione come operazione iconico-performativa
Per Massimo Leone, l’imitazione non è un semplice riflesso del reale, ma una operazione semiotica autonoma, una modalità enunciativa derivata ma produttiva, capace di riconfigurare l’identità e di alterare il regime della singolarità. Lungi dal “copiare”, l’imitazione consiste nell’abitare il segno dell’altro, nel ripeterlo modificandolo, secondo una logica di scarto che trasforma la somiglianza in uno…
La rappresentatività dei discorsi e la costruzione del corpus scientifico
Lo studio semiotico del discorso scientifico si fonda su una scelta precisa dei testi da analizzare. Greimas e Landowski sottolineano che tale scelta non è mai neutra: la definizione del corpus deriva da criteri di rappresentatività e da considerazioni sullo statuto semiotico dei testi oggetto. Riunire ed esaminare un numero limitato di testi che rappresentino…
La testualizzazione come mediazione tra testo e pratica
Maria Giulia Dondero approfondisce concetto di testualizzazione come luogo di mediazione fra testo e pratica. Il problema di fondo consiste nel comprendere come la semiotica possa analizzare la dimensione effimera delle azioni e delle interazioni, senza perdere la solidità epistemologica garantita dal principio di immanenza. La testualizzazione risponde a questa esigenza: essa designa l’insieme dei dispositivi —…
Il testo come segno: voce, isotopia e unità estetica
Per Aage Brandt definisce il testo come un segno composto di frasi. Poiché ogni frase configura la propria enunciazione, la sequenza di frasi all’interno di un testo richiede un’integrazione delle rispettive istanze enunciative. Tale integrazione genera una enunciazione transfrastica, cioè una sorta di voce continua che sostiene il testo nel suo insieme e gli conferisce coerenza e identità. Questa…