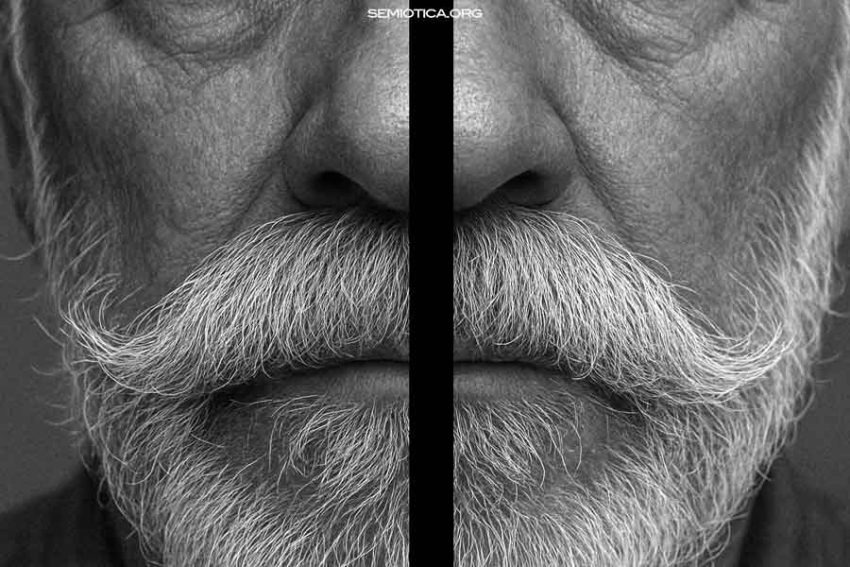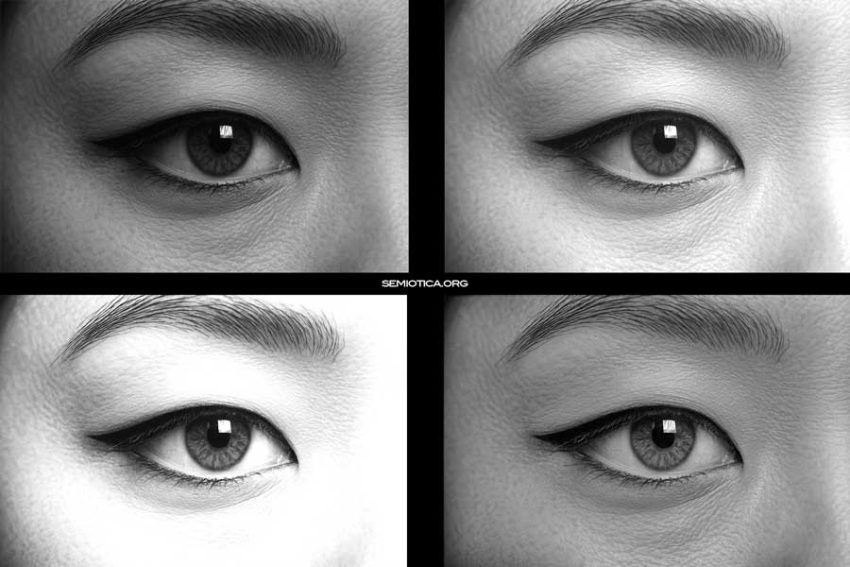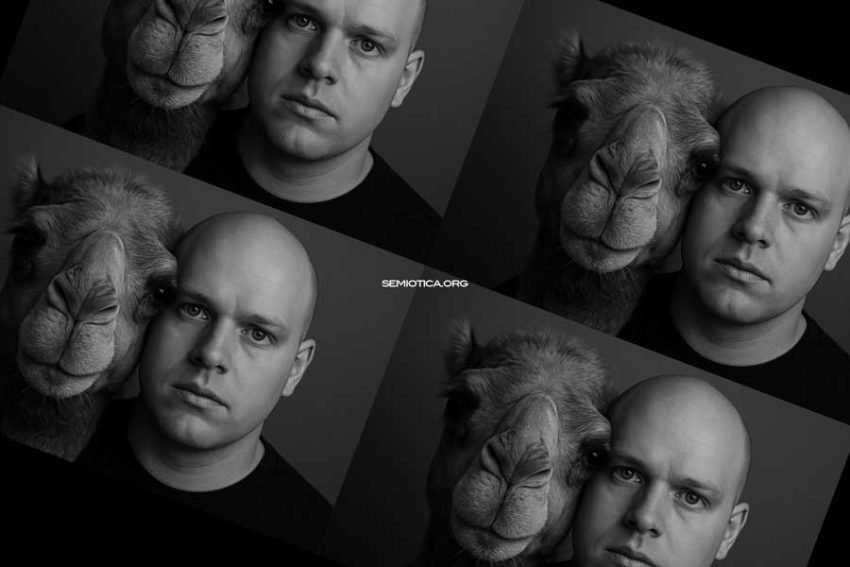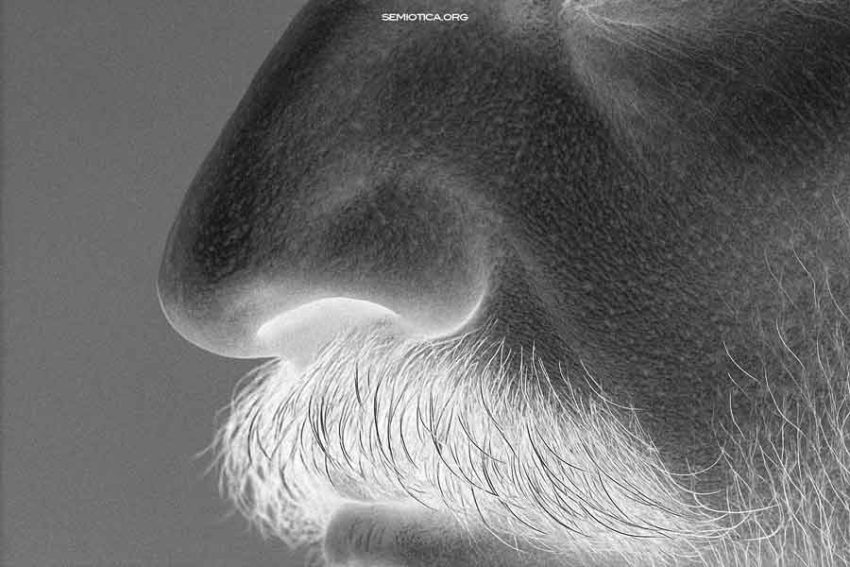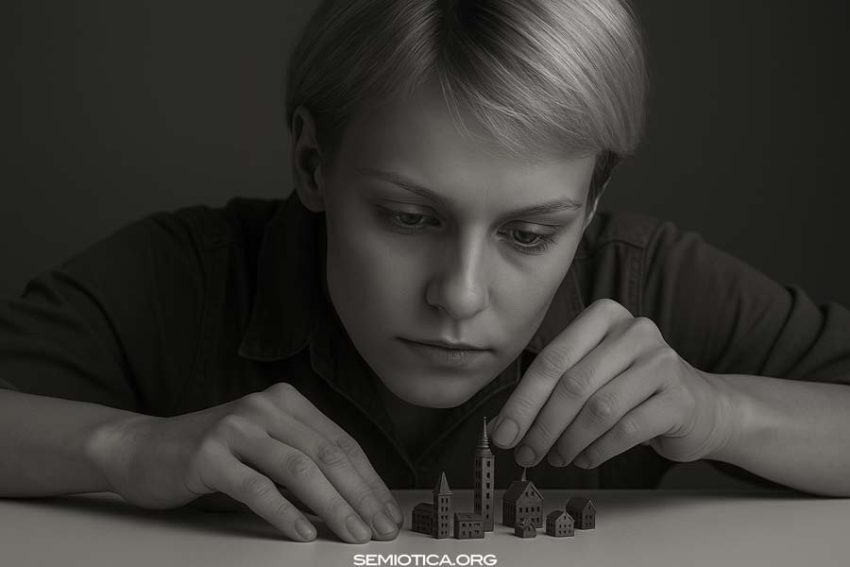La pubblicazione del Cours de linguistique générale avviene nel 1916, a Parigi, come opera postuma che raccoglie le lezioni tenute da Ferdinand de Saussure tra il 1907 e il 1911. Carlo Sini ricorda che il libro, nonostante la sua portata teorica, impiegò quarant’anni prima di essere riconosciuto come testo capitale. La svolta giunge intorno al 1956, quando…
Tag: Claude Lévi-Strauss
Vergogna e paura: una genealogia emozionale del politico secondo Lotman
Jurij Lotman affronta in modo esplicito il tema del conflitto politico nel saggio del 1970 intitolato La semiotica dei concetti di “vergogna” e “paura”. In questo testo, come osserva Franciscu Sedda, il semiologo sovrappone un ragionamento di tipo filogenetico a uno tipologico, tentando di delineare un modello ideale per l’emergenza e la strutturazione della dimensione politica…
Lo strutturalismo come autodescrizione culturale
L’incontro di Jurij Lotman con lo strutturalismo segnò, secondo Pietro Restaneo, una vera “rivoluzione” nella sua vita intellettuale. Fu il punto di svolta che ne determinò il metodo, l’oggetto di ricerca e, in definitiva, la costruzione della rete di studiosi che avrebbe dato vita alla Scuola di Tartu-Mosca. Ma comprendere in che modo lo strutturalismo…
La costruzione epistemologica della semiotica greimasiana
Patrizia Magli e Maria Pia Pozzato aprono la loro prefazione (La grammatica narrativa) a Del senso 2 di Greimas richiamando una domanda che lo studioso si era posto nell’“Introduzione” al primo volume di Del senso: come sia possibile “parlare del senso e dire su di esso qualcosa di sensato”. La risposta, osservano, si radica nel progetto di…
Mythologeme and Mytheme: Two Structural Units of Myth
The semiotic investigation of myth often returns to two key notions that attempt to capture its smallest meaningful components: the mythologeme and the mytheme. Both terms appeared in the first half of the twentieth century, each emerging from a different intellectual tradition. Their comparison reveals two distinct ways of thinking about the inner organization of myth — one…
The Semiotic Study of Myth in Mass Culture
Is myth still relevant to everyday life? Can we say that myth still lives among us, though perhaps in altered forms? Even in the twenty-first century it remains an enigma for researchers, a phenomenon that has been examined through the lenses of ethnography, literary theory, philosophy, psychology, religious studies, and anthropology. In the mid-twentieth century,…
Roman Jakobson, Semantica e senso: dall’interpretante alla semiosi
Come sottolinea Umberto Eco, la prospettiva di Roman Jakobson si fonda sull’idea che la semiotica non può limitarsi a studiare la struttura dei segni: deve includere necessariamente una riflessione sul significato e sulla costruzione del senso. Jakobson rifiuta con decisione l’idea che la linguistica possa prescindere dal problema del significato, restando confinata alla pura descrizione formale….
Umberto Eco su Jakobson. Trasferimenti metodologici e costruzione dei modelli semiotici
Nel delineare il contributo di Roman Jakobson alla fondazione della semiotica, Umberto Eco individua una delle sue principali forze nella capacità di operare trasferimenti interdisciplinari. La semiotica, come emerge dalle ricerche jakobsoniane, non nasce da un sistema concettuale chiuso, ma si costituisce attraverso l’innesto continuo di modelli, strumenti e metodi provenienti da altre scienze. Jakobson ha…
Alle origini dell’etnosemiotica: tra Saussure, Lévi-Strauss e Geertz
Il termine etnosemiotica circola da tempo all’interno del campo semiotico, anche se in modo piuttosto sommesso. Tarcisio Lancioni ne rintraccia le tracce teoriche iniziali in alcune domande poste da Greimas sullo statuto semiotico di una classe specifica di “oggetti”, definiti appunto “etnosemiotici”, cioè prodotti da culture “altre” rispetto alla nostra. Si tratta di interrogativi che toccano direttamente…
Il lessema come fascio di tratti semantici
Nel quadro teorico strutturalista, ogni personaggio, oggetto o figura rappresentata nel racconto è designato da un lessema. Esso è, sul piano del contenuto, ciò che il fonema rappresenta sul piano dell’espressione. Come sottolinea Patrizia Magli, il lessema è un «fascio di elementi differenziali», detti semi, che entrano in gioco quando viene inserito in un contesto discorsivo….