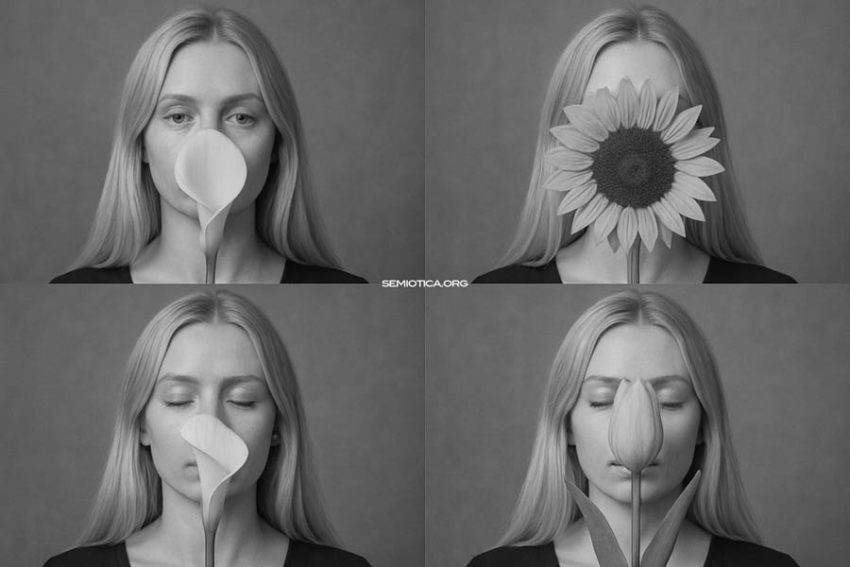Paolo Fabbri propone una ricostruzione della semiotica come disciplina a partire dagli anni Sessanta, indicandone due caratteristiche fondamentali, associate emblematicamente a Roland Barthes e a Umberto Eco. La prima, che Fabbri presenta attraverso il nome di Barthes, è una semiologia che ancora non si configura pienamente come semiotica, ma che opera come critica delle connotazioni ideologiche inscritte nella lingua.
Barthes parte dall’assunto che esistono diversi sistemi di segni all’interno di culture date, e che questi non vadano analizzati singolarmente ma in quanto regimi di significazione. La lingua, tra questi sistemi, si distingue perché possiede la facoltà di parlare anche degli altri segni. Secondo Fabbri, questo conferisce alla lingua naturale una posizione privilegiata e conduce Barthes a trattare la semiologia come “una sorta di trans-linguistica, ossia una linguistica capace di parlare, oltre che della lingua, di tutti i sistemi di segni”.
È in questa prospettiva che la semiologia viene pensata come disciplina critica, capace di smontare l’ideologia sociale stratificata nella lingua. Fabbri ricorda che Barthes, negli anni Cinquanta, fu un importante critico teatrale impegnato nella diffusione e difesa dell’opera di Brecht in Francia. Questa matrice brechtiana è decisiva per comprendere la sua idea di semiologia come strumento per “distruggere, dissipare, decostruire (…) quell’insieme di connotazioni culturali, sociali e ideologiche che la borghesia ha calato sulla lingua”.
Questa semiologia, osserva Fabbri, si è affermata anche grazie al clima teorico del cosiddetto linguistic turn, che portava il linguaggio al centro della riflessione filosofica e sociale. In tale contesto, la trans-linguistica appariva come un modo per evitare di considerare l’uomo come una realtà oggettivabile o isolata, privilegiando invece l’analisi dei modi in cui gli esseri umani comunicano e si rappresentano reciprocamente.
Il successo di questo approccio semiologico si spiega dunque anche con la continuità che instaura con la tradizione delle arti liberali, dove il linguaggio verbale occupa da sempre un ruolo centrale come espressione della civiltà. Tuttavia, è proprio questo legame a determinare, secondo Fabbri, il limite teorico della semiologia barthesiana: “ha raggiunto così il pieno successo solo nel momento in cui ha tradito il suo scopo precipuo e originario”.
In altri termini, se la semiotica viene ridotta a una forma di sapere già contenuto nella grammatica, nella retorica e nella filosofia, allora si dissolve nella tradizione umanistica che intendeva rinnovare. Il risultato è un sapere insieme fondato e rinnegato, “diffuso e dissolto”.
Fabbri individua nel recupero della retorica antica il caso più evidente di questa deriva. Il tentativo di riunire, in manuali come quelli di Lausberg e Perelman, figure retoriche provenienti da tradizioni e concezioni linguistiche eterogenee, produce secondo lui una “babele infelice”. Il riferimento a Fontanier e alla scomparsa delle figure di passione dalla dottrina retorica moderna serve a mostrare come la retorica, lungi dall’essere un apparato unitario e stabile, sia variata nel tempo in funzione delle concezioni teoriche del linguaggio.
Le neo-retoriche che si ispirano alla semiologia hanno finito così per costruire classificazioni teoricamente incoerenti, assemblando elementi incongrui, incomparabili, incommensurabili. È questo stile di confusione, osserva Fabbri, che ha contribuito alla dissoluzione del primo paradigma semiologico.
Riferimento bibliografico: Fabbri, P. (1998). La svolta semiotica. Italia: Laterza.