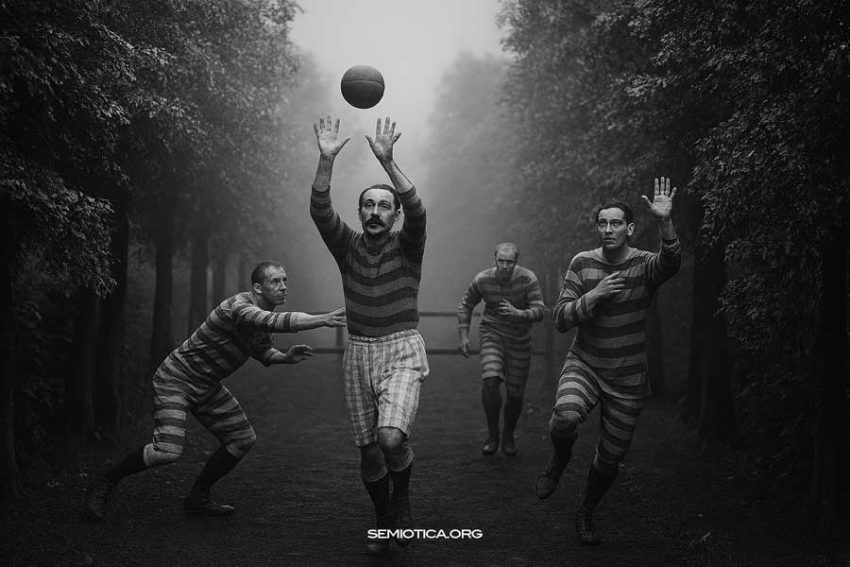Nella famosa lettera a Antoine Meillet del 1894, Ferdinand de Saussure esprime due convinzioni fondamentali: da un lato, l’urgenza di mostrare al linguista ciò che fa, riconducendo ogni operazione a una categoria prevista; dall’altro, la necessità di ridare senso a una terminologia priva di coerenza, poiché, a suo dire, “non c’è un solo termine usato in linguistica al quale io attribuisca un significato qualsiasi”.
Secondo Alessandro Zinna, queste due esigenze costituiscono il vero compito fondativo della linguistica moderna. La linguistica, come ogni scienza, per diventare realmente confrontabile e cumulabile, ha bisogno di due forme di omogeneità: terminologica e operativa. Non basta disporre di un metalinguaggio ben costruito; è necessario anche seguire procedure comuni, capaci di guidare l’analisi e garantire la comparabilità dei risultati.
Il solo controllo terminologico, osserva Zinna, è insufficiente. La costruzione di una teoria linguistica o semiotica non può limitarsi a fornire un insieme di definizioni coerenti: essa deve anche prescrivere una metodologia applicativa, fondata su un insieme ordinato di azioni o operazioni di descrizione. L’epistemologia auspicata da Saussure prevede infatti un doppio controllo: da un lato il senso dei termini impiegati nel metalinguaggio, dall’altro la riduzione delle azioni descrittive alle categorie previste.
È in questa direzione che Louis Hjelmslev svilupperà, a partire dagli anni ’40, una teoria linguistica che integra le operazioni nel metalinguaggio. La descrizione non si limita più a un esercizio terminologico, ma diventa una procedura, cioè un insieme regolato di azioni da compiere per applicare la teoria a un oggetto concreto.
Zinna illustra il caso esemplare della commutazione. Nella glossematica, la commutazione ha una doppia funzione: è allo stesso tempo proprietà dei sistemi semiotici e test operativo. Come proprietà, indica la correlazione tra i membri di un paradigma. Come test, consiste nella sostituzione controllata di due membri per verificare tale correlazione. Questa procedura consente di stabilire le invarianti non solo sul piano dell’espressione (come nella fonologia), ma anche su quello del contenuto. In tal modo, il “fare del linguista”, anziché affidarsi a intuizioni soggettive, si regola attraverso una metodologia condivisa che garantisce risultati riproducibili.
Tuttavia, l’impostazione hjelmsleviana presenta anche dei limiti. Anzitutto, tende a considerare l’oggetto d’analisi come un linguaggio piuttosto che come un discorso. Ciò comporta una tipologia fissa di metalinguaggi e una scarsa attenzione alla dimensione storica e trasformativa delle pratiche semiotiche. Le tipologie proposte — come quelle basate su strutture mono/biplanari, scientifiche/non scientifiche, omosemiotiche/eterosemiotiche — risultano poco operative per la varietà degli oggetti contemporanei.
Per questo, osserva Zinna, non basta ragionare per tipologie strutturali, ma occorre riconoscere che ogni applicazione convoca un metasistema semiotico in funzione della fase storica della disciplina. L’evoluzione della semiotica ha moltiplicato i propri campi d’indagine: dalla semiotica dei testi alla semiotica degli oggetti, dell’immagine scientifica, dell’interfaccia. Questo ampliamento progressivo ha richiesto nuove categorie analitiche, e con esse un progressivo arricchimento del metalinguaggio stesso.
Applicare una teoria non significa semplicemente applicare un modello già pronto, ma confrontarsi con oggetti che sollecitano aggiustamenti, adattamenti e persino riformulazioni teoriche. Per questo motivo, ogni descrizione operativa implica una selezione all’interno di un repertorio più ampio di categorie, e ogni applicazione può essere letta come un metaprocesso: una trasformazione del metalinguaggio stesso nella sua attuazione concreta.
Riferimento bibliografico: Alessandro Zinna, « L’épistémologie de Hjelmslev : Entre métalangage et opérations », Signata [En ligne], 4 | 2013, mis en ligne le 30 septembre 2016.