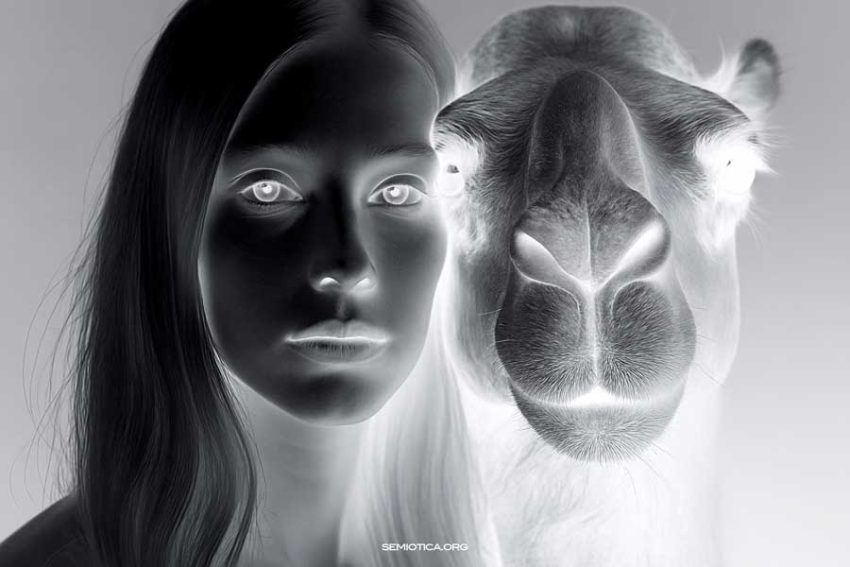L’interesse della grammatica narrativa di Greimas consiste, osserva Paul Ricœur, nel “comporre passo dopo passo le condizioni della narratività a partire da un modello logico il meno complesso possibile e che non comporta, inizialmente, alcun carattere cronologico”.
La questione decisiva è stabilire se le successive aggiunte introdotte per avvicinarsi ai racconti effettivamente prodotti — orali o scritti — traggano la loro capacità propriamente narrativa dal modello di partenza o da presupposizioni estrinseche.
Greimas scommette sul mantenimento dell’equivalenza tra modello iniziale e matrice terminale, e Ricœur dichiara di voler mettere alla prova questa scommessa “sul piano teorico, seguendo l’autore passo dopo passo nella costituzione del suo modello terminale”.
L’intero problema, precisa Ricœur, può essere articolato su più livelli, corrispondenti ai successivi gradi di narrativizzazione che Greimas individua nel suo saggio Elementi per una grammatica narrativa.
Ricœur distingue quattro piani, che costituiscono altrettante tappe della costruzione:
- la narrativizzazione all’interno della grammatica fondamentale, dove compare per la prima volta la nozione stessa di narrativizzazione;
- il passaggio dalla grammatica fondamentale alla grammatica narrativa di superficie, con l’introduzione del “fare”, del “voler-fare” e del “poter-fare”, su cui si costruisce l’enunciato narrativo;
- lo sviluppo della grammatica di superficie, segnato dall’inserimento di un fattore polemico che definisce la performanza come unità narrativa esemplare;
- infine, la rappresentazione topologica della narratività, in cui la struttura dello scambio consente di descrivere il trasferimento di valori da un luogo all’altro all’interno delle “sequenze performanziali”.
La questione centrale è se, attraverso queste trasformazioni, “l’equivalenza al modello iniziale venga mantenuta”, ossia se i successivi gradi di narrativizzazione non facciano che dispiegare la forza logica originaria, rendendola manifesta nella sua struttura profonda.
Ricœur riconosce che il percorso greimasiano si presenta come un “lavoro di mediazione” e invita a seguirne il progresso “prima ancora di valutarne la pertinenza”. L’obiettivo è comprendere se, in ciascun passaggio, la narratività resti ancorata alla potenza logica della struttura elementare, o se invece richieda l’introduzione di componenti estranee di ordine antropomorfo o pragmatico.
L’autore sottolinea così la minuzia e il rigore delle distinzioni greimasiane, destinate a colmare lo scarto tra le “istanze fondamentali ab quo” e le “istanze ultime ad quem”, cioè tra il piano delle prime articolazioni del senso e quello della sua manifestazione nei linguaggi.
In questo spazio di mediazione si colloca la grammatica narrativa, che per Ricœur rappresenta “una sorta di grammatica generale e fondamentale a un tempo, suscettibile di presiedere all’instaurazione dei discorsi articolati”.
Il compito della teoria greimasiana è dunque quello di garantire che le condizioni logiche della significazione restino valide anche quando il modello si arricchisce di componenti sintattiche e figurative: un’impresa che Ricœur definisce insieme come un atto di rigore deduttivo e come un lavoro di traduzione tra livelli differenti del senso.
È qui che si gioca, nel giudizio di Ricœur, la “scommessa” fondamentale di Greimas: la possibilità di mantenere un’equivalenza tra logica e narratività, tra struttura e racconto, tra profondità semiotica e manifestazione discorsiva.
Riferimento bibliografico: Paul Ricœur, La grammatica narrativa di Greimas