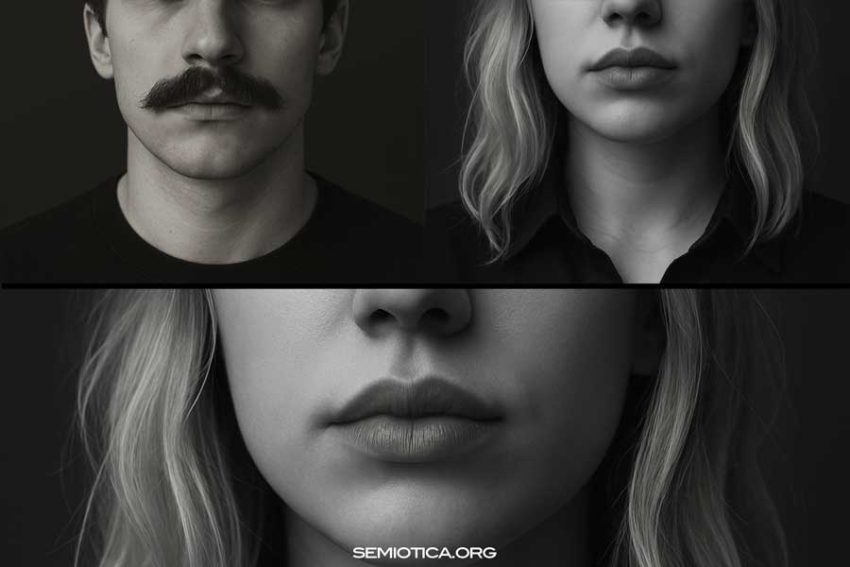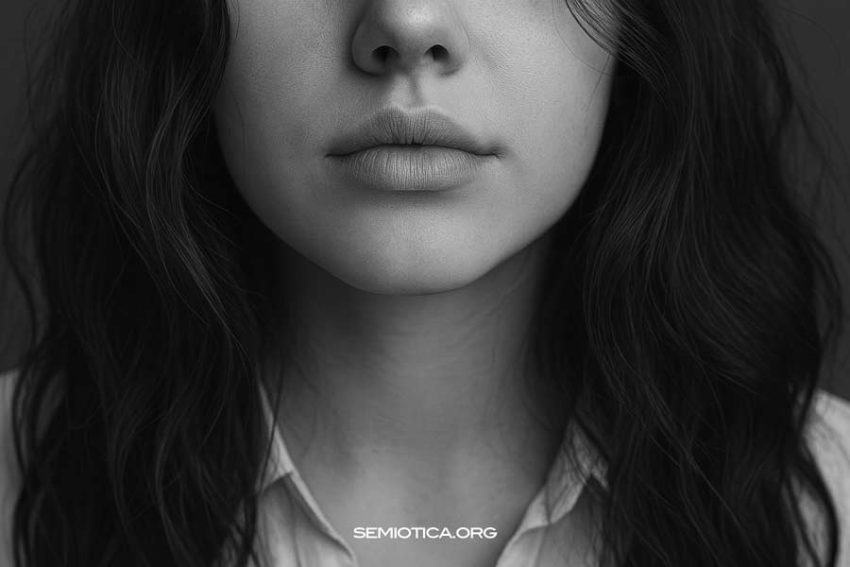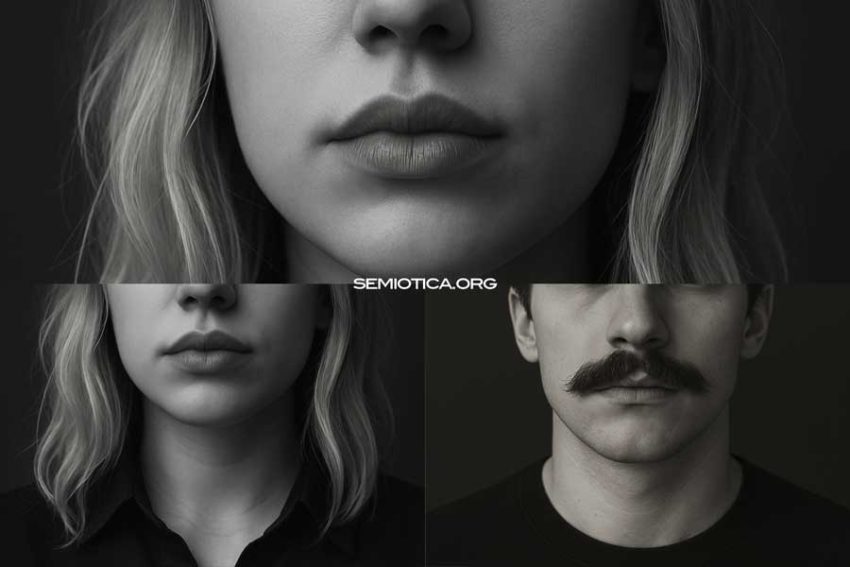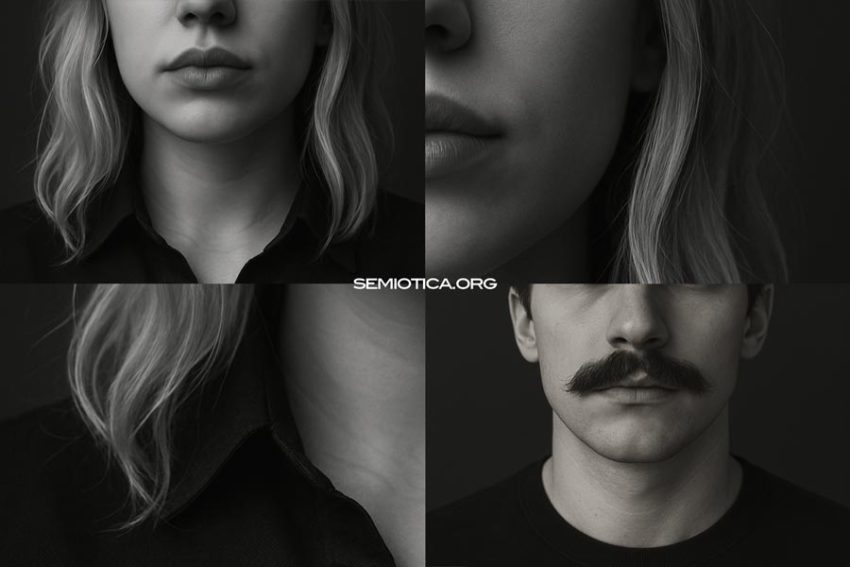Umberto Eco individua due radici distinte della semiotica: una linguistica, che si riconduce alla semiologia saussuriana, e una filosofica, che affonda nella riflessione di Peirce. In questo senso, «la semiologia di Saussure ha origini linguistiche, ma la semiotica di Peirce ha origini filosofiche». La convivenza tra queste due eredità è tuttora alla base della complessità disciplinare della…
Il labirinto e l’enciclopedia regolativa
Tra le figure teoriche capaci di rappresentare la complessità e la dinamica del sapere, il labirinto si configura come una delle più efficaci. L’immagine è ripresa e sviluppata anche da Umberto Eco, in riferimento alla teoria delle strutture acentriche formulata da Rosenstiehl e Petitot. Si tratta di una struttura priva di centro e di punti di vista…
La semiotica come teoria generale della cultura?
Nel rileggere il Trattato di semiotica generale, Stefano Traini si sofferma su uno dei nuclei più emblematici e al tempo stesso problematici dell’opera di Umberto Eco: la definizione di semiotica come “teoria generale della cultura”. Il titolo stesso dell’introduzione — Verso una logica della cultura — risulta, secondo Traini, particolarmente evocativo e ancora attuale. La proposta di Eco,…
Parafrasi e metalinguaggio: due funzioni distinte del linguaggio che parla di sé
Roman Jakobson ha individuato nella funzione metalinguistica una proprietà fondamentale delle lingue naturali, affermando che la condizione per avere un linguaggio è che esso possa parlare di sé. Due manifestazioni evidenti di questa funzione sono la parafrasi e il metalinguaggio, ma rimane da chiarire in che modo questi due strumenti linguistici riflettano effettivamente “sul linguaggio stesso”. Jakobson definisce…
Umberto Eco. Le origini e la necessità storica della semiotica
Alla domanda sull’origine della semiotica, Umberto Eco risponde che il suo sforzo è sempre stato quello di mostrarne l’antichità. «La semiotica nasce in Grecia», afferma, e indica come testo fondativo il De Interpretatione di Aristotele. Anche se il termine non esisteva ancora in senso moderno, la riflessione sul segno si trovava già negli Stoici, in Galeno, e nella semiotica di…
La svolta glossematica: segmentare il senso, articolare il significato
La svolta semiotica. Paolo Fabbri individua nella glossematica di Louis Hjelmslev una risorsa teorica decisiva per ripensare radicalmente il concetto di segno. Se la tradizione semiologica si era fondata su una concezione dualistica e arbitraria del segno saussuriano — rapporto tra significante e significato —, la glossematica introduce un’architettura completamente diversa. Per Hjelmslev, infatti, ogni…
La pertinenza e l’oggetto: incommensurabilità delle metodologie analitiche
La questione del metodo non riguarda soltanto l’efficacia dell’approccio prescelto, ma investe direttamente la costruzione stessa dell’oggetto analitico. Michela Deni afferma di avere sempre immaginato, fin dall’inizio delle sue ricerche, che un cambiamento di prospettiva fosse possibile: non tanto per le caratteristiche dell’oggetto in sé, quanto in funzione della pertinenza adottata e degli obiettivi da…
La semiotica come fabbrica del senso
Claudio Paolucci propone una riformulazione epistemologica della semiotica, contrapponendo due immagini forti: Cinecittà e Atene. Non si tratta, scrive, di rappresentare il senso come se fosse già dato, ma di occuparsi delle condizioni in cui esso si produce. Cinecittà è il luogo in cui si fabbricano mondi. È lì che la semiotica deve stare: non nella città della contemplazione,…
La metasemiotica come fondamento scientifico?
Francesco Galofaro introduce la sua indagine epistemologica proponendo una ricostruzione alternativa della storia della semiotica, intesa non tanto come successione cronologica di teorie, quanto come esplorazione delle vie non percorse. Tra queste, occupa un posto centrale la nozione di metasemiotica, introdotta da Louis Hjelmslev, che Galofaro propone di rileggere in chiave critica. Il termine “meta-” entra…
Eco, Peirce e lo strutturalismo: un caso di bisociazione creativa
Valentina Pisanty propone un’interpretazione originale del Trattato di semiotica generale, leggendo la sua architettura teorica non come un semplice innesto, bensì come un caso esemplare di “dissociazione creativa”. Il riferimento esplicito è ad Arthur Koestler, che nel saggio The Act of Creation descrive il meccanismo cognitivo alla base dei processi creativi — dall’umorismo alla scienza — come un…