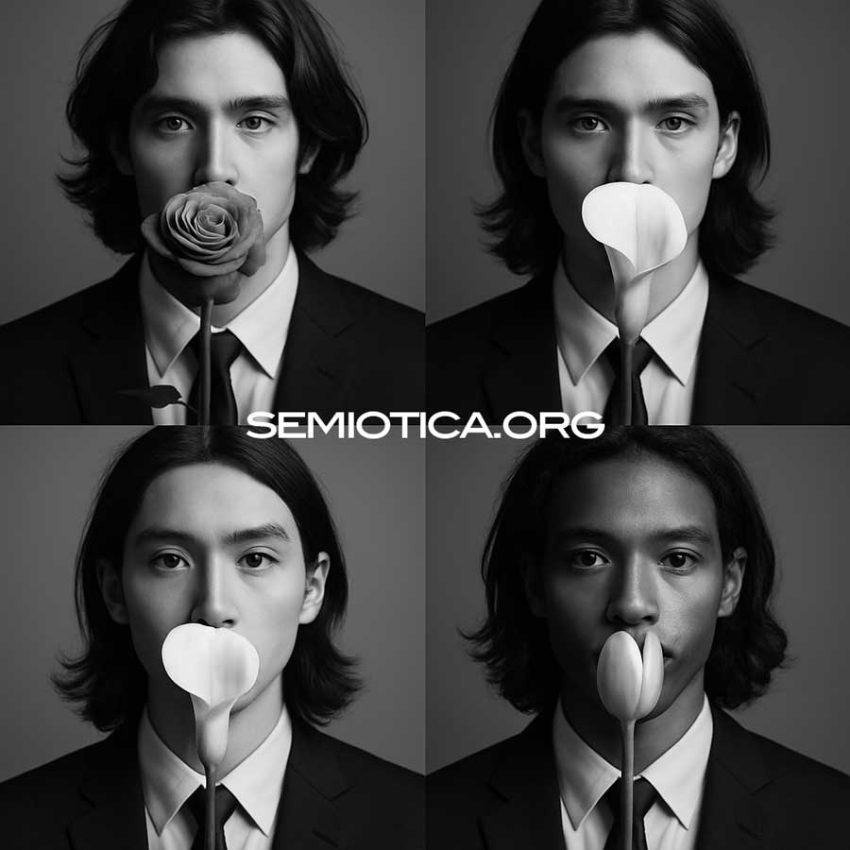Nel 1957 Roland Barthes pubblica Mythologies, una raccolta di interventi comparsi nella seconda metà degli anni Cinquanta, incentrati sull’analisi della società di massa. Al fondo del libro si trova un saggio teorico che offre una chiave di lettura semiologica dei materiali affrontati. Barthes spiega nella Premessa che a guidarlo era “un senso di insofferenza davanti alla ‘naturalità’ di cui incessantemente la stampa, l’arte, il senso comune, rivestono una realtà che per essere quella che viviamo non è meno perfettamente storica”.
La sua è una battaglia teorica contro la confusione fra Natura e Storia: ciò che è storicamente prodotto viene fatto passare come ovvio, necessario, naturale. Barthes intende smascherare questo meccanismo ideologico, rivelando che quelle che chiama “mitologie” non sono altro che “la maschera culturale della borghesia”, la quale tenta di legittimare le sue rappresentazioni rendendole invisibili.
I matrimoni come naturalizzazione dell’istituzione
Uno degli esempi più significativi riguarda i matrimoni. Barthes osserva come la stampa illustrata metta in scena, nei matrimoni aristocratici e borghesi, l’unione fra famiglie e patrimoni. Ma analizza anche un caso anomalo: il matrimonio tra Sylviane Carpentier, Miss Europa 1953, e un elettricista suo amico d’infanzia. In questo caso, la stampa costruisce il mito della “capanna felice”, in cui la Miss, rinunciando alla gloria, si ritira nel focolare domestico, allineandosi al destino della maggioranza dei cittadini. In entrambi i casi, l’effetto è sempre lo stesso: il matrimonio appare come esito “naturale” dell’accoppiamento, e non come istituzione storicamente situata.
Giocattoli e socializzazione all’età adulta
Un altro esempio toccante riguarda i giocattoli. Barthes scrive che “sono tutti riproduzioni in formato ridotto di oggetti umani, come se agli occhi del pubblico il bambino non fosse in fondo che un uomo più piccolo”. I giocattoli non stimolano la creatività, ma formano bambini-utenti, già avviati alle funzioni sociali adulte: eserciti, uffici postali, radio, ospedali. È un mondo adulto in miniatura che prepara all’assunzione passiva dei ruoli, come se la natura avesse previsto tutto ciò.
L’inondazione del 1955 e la drammatizzazione dell’evento
Barthes analizza la copertura mediatica dell’inondazione del gennaio 1955. Le immagini pubblicate non evocano paura, ma piuttosto una sorta di festa: “le fotografie […] danno disorientamento e stordimento ma non sono minacciose”. Si costruisce una narrazione di solidarietà, dove barche scorrono nelle strade e le persone si aiutano. L’evento catastrofico si trasforma in occasione di unione e pathos condiviso.
Le fotografie-choc: una retorica dell’orrore
Nella mostra alla galleria d’Orsay, Barthes osserva come le fotografie-choc, “supercostruite” dal fotografo, perdano ogni effetto. Un esempio: l’accostamento di soldati e teschi, o di un militare e uno scheletro. L’intervento eccessivo dell’autore impedisce al pubblico di esercitare il proprio giudizio: l’orrore vero – sostiene Barthes – nasce quando “guardiamo dall’interno della nostra libertà”.
La grande famiglia degli uomini e l’universalismo falsato
Un altro bersaglio critico è la mostra La Grande Famiglia degli Uomini, che propone l’universalità di nascita, giochi, lavoro, morte. Ma Barthes avverte: “perché questi fatti naturali accedano a un linguaggio veritiero occorre inserirli in un ordine del sapere”. Isolati dal loro contesto storico-culturale, perdono significato: ciò che conta è come ogni cultura vive e rappresenta quegli eventi.
In tutti questi esempi – nota Traini – ricorre un meccanismo fondamentale: “la storicità di certi fenomeni viene fatta passare come naturale”. In altri termini, la società borghese trasforma le proprie norme in “leggi evidenti di un ordine naturale”, facendole apparire come eterne e indiscutibili.
Riferimento Bibliografico:
Stefano Traini. Le due vie della semiotica: Teorie strutturali e interpretative (Strumenti Bompiani)