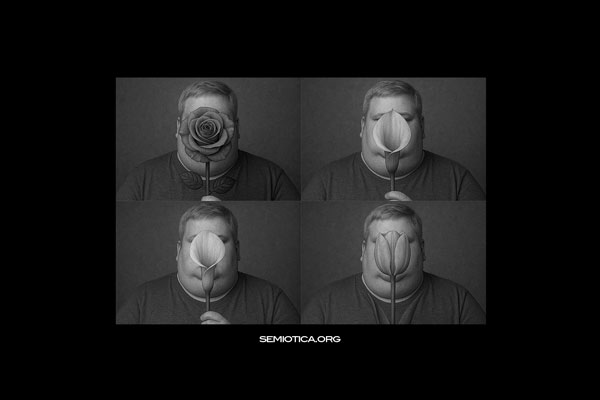Una delle tesi centrali del pragmaticismo consiste nella trasformazione semiotica del concetto moderno di conoscenza. In opposizione alla concezione nominalista della scuola inglese, che vedeva la conoscenza come medium quod – ovvero come mediazione dei segni rispetto agli effetti delle cose sulla coscienza – il pragmaticismo introduce la nozione di medium quo: il consenso intersoggettivo è la mediazione costitutiva dell’oggetto conosciuto. In questa prospettiva, i fatti non sono semplicemente dati immediati della percezione, ma vengono configurati semioticamente attraverso formulazioni iconiche e simboliche condivise.
La conoscenza risulta allora essere il prodotto di un processo di semiosi, all’interno del quale i segni sono articolati in proposizioni interpretative. In particolare, i segni ipotetici – concezioni di qualcosa come qualcosa – trovano una loro unità in una proposizione che, pur riferendosi a un fatto esterno, lo organizza attraverso un predicato simbolico.
Da ciò consegue un primo elemento chiave: la conoscenza scientifica è ipotetica e fallibile. Essa si sviluppa come un processo dinamico, sempre trasformabile, e fondato sulla possibilità di immaginare mondi alternativi rispetto a quanto osservato finora. È in questa cornice che il condizionale contrafattuale diventa, nel pragmaticismo, la forma logica più adatta a descrivere il funzionamento delle leggi scientifiche.
In logica, un condizionale contrafattuale esprime uno stato di cose non attuale. La struttura è quella del tipo: Se X fosse stato vero, allora Y sarebbe stato vero. Come spiegano Jasso e Nagel, la particolarità di questo costrutto è che l’antecedente (X) può essere falso, ma ciò non implica né la falsità del conseguente (Y), né della relazione condizionale nel suo complesso. È proprio nella speculazione su questi mondi alternativi che si radica il valore filosofico del contrafattuale.
Secondo Peirce, i concetti intellettuali funzionano come interpretanti logici, capaci di definire relazioni in termini di possibilità: would be, may be. Tali concetti giustificano la loro validità come possibilità regolata da condizioni e regole specifiche. In altri termini, un concetto è valido se, sotto certe condizioni, determina un’azione prevedibile.
Applicando questa logica ai concetti scientifici, le teorie e le leggi diventano dispositivi che configurano aspettative, abitudini, credenze operative. La loro funzione non è quella di descrivere eventi effettivi, ma di prescrivere comportamenti possibili. La legge scientifica, dunque, non afferma un evento osservato, ma organizza una regola di condotta che vale sotto certe condizioni operative.
In questa prospettiva, la legge non ha come obiettivo la verifica empirica, ma l’orientamento dell’interpretazione. L’enunciato scientifico diventa così una forma di pensiero in quanto azione possibile sul mondo. È in questo senso che Peirce definisce l’interpretante finale come ciò che ogni mente adotterebbe sotto determinate condizioni: una norma generalizzata che produce abitudini interpretative.
La legge scientifica stabilisce, in tal modo, un abito di condotta basato su esperienze pregresse. Essa non si limita a descrivere il reale, ma proietta una credenza pratica rispetto a un mondo possibile. È una prescrizione condizionale, fondata sulla plausibilità e sulla coerenza con lo stato attuale delle conoscenze.
Ciò che ne risulta è una concezione della scienza come costruzione regolativa del senso, in cui le teorie non pretendono di dire come stanno le cose, ma cosa potrebbe avvenire se certe condizioni fossero soddisfatte. Questo orientamento apre lo spazio per una lettura semiotica della legge: la legge è un segno che dirige l’interpretazione, e non un rispecchiamento del mondo.
Riferimento bibliografico: Julio Horta, “Pragmaticismo y Ley científica”, in deSignis, n. 43, 2025.