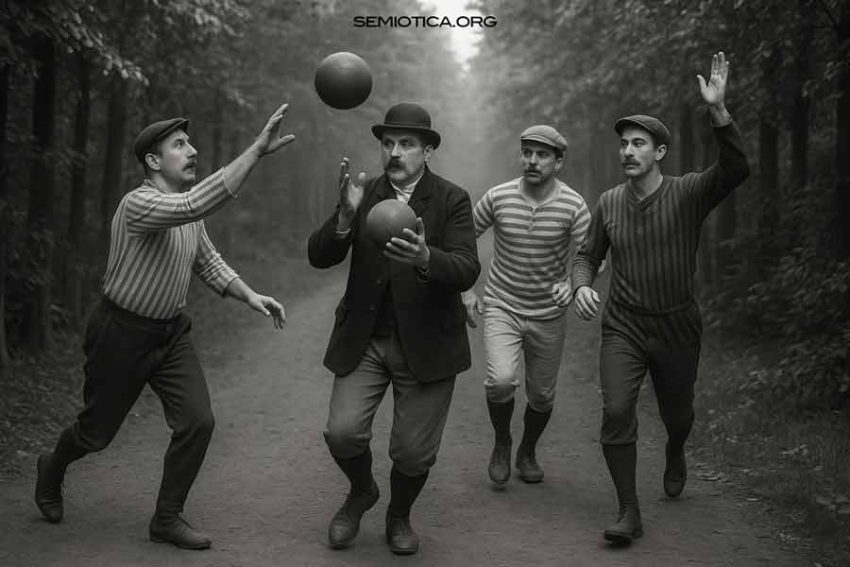Lorenzo Cigana sottolinea come, nella riflessione teorica di Hjelmslev, la formulazione del concetto di linguaggi di gradi diversi si collochi nel periodo di straordinaria produttività che vide la stesura del Résumé, delle Forelæsninger over Sprogteori e della comunicazione per il decennale del Circolo Linguistico di Copenaghen.
In tutti questi testi ritorna un punto centrale: il compito di una teoria è quello di fornire una procedura per mezzo della quale oggetti di una data natura possano essere descritti, in modo non generico ma specifico, cioè privo di contraddizioni e esaustivo. Questo principio si applica alla teoria linguistica in quanto scienza particolare, e viene espresso in modo coerente sia nel Résumé (Reg. 87), sia nelle Forelæsninger, sia nella comunicazione del 1943.
Hjelmslev scrive che una tale teoria deve trattare ogni semiotica – reale o potenziale – come un piano da descrivere secondo una procedura scientifica. Ma questa teoria, essendo essa stessa una costruzione linguistica, si configura anch’essa come un linguaggio. Da qui deriva una conseguenza cruciale: la teoria linguistica deve potersi applicare a se stessa, ovvero diventare oggetto di analisi con i propri strumenti.
Come ricorda Hjelmslev, quando abbiamo affermato che la teoria linguistica è un linguaggio abbiamo anche aperto la strada a una prospettiva interessante: la teoria linguistica deve poter essere analizzata e descritta per mezzo del suo stesso metodo.
Cigana osserva che questa circolarità è necessaria e non va eliminata, ma risolta attraverso una gerarchia dei linguaggi, in cui i gradi riflettono i diversi livelli su cui si collocano reciprocamente l’oggetto e la descrizione. Si trasferisce così la funzione logica dell’“uso” e della “menzione” dalle espressioni linguistiche alle proprietà strutturali del linguaggio stesso.
In questo quadro, la definizione non è concepita come un’uguaglianza terminologica del tipo A = B, ma come un’operazione schematica che fissa la posizione di ciascun termine in opposizione a tutti gli altri, all’interno di un sistema.
Lorenzo Cigana mette in evidenza che ciò comporta una concezione algebrica del linguaggio: le entità risultanti dall’analisi non hanno denominazione naturale, ma sono forme pure, e solo successivamente ricevono etichette. Si tratta di un principio che fonda anche la distinzione tra struttura del linguaggio-oggetto e struttura del metalinguaggio: la grammatica come oggetto e la grammatica come teoria.
Il linguaggio naturale, in questa prospettiva, è definito come una semiotica le cui categorie possono manifestarsi in qualsiasi sostanza. Ma, proprio per questa definizione teorica e costruttivistica, il linguaggio naturale — o “lingua” — non è mai verificabile empiricamente come tale: è un’idealità regolativa, più che un oggetto concreto.
L’impianto hjelmsleviano, dunque, delinea una teoria metalinguistica che descrive i linguaggi in modo formalizzato, stabilendo una gerarchia dei piani (linguaggio-oggetto, metalinguaggio, metasemiotica), senza mai uscire dal linguaggio stesso. In tal modo, la glossematica costruisce un sistema coerente in cui il linguaggio descrive il linguaggio, mantenendo una distinzione rigorosa tra piani e gradi, e fornendo una chiave fondamentale per l’analisi delle semiotiche.
Riferimento bibliografico: Lorenzo Cigana, Hjelmslev e i “linguaggi di gradi diversi”