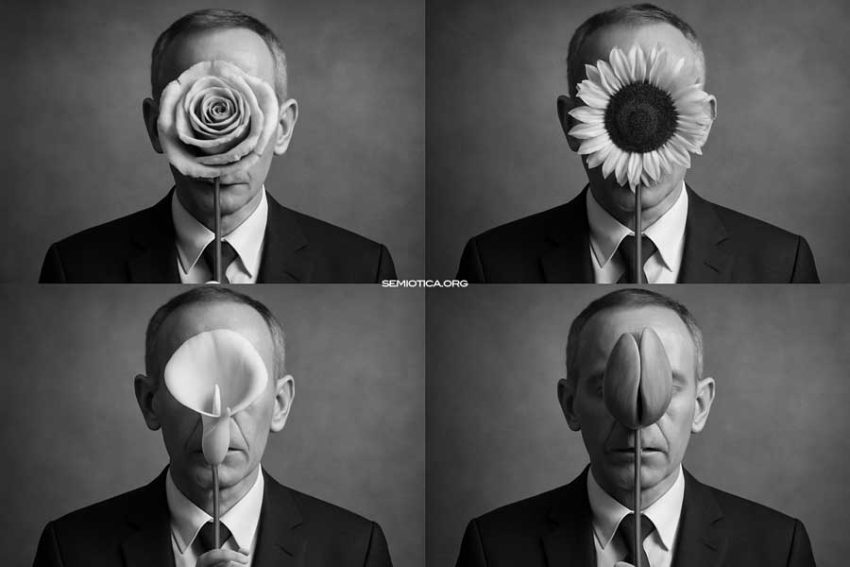Nel suo intervento sulla rilettura del Trattato di semiotica generale, Stefano Traini dichiara apertamente la sua “predilezione particolare per la prima parte del Trattato”, quella dedicata alla teoria dei codici. Tale preferenza deriva dalla sua formazione hjelmsleviana, che lo porta a riconoscere in Eco un’impostazione fortemente strutturale in quella sezione del testo.
Secondo Traini, Eco sembra seguire Hjelmslev non solo nel principio di correlazione tra piano dell’espressione e piano del contenuto, ma anche — e soprattutto — nell’idea che esista un livello immanente, soggiacente ai segni, costituito da “formanti”. Per chiarire questa prospettiva, Traini richiama tre brevi citazioni tratte dal Trattato:
- “Le cosiddette cose sono l’apparenza superficiale di una rete soggiacente di unità più macroscopiche”;
- “La semiotica, come la teoria musicale, ci dice che al di sotto della melodia riconoscibile c’è un complesso gioco di intervalli e di note”;
- “Quello che si chiama messaggio è il più delle volte un testo il cui contenuto è un discorso a più livelli”.
A partire da queste immagini, Traini evidenzia come il Trattato proponga una concezione del significato in termini di unità culturali che si pongono e si oppongono ad altre unità culturali. Il punto di partenza è strutturale, ma la direzione presa da Eco va oltre la descrizione dei segni in sé, puntando piuttosto alla relazione tra unità culturali.
Il vero interesse di Eco, nota Traini, non risiede nel valore opposizionale o posizionale dei segni, come avviene in molte letture strutturaliste classiche, né nella descrizione dei livelli del contenuto, che sarà invece una delle imprese centrali della semiotica greimasiana.
Piuttosto, il punto nodale del modello echiano è l’adozione del concetto di interpretante, mutuato da Peirce. Attraverso l’interpretante, Eco si spinge a ipotizzare una struttura della semiosi illimitata, che però definisce egli stesso come una “contraddizione”. Una contraddizione — osserva Traini — destinata a segnare l’intera produzione teorica dell’autore.
“Tanto che ancora in Kant e l’ornitorinco, Eco scrive che le due prospettive debbono coesistere, perché a volerne scegliere una sola non si rende ragione del nostro modo di conoscere e di esprimere quello che conosciamo”.
Traini concorda con questa posizione nell’ambito di una teoria della conoscenza, ma esprime perplessità sulla sua tenuta interna rispetto a una teoria semiotica:
“Non riesco però a convincermi del fatto che le due prospettive possano coesistere nell’ambito di una teoria semiotica che aspira a diventare […] una teoria generale della cultura”.
Secondo lui, la coesistenza di una visione strutturale e di una visione processuale può compromettere l’operatività della semiotica come strumento analitico. Una teoria della conoscenza può accettare l’instabilità e la contraddizione, ma una disciplina che ambisce ad analizzare i processi di significazione nella cultura deve dotarsi di strumenti operativi e coerenti.
Traini insiste infine sul fatto che, per Eco, la semiotica non è solo un sapere descrittivo, ma anche una forma di prassi: aspirazione che, proprio in quanto tale, dovrebbe spingere verso una maggiore chiarezza metodologica.
Fonte: Stefano Traini, Tavola rotonda sull’eredità del “Trattato di semiotica generale” di Umberto Eco, organizzata in occasione del XXXIV congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS) nel 2006.