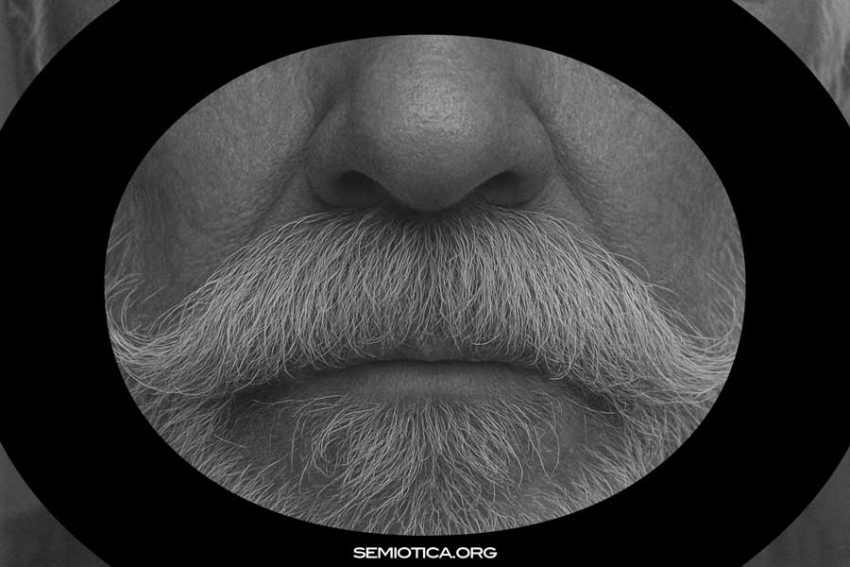Francesco Galofaro individua nei Fondamenti della teoria del linguaggio di Louis Hjelmslev un presupposto fondamentale di ordine epistemologico: la possibilità di scomporre ogni processo in una combinatoria di elementi semplici, descrivibile attraverso un numero limitato di premesse. Tale presupposto implica che qualsiasi processo può essere analizzato come un sistema finito, classificabile secondo le possibilità di combinazione dei suoi elementi. A partire da questa idea, Hjelmslev introduce il suo celebre principio empirico, la cui formulazione è precisa: “La descrizione deve essere libera da contraddizioni (coerente), esauriente e semplice quanto più si possa”. L’ordine delle priorità è anch’esso stabilito: la coerenza precede l’esaurienza, e quest’ultima precede la semplicità.
Galofaro chiarisce che, secondo Hjelmslev, la semplicità non va intesa in senso generico, ma come riduzione delle premesse a ciò che è strettamente necessario rispetto all’oggetto studiato. Inoltre, una teoria è adeguata solo se i suoi risultati sono in accordo con i dati empirici. Tuttavia, ciò che conta come “empirico” non è mai la totalità disordinata dell’esperienza, ma un testo – o più propriamente, alcuni testi – da cui si parte per costruire una teoria di sistemi interpretabili. La verifica avviene poi su altri testi: non vi è altro metro di giudizio che il testo stesso. L’approccio di Hjelmslev è dunque deduttivo, ma con riscontro empirico rigorosamente controllato.
Il rifiuto dell’induttivismo è, secondo Galofaro, uno dei tratti distintivi del progetto glossematico. L’induzione conduce a generalizzazioni basate su dati insufficienti, ottenute da lingue particolari e non estendibili ad altri sistemi linguistici. Hjelmslev rifiuta questa impostazione, accusandola di produrre concetti astratti ipostatizzati come reali. Questo tipo di “realismo medievale”, scrive, non è in grado di fornire basi comparabili tra lingue diverse. Il bersaglio è chiaramente la linguistica comparata, ma la critica si estende anche a quelle teorie che assumono i dati testuali come base privilegiata di generalizzazione.
Galofaro osserva che il rifiuto dell’induzione non implica la rinuncia all’esperienza, bensì la sua sottomissione a una struttura teorica forte e predefinita. L’empirismo hjelmsleviano è infatti un empirismo deduttivo: parte da una costruzione teorica, la applica ai testi, e ne valuta la capacità di spiegare le regolarità rilevate. Il testo, in quanto tale, è sia punto di partenza che banco di prova.
Il confronto con l’induzione ha anche un valore metodologico. Hjelmslev rifiuta di lasciare che sia l’esperienza a guidare la costruzione teorica: la teoria non è un prodotto dell’esperienza, ma una condizione di possibilità della descrizione coerente dei fatti linguistici. Galofaro nota che questa posizione lo distingue da molte tendenze contemporanee della semiotica, orientate all’analisi dei testi come processi e superfici differenziali. Tuttavia, lo stesso studio della variabilità richiede – osserva – un sistema di riferimento, anche se questo non è mai perfettamente realizzato nei testi.
Inoltre, la glossematica non esclude la possibilità di descrivere la variazione, ma lo fa a partire da un sistema: “perfino se nei fatti questo sistema non si realizzasse mai così come è stato descritto”, scrive Galofaro. È proprio in questa distanza che si colloca la funzione della teoria. La linguistica hjelmsleviana è dunque una teoria non induttiva e non empirista in senso ingenuo, ma costruita in modo deduttivo per poi confrontarsi con i dati linguistici attraverso criteri di coerenza, semplicità e esaustività.
Nel contesto delle riflessioni di Hjelmslev sull’indoeuropeo, Galofaro sottolinea che il problema dell’induzione era già evidente: le categorie grammaticali elaborate su una singola lingua non risultavano applicabili ad altre, e l’approccio fonologico o morfologico si rivelava inadeguato. Da qui nasce l’esigenza di riorganizzare la descrizione linguistica in base a opposizioni partecipative, superando il binarismo rigido e le classificazioni empiriche.
Alla base di tutto vi è una convinzione metodologica: per costruire una teoria generale del linguaggio non basta osservare i testi. Occorre un progetto teorico che ne anticipi la struttura possibile, un sistema in grado di descrivere e di prevedere. I Fondamenti di Hjelmslev non dimostrano che ciò sia possibile in astratto, ma ne offrono un esempio: una linguistica teorica fondata sul calcolo delle possibilità e sull’analisi relazionale dei segni.
Riferimento bibliografico: Francesco Galofaro, METASEMIOTICHE. Una ricognizione epistemologica