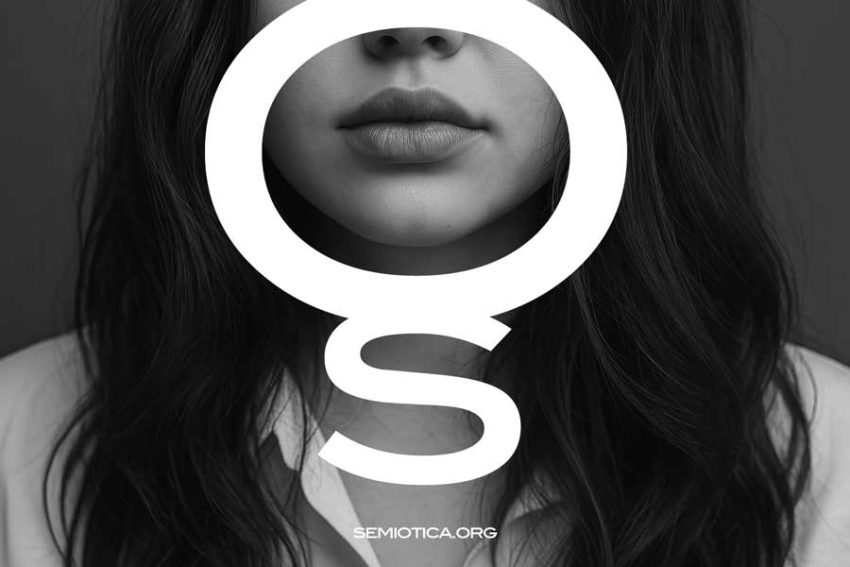Julio Horta ricostruisce la teoria della conoscenza moderna come fondata su un compromesso ontologico tra soggetto e oggetto. Tale impostazione, radicata nella filosofia cartesiana, implica una posizione realista per cui è l’attività razionale del soggetto a rendere conoscibile la vera natura del reale. In modo ancora più radicale, essa suppone la determinazione soggettiva dell’oggetto come condizione necessaria per una comprensione oggettiva della realtà empirica.
Horta cita Cassirer, per il quale la verità, nel modello cartesiano, consiste nei concetti indubitabili dello “spirito puro e attento”, generati esclusivamente dalla luce della ragione. Così si instaura un legame gerarchico tra epistemologia e scienza, dove la regulae philosophandi diventa prerequisito per il sapere scientifico. In questa prospettiva, “la mente” è intesa come spazio soggettivo interiore e come principio indubitabile del conoscere.
Il modello di scienza che ne deriva si fonda, secondo Horta, su una spiegazione di tipo causal-meccanicistico, dominata dalla legge di causalità. La fisica moderna, e le scienze della natura in generale, procedono verso una spiegazione causale completa, volta a rintracciare la “causa prima” all’interno di un ordine naturale regolato da leggi immutabili.
L’autore ricorda come Locke abbia trasformato la mente cartesiana nell’oggetto della “scienza dell’uomo”, proiettando il meccanicismo newtoniano nel campo della filosofia morale. Anche in Hume, sebbene si mantenga l’assunto che ogni contenuto mentale derivi da una sensazione esterna, emerge la facoltà dell’immaginazione, che formula principi di associazione tra impressioni: somiglianza, contiguità, causa-effetto.
La questione fondamentale è che la mente non si limita a percepire i dati sensibili, ma li organizza e li costituisce come oggetto di conoscenza. Di conseguenza, la scienza moderna si fonda su una verifica empirica che conferma la validità delle leggi tramite la loro evidenza fenomenica. Ma questa impostazione è problematica: l’esperienza, in sé, non garantisce la trasformazione in conoscenza, e la verifica empirica non fu sempre principio accettato, nemmeno all’interno della comunità scientifica.
Fu solo con l’emergere della “evidenza induttiva” che il problema dell’induzione sollevato da Hume poté essere formalmente tematizzato. In questo contesto si affermò il principio secondo cui una teoria è scientifica solo se verificabile per via empirica. La scienza moderna si sposta così verso una logica ipotetico-deduttiva, abbandonando la metafisica qualitativa in favore di concetti quantitativi e operativi, come “funzione” e “relazione”.
A questa tradizione si oppone radicalmente il pragmaticismo di Charles S. Peirce che elabora una critica ai fondamenti della scienza moderna. Seguendo Richard Bernstein, Horta individua due assi portanti del pensiero peirceano: in primo luogo, ogni processo cognitivo è segnico, poiché “l’uomo pensa, conosce e interpreta il mondo a partire dai segni”; in secondo luogo, il pensiero umano è inferenziale, e le ipotesi esplicative sono la condizione stessa per l’acquisizione di nuovi saperi.
A differenza dell’epistemologia moderna, il pragmaticismo peirceano fonda il sapere sulla possibilità, sull’intuizione e sull’immaginazione. Ciò implica una presa di distanza dal principio di verificazione, a favore di un modello in cui la validità delle teorie e delle leggi scientifiche si fonda su condizioni intersoggettive e metafisiche. In questo contesto, la quasi-mente assume un ruolo centrale: “due menti in comunicazione sono, in quella misura, un’unica mente” (Peirce, 2012, 2:472).
Riprendendo Karl-Otto Apel, Horta sottolinea che la dimensione intersoggettiva del pensiero comporta che l’inferenza cognitiva sia sempre supraindividuale. Il soggetto non pensa isolatamente, ma all’interno di una comunità; e il segno, mediatore della cognizione, modella l’identità del soggetto a partire dalle funzioni simboliche del linguaggio. Di conseguenza, il consenso intersoggettivo diventa condizione necessaria per la determinazione del simbolo, e il simbolo è ciò che consente futuri accordi condivisi all’interno della comunità degli interpreti.
Riferimento bibliografico: Julio Horta, “Pragmaticismo y Ley científica”, in deSignis, n. 43, 2025.