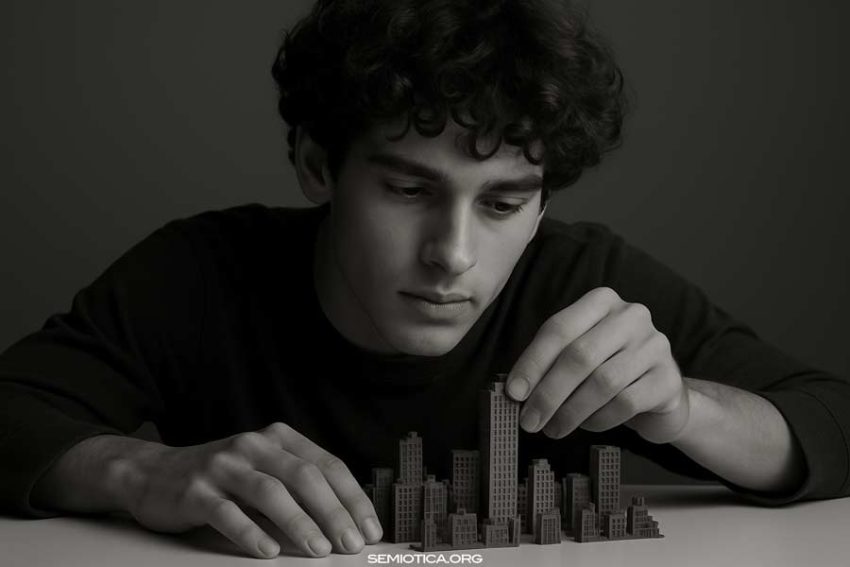Nella prospettiva della semiotica strutturale e generativa, il diritto non si presenta come un’entità unica o una tavola metafisica della legge. Piuttosto, viene inteso come un “fascio di fenomeni” che si fonda su sistemi e processi di significazione specifici.
Giuditta Bassano richiama l’originalità dell’approccio del giurista Philippopoulos, secondo il quale “la legge non è che uno spaccato interdisciplinare o postdisciplinare della combinazione vertiginosa tra geografia, storia, psicologia, chimica, fisica, economia, media, religione ed altro ancora”. Questa visione, fondata sul dialogo con Luhmann e su una ripresa del pensiero di Deleuze, appare in parte compatibile con un approccio semiotico, nella misura in cui concepisce il diritto come stratificato e molteplice.
Tuttavia, osserva Bassano, “il problema diviene quindi quello di distinguere che cosa sia diritto e che cosa non lo sia” e di comprendere le differenze tra, per esempio, “un apparato di condotte che definiscono delle buone maniere” e “gli articoli di un codice di legge”. La semiotica del diritto, infatti, non può che rifiutare “l’idea positivista che fonda metafisicamente l’unità degli ordinamenti giuridici”, ma al tempo stesso non può accogliere una concezione della legge come “totalità” di natura ontologica e “dal carattere conativo”.
Risulta allora necessario distinguere con chiarezza il punto di vista semiotico da tali prospettive filosofiche e precisare l’orizzonte epistemologico in cui si intende operare. In altri lavori, Bassano ha messo a fuoco “i fondamenti storico-filosofici di una considerazione costruttivista del linguaggio giuridico”, facendo riferimento al dibattito oxoniense tra Ryle, Strawson, Hart e Austin. È quest’ultimo, con la teoria degli atti linguistici, a fornire al diritto la possibilità di esistere come discorso performativo. Come ricorda Bassano, Greimas affermerà che nell’enunciazione giuridica non esistono asserzioni ma solo atti.
Da questa impostazione si distaccano due grandi linee teoriche: la pragmatica e il pragmatismo. La prima raccoglie studi di ambito europeo, anche molto differenti tra loro, come quelli di Grice e Searle; il secondo trova fondamento nel pensiero di Peirce e nella riflessione sul diritto di common law negli Stati Uniti. Giuditta Bassano chiarisce così la propria posizione nel quadro degli studi giuridici a vocazione semiotica, marcando una distanza tanto dal positivismo quanto da letture ontologiche o post-disciplinari del giuridico.
Riferimento bibliografico: Giuditta Bassano, «Tra semiotica del diritto ed etnosemiotica: una ripresa», in Cura del senso e critica sociale. Ricognizione della semiotica italiana, Mimesis, 2022.