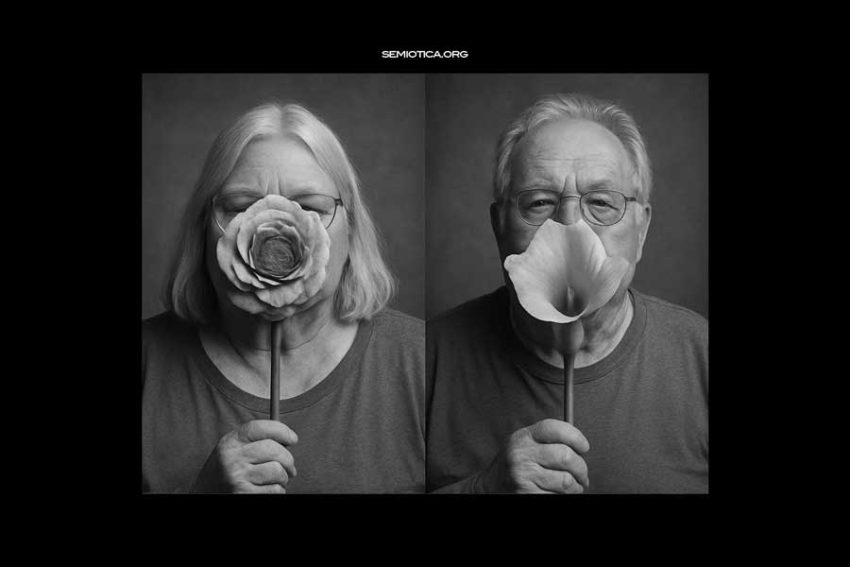Pierluigi Basso evidenzia un’eredità teorica fondamentale del Trattato di semiotica generale: l’insistenza sulla costituzione congiunturale di espressione e contenuto. Secondo Basso, questa tesi, ribadita ossessivamente da Eco lungo tutto il Trattato, ha implicazioni profonde tanto per la teoria della significazione quanto per le analisi testuali.
Eco contesta in modo esplicito la riduzione informazionale della comunicazione, tipica di certi modelli strutturalisti, secondo cui il senso sarebbe una funzione interna al piano del contenuto, indipendente dalla sua espressione. Al contrario, afferma Basso, nel Trattato si trova una posizione chiara: non esiste contenuto che non si costituisca attraverso il piano dell’espressione, e viceversa. È in questo quadro che Basso introduce l’immagine di un’ecologia della significazione, in cui espressione e contenuto si determinano a vicenda in un rapporto di co-implicazione.
Questo principio emerge con particolare forza nell’analisi del testo estetico contenuta nel Trattato. Eco considera il testo estetico non come un’eccezione, ma come un caso esemplare in cui si manifesta la possibilità di rimettere in gioco il piano dell’espressione a fini di significazione. La ripertinizzazione dei tratti espressivi — il fatto che alcuni elementi, in certi contesti, diventino semioticamente rilevanti — si accompagna a una ridefinizione locale del contenuto. È un processo che tocca direttamente il problema della creatività, già al centro delle ricerche di Eco negli anni Sessanta, e che viene ripreso con forza proprio nelle pagine finali del Trattato.
Un altro ambito in cui questa co-costituzione appare evidente è quello della medialità. Basso ricorda come Eco, criticando la concezione matematica dell’informazione, rifiuti di considerare il medium come un semplice supporto neutro. Per Eco, il medium è un elemento costitutivo della significazione. Non si dà significazione linguistica senza l’assunzione, esplicita o implicita, di un medium — e, al tempo stesso, non esiste medialità che non sia orientata alla produzione di senso.
Da qui l’idea di un doppio movimento: da un lato, la significazione richiede un supporto materiale e formale; dall’altro, questa materia — che sia grafica, sonora, visiva — è già strutturata per essere interpretabile. È in questo reciproco condizionamento che Basso intravede una delle acquisizioni più lucide e attuali del Trattato.
Fonte: Pierluigi Basso, Tavola rotonda sull’eredità del “Trattato di semiotica generale” di Umberto Eco, organizzata in occasione del XXXIV congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS) nel 2006.