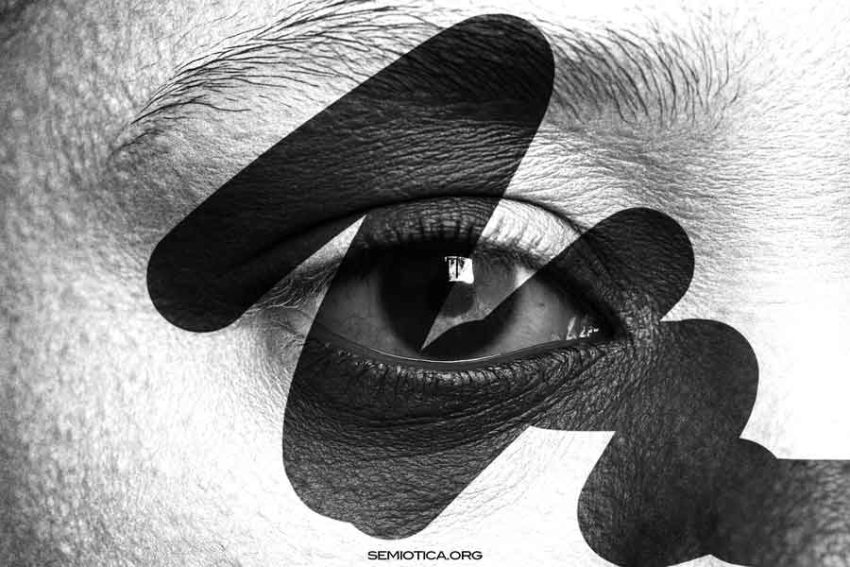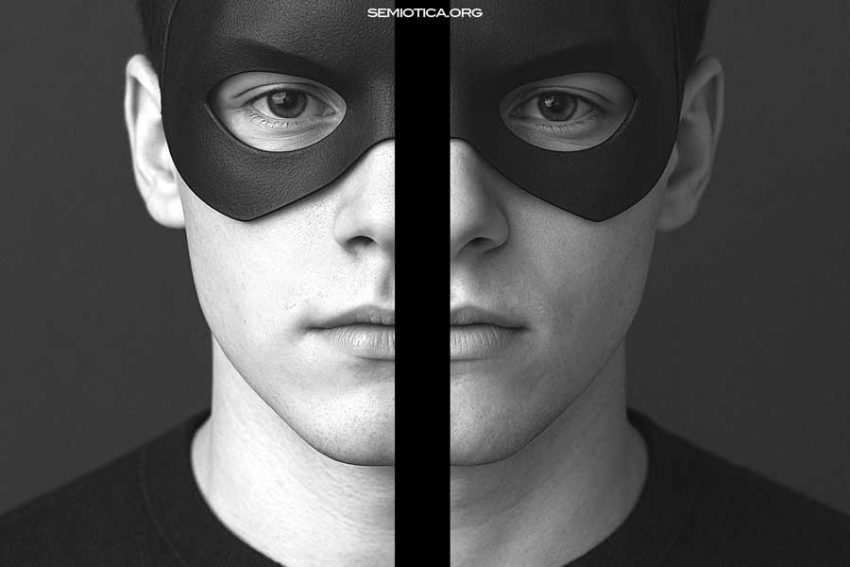Nella metà degli anni Ottanta, la semiotica appare attraversata da una condizione che Marrone — allora — descriveva come tipica delle scienze soggette a “crisi cicliche”. La disciplina oscillava fra entusiasmi teorici e improvvise restrizioni di campo, fra congetture e verifiche, mentre cresceva il numero di interventi che annunciavano, con toni diversi, la “crisi”, la…
Categoria: Semiotica & Linguistica
La nascita della semiotica delle passioni e la tradizione filosofica come archivio semiotico
La semiotica delle passioni si configura come un ampliamento interno alla teoria della significazione, senza assumere lo statuto di disciplina autonoma. È una direzione di ricerca che esplora i modi in cui stati, moti dell’animo e investimenti di valore entrano nella costruzione del senso. Isabella Pezzini osserva che questa prospettiva si radica nella cornice della…
Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco. L’essere tra soggetto, parola e mondanità
L’essere può essere tematizzato da tre prospettive, ciascuna delle quali si impone nei momenti in cui ci si interroga sul suo statuto. Umberto Eco ne individua tre configurazioni fondamentali: essere come ciò che è detto da un soggetto, come ciò che è detto da una parola, e come ciò che è nel mondo. Nel primo caso, l’essere è…
L’enigma delle “pagine seguenti”: interpretazione e attesa
Nel testo introduttivo dedicato alla Semantica strutturale di A. J. Greimas, Paolo Fabbri richiama l’attenzione su un paradosso linguistico che diventa anche una figura dell’interpretazione. La lingua, osserva, “riserva ad ogni lettore il paradosso delle ‘pagine seguenti’”. L’espressione può essere intesa in due modi distinti: le pagine che abbiamo già letto — e che quindi ci seguono…
Semiotica interpretativa: il testo come “intessuto di non detto”
Nella prospettiva della semiotica interpretativa, un testo non è mai un oggetto autosufficiente. Esso si presenta come una struttura incompleta, che necessita dell’intervento del lettore per essere attualizzata. Secondo questa impostazione, il testo è sempre “intessuto di non detto” e contiene una quantità di informazioni implicite che il destinatario è chiamato a estrapolare grazie alle proprie conoscenze…
Il “silenzio di Kant”: la lettura di Tullio De Mauro e il problema del linguaggio
Nel 1965 Tullio De Mauro intitolò Il silenzio di Kant un breve paragrafo della sua Introduzione alla semantica. Con quella formula indicava la «mancanza di attenzione al problema del linguaggio in generale, e dunque anche ai problemi semiotici in senso lato che il linguaggio pone». A suo giudizio, nella filosofia kantiana non si troverebbe una vera teoria del…
Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco. L’aporia dell’essere e il linguaggio che non lo definisce
L’essere non è definibile. Umberto Eco individua in questa constatazione il centro della grande aporia aristotelica. Sebbene l’essere sia il presupposto di ogni definizione, esso stesso non può essere definito, poiché – per definire qualcosa – è necessario ricorrere a un genere e a una differenza specifica. Ma l’essere non è un genere, neppure il più generale:…
Il primato delle lingue naturali nella traduzione delle altre semiotiche
Nel quadro delle macrosemiotiche, Greimas e Courtés mettono in evidenza un principio decisivo per la teoria semiotica: le lingue naturali sono le uniche in cui sono traducibili tutte le altre semiotiche, mentre l’inverso non è possibile. Questo asimmetrico rapporto di traducibilità è spiegato da due ordini di motivi. Anzitutto, “le figure del mondo naturale sono semanticamente…
Pragmatica e semiotica: differenze, convergenze, alleanze
Il modello delle co-illocutions proposto da Sophie Anquetil prende forma all’incrocio tra due prospettive teoriche che, pur distinte, mostrano legami profondi: la pragmatica integrata e la semiotica narrativa. L’autrice insiste sull’utilità di un dialogo tra queste discipline, sottolineando come il proprio approccio, pur provenendo dalla tradizione pragmatica, sia stato fortemente influenzato dai concetti di “fare narrativo”, “trasformazione”…
Lector in fabula. Il semema come espansione testuale nella prospettiva peirciana
Secondo Umberto Eco, l’idea che il testo sia l’espansione di un semema è pienamente coerente con la semiotica di Charles Sanders Peirce. La formula “il semema è un testo virtuale e il testo è l’espansione di un semema” sintetizza una concezione della significazione come processo illimitato, in cui il significato non è mai dato una volta per…