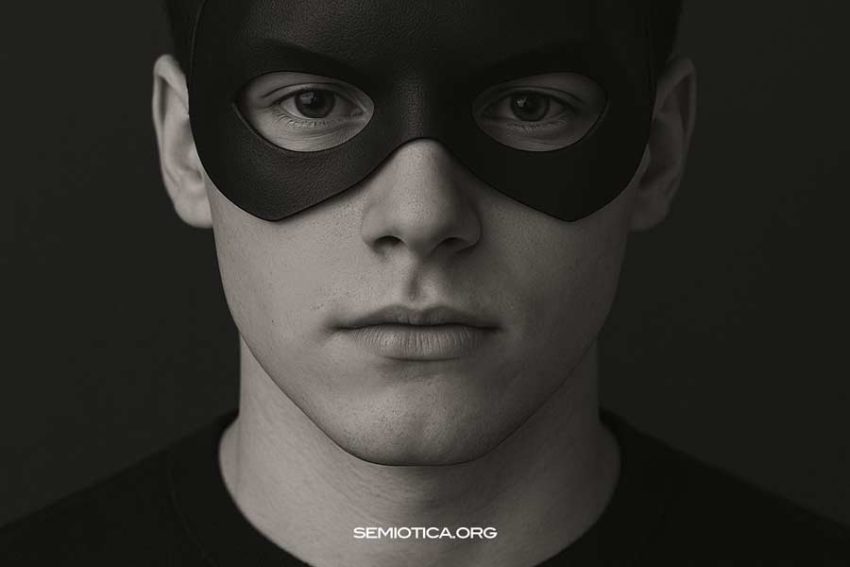Per affrontare in modo rigoroso il rapporto tra semiotica ed ecologia, Gianfranco Marrone propone di partire da un nodo teorico fondamentale: l’articolazione della ricerca semiotica su quattro livelli distinti ma interrelati. Il modello di riferimento è quello delineato da Algirdas Julien Greimas nella Sémantique structurale e successivamente sviluppato da Paolo Fabbri, in particolare ne Le tournant sémiotique (La svolta semiotica).
Greimas individua quattro livelli gerarchici del linguaggio che costituiscono la struttura logica dell’attività scientifica in semiotica:
- lingua-oggetto
- linguaggio descrittivo
- linguaggio metodologico
- linguaggio epistemologico
Questa gerarchia permette di distinguere il livello dell’oggetto d’indagine (la lingua-oggetto), da quello che la descrive (descrizione), da quello che organizza concetti e strumenti descrittivi (metodo), fino a quello che riflette sulle condizioni e coerenze del sapere stesso (epistemologia). Greimas sottolinea che una semantica scientifica può esistere solo se questi tre linguaggi — descrittivo, metodologico ed epistemologico — vengono simultaneamente tenuti in conto.
Fabbri riprende e sviluppa questo schema articolandolo nei termini di una vera e propria architettura della ricerca semiotica. I livelli, pur distinti, non sono indipendenti, e vanno tenuti insieme nel corso dell’indagine. Si tratta di un dispositivo logico e non valutativo, dove la circolarità tra i livelli è costitutiva del lavoro analitico. Fabbri insiste in particolare sull’esistenza di anelli mancanti, ossia i collegamenti mancanti tra i livelli stessi, il cui ripristino è condizione di rigore per la disciplina.
Nel dettaglio:
- Livello empirico: riguarda l’analisi concreta dei sistemi significanti. Il punto di partenza non è un mondo di dati puri e preesistenti, ma oggetti costruiti e selezionati attraverso il progetto descrittivo. La semiotica, scrive Fabbri, deve “entrare in contatto […] con queste pratiche di significazione complesse”.
- Livello metodologico: introduce un orientamento nell’osservazione. L’analisi si comporta come un “esperimento mentale” (Gedankenexperiment), capace di modellizzare e ridefinire i testi culturali. Fabbri definisce la metodologia semiotica come un organon, un’arte razionale locale e non universale, capace di fornire modelli e massime operative.
- Livello teorico: trasforma le categorie della metodologia in concetti interdefiniti tra loro. La teoria permette di articolare modelli e categorie, garantendo la coerenza dell’analisi. “Il testo è il selvaggio del semiologo”, osserva Fabbri, e la teoria nasce come risposta alla resistenza testuale.
- Livello epistemologico: esamina i presupposti filosofici e teorici delle categorie utilizzate. Qui si interrogano nozioni come “essere”, “fare”, “soggetto”, “oggetto”, “differenza”, “relazione”, portandole alla luce come problemi. Fabbri invoca un dialogo con altre discipline filosofiche — ermeneutica, logica, fenomenologia — per mettere in discussione le opposizioni date come natura/cultura, animale/umano, vita/morte.
L’intera architettura non può funzionare se i passaggi tra i livelli sono assenti. Proprio questi passaggi costituiscono gli anelli mancanti, non intesi come semplici concetti da aggiungere, ma come relazioni da costruire. Il rischio, altrimenti, è quello di una ricerca disarticolata, dove il discorso filosofico si fonda su descrizioni arbitrarie, o l’analisi applica metodi senza definire concetti, o ancora, si utilizza una teoria senza base epistemologica.
Fabbri individua tre principali anelli mancanti:
- tra epistemologia e teoria
- tra teoria e metodo
- tra metodo e descrizione empirica
Una semiotica priva di questi collegamenti si riduce, secondo Fabbri, a un bricolage metodologico irresponsabile o a un’applicazione meccanica di schemi astratti. Al contrario, il compito della semiotica marcata è proprio quello di ricostruire i ponti, in modo esplicito, tra i livelli di cui si compone la sua architettura scientifica.
Riferimento bibliografico: Gianfranco Marrone, Des chaînons manquants dans une sémiotique écologique : le cas des animaux, in «Actes Sémiotiques», n°125, 2021.