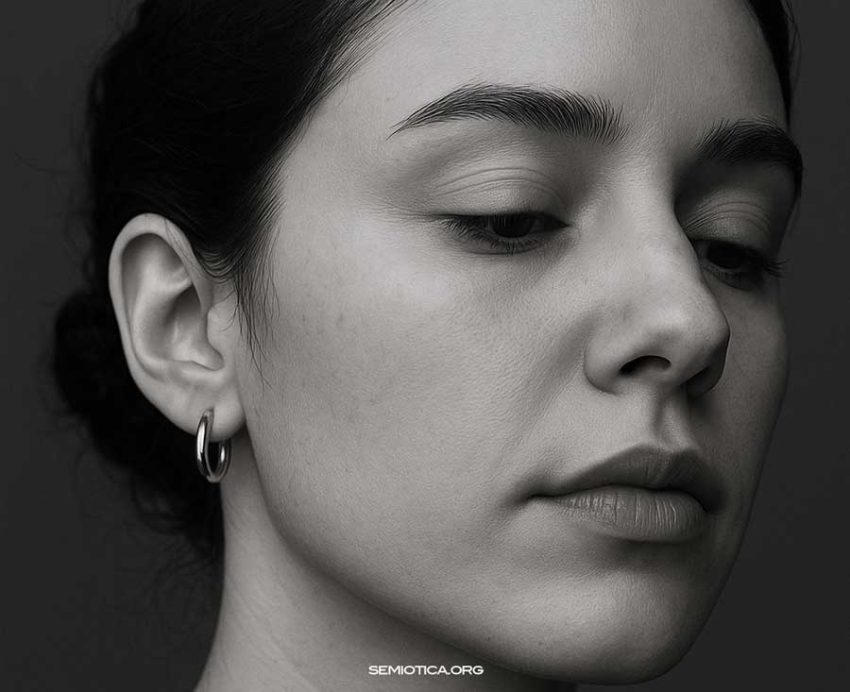Gianfranco Marrone affronta il tema della natura attraverso la lente teorica offerta da Bruno Latour, autore che nel libro Politiche della natura propone un radicale ripensamento del rapporto tra scienza e politica. Secondo Latour, ogni idea di natura — o, meglio, ogni natura — è il risultato di una doppia costrizione: politica e scientifica al tempo stesso. La scienza, infatti, non si costituisce mai in modo neutro, ma risente di un certo orientamento politico, mentre la politica è modellata da precise disposizioni epistemologiche.
Parlare di natura significa allora discutere di assetti politici prima ancora che epistemologici. Marrone sottolinea come i movimenti ecologisti — in particolare i “verdi” — abbiano portato la natura nell’agenda politica, ma senza intaccare davvero l’idea implicita di politica della natura che permea la cultura occidentale. Gli ecologisti, secondo Latour, hanno posto un problema serio ma in modo impreciso, rivendicando una natura che coincide con l’immagine irriflessa del senso comune. È una natura che deriva più dalla divulgazione mediatica (ad esempio dai documentari televisivi) che dalla riflessione scientifica o teorica.
Marrone osserva che si tratta di una natura “banalizzata” e trasposta su un piano enunciazionale tipico dei media di massa, i quali non fanno che riproporre l’autorità discorsiva delle scienze naturali in una forma diversa, spettacolarizzata e semplificata. Il problema è che questa “natura dei verdi” dà per scontata la separazione tra natura e società, su cui si fonda anche la distinzione tra scienza e politica nella tradizione occidentale.
Ma è proprio da qui che, secondo Latour, può nascere una riflessione più profonda. L’azione degli ecologisti, pur se confusa, indica — spesso inconsapevolmente — un nodo irrisolto, epistemologico e metapolitico insieme: la necessità di ripensare la costituzione stessa dell’idea di natura. Questo richiede una ridefinizione del “collettivo”, in cui natura e società, scienza e politica non siano più tenute rigidamente separate.
Marrone sottolinea che inserire il tema della natura nell’agenda politica, per esempio discutendo di modelli sostenibili di sviluppo, comporta un mutamento radicale nella mentalità sociale. Non si tratta più di proteggersi dalla natura, né di proteggerla, come vorrebbe l’ecologismo più superficiale. Si tratta invece di costruire socialmente la natura, attraverso una concertazione tra soggetti diversi: scienziati, amministratori, economisti, filosofi, attivisti e altri.
Questa visione nega l’alterità radicale della natura rispetto all’uomo, affermando piuttosto che la natura è il prodotto di rapporti sociali, e che la società stessa non è una rottura culturale rispetto a una base naturale originaria, ma è co-originaria e co-dipendente. Il genitivo contenuto nel titolo del libro di Latour — Politiche della natura — va allora inteso in senso doppio: le politiche che riguardano la natura e le politiche che la natura stessa porta avanti, se riconosciuta come attante collettivo.
In questo scenario, Marrone vede delinearsi la prospettiva del multinaturalismo, proposta da antropologi come Eduardo Viveiros de Castro e Philippe Descola. Secondo questa visione, non esiste una sola natura comune a tutte le culture, ma una molteplicità di nature costitutivamente legate alla pluralità delle culture. La natura non è una base stabile da cui si diparte la diversità culturale, ma è essa stessa diversa, molteplice, configurata secondo sistemi simbolici differenti. In questa prospettiva, l’opposizione tra natura e cultura si dissolve: la natura è cultura — o, meglio, è altro della cultura, ma sempre interno ad essa.
Riferimento bibliografico: Gianfranco Marrone, Politiche della natura / Natura della politica