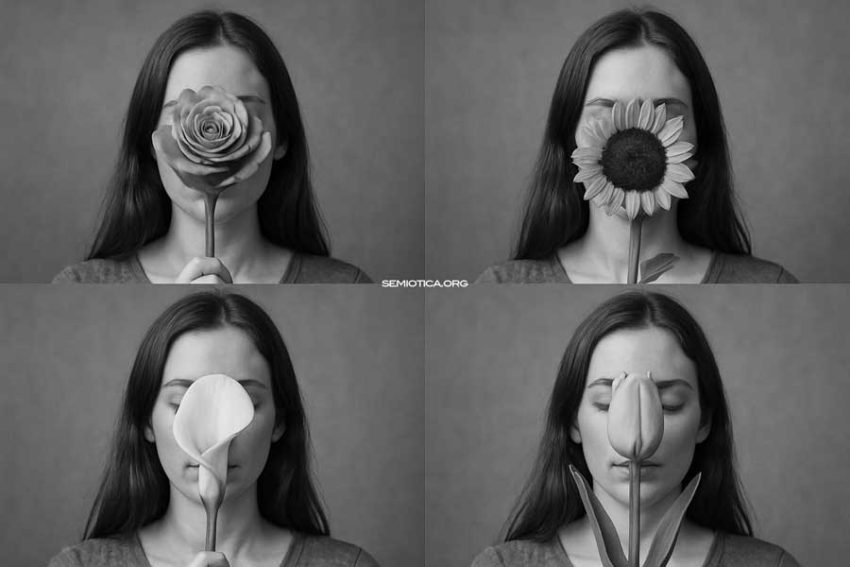Per Umberto Eco, il fondamento filosofico dell’approccio semiotico è la capacità umana di rappresentare l’assenza. È questo che distingue l’uomo dagli altri animali: «l’animale umano ha la capacità di poter pensare e comunicare l’assenza». Mentre gli animali reagiscono a stimoli presenti, l’uomo può parlare della Luna o degli Stati Uniti anche se non li ha di fronte, può raccontare storie, costruire mondi immaginari, e soprattutto sa che deve morire. Gli altri animali muoiono, ma non sanno che devono morire; l’uomo sì, perché ha visto altri morire, ne ha sentito parlare, ne ha tratto conclusioni.
Questa capacità di presentificare l’assenza è alla radice stessa della semiosi. Ecco perché, osserva Eco, «la radice di tutta la semiotica sta nel riuscire a capire cosa avviene in questo spazio di assenza».
Tale concezione si collega direttamente a un altro nodo centrale della riflessione echiana: l’enciclopedia. Ogni scambio significante presuppone uno sfondo di competenze comuni, e queste competenze sono organizzate in quell’insieme dinamico e collettivo che Eco chiama “enciclopedia”. Essa comprende tanto nozioni vere quanto credenze false: accoglie allo stesso modo gli anelli di Saturno e Cappuccetto Rosso. È la base flessibile e mutevole del sapere condiviso, ed è il presupposto stesso della comunicazione.
Secondo Eco, l’umanità ha sempre tentato di organizzare e controllare l’enciclopedia: lo dimostrano le biblioteche, i musei, le raccolte sistematiche da Plinio alla Treccani. Ma l’enciclopedia non deve solo conservare: deve filtrare. Deve registrare, ad esempio, la battaglia di Waterloo, ma non i nomi di tutti i caduti. Quel tipo di selezione è necessario, altrimenti si cade nel paradosso dell’onniscienza inutile.
Qui si inserisce la critica di Eco alla rete: Internet è una forma di enciclopedia che non filtra, una sorta di Funes il memorioso borgesiano, che ricorda tutto e per questo «è un perfetto idiota». «C’è tutto», dice Eco, ma manca un criterio di selezione, una gerarchia. Di fronte a un sito, «non si sa mai se l’informazione è attendibile o non è attendibile».
Questa situazione genera una sfida nuova per l’umanità. Se un tempo il problema era possedere quanta più enciclopedia possibile, oggi il problema è sbarazzarsene, ridurla. Ma questa scienza del filtraggio — afferma Eco — «non è stata ancora inventata». Potrebbe non essere una scienza, bensì una pratica intuitiva, che si apprende per esperienza, per imitazione, «come il cacciatore apprende dallo stormire delle foglie».
Il pericolo estremo è che, senza più un’enciclopedia condivisa, ogni essere umano costruisca la propria. Se ciò accadesse, «sarebbe l’assoluta incomunicabilità». Alla domanda se esista una conoscenza emergente dalla rete, Eco risponde con decisione: la conoscenza non è solo acquisizione, è anche selezione. Così come la memoria non è solo ritenzione, ma anche rimozione.
«Se ricordassimo tutto saremmo finiti», afferma. E aggiunge: «se la rete non elimina, non è un modello di intelligenza umana. Al massimo è un modello di intelligenza divina, ma verrebbe fuori l’idea di un Dio completamente stupido, perché sa troppe cose, non organizzate».
Infine, la riflessione si chiude con un’immagine ironica e precisa: il problema della rete non è il senso, ma la quantità. Non è questione di contenuto (il caviale o la frittata), ma di eccesso bulimico. «La rete è Grand Buff per quantità, e in questa quantità è impossibile stabilire distinzioni».
Fonte: Semiotica: origini, definizione, sguardo sul presente, Intervista a Umberto Eco, Andrea Cirla, 2006