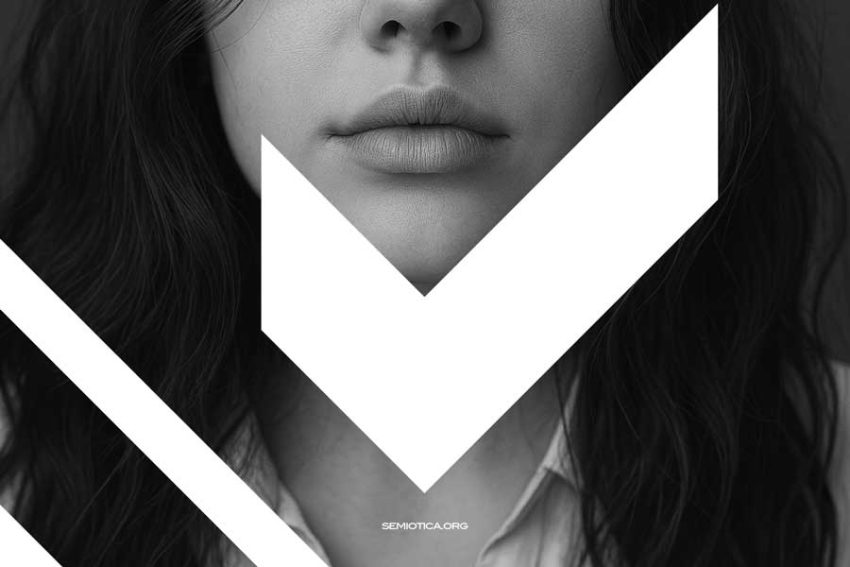Nelle culture fondate su testi sacri o fondativi, il contrasto tra stili interpretativi differenti rappresenta il cuore di questioni politiche fondamentali: chi ha diritto di interpretare i testi sacri, e quindi di esercitare un’autorità sulla comunità? Quali destinanti hanno il potere di sanzionare tali interpretazioni?
Jenny Ponzo propone di immaginare tali culture come semiosfere (Lotman) con una struttura semplice: al centro i testi fondativi; intorno, più o meno perifericamente, comunità di interpreti e metatesti (Genette) che si confrontano con quei testi secondo approcci, presupposti e criteri differenti. Ne derivano letture divergenti, con conseguenze culturali, sociali e politiche profonde. In questo quadro, lo stile interpretativo incide non solo sul rapporto del lettore con il testo sacro, ma anche sulla definizione dell’identità del gruppo e sulla sua organizzazione sociale.
Tra gli studiosi che hanno riflettuto su tali dinamiche, Ponzo richiama Vincent Crapanzano, che ha studiato il literalismo come “stile interpretativo” in America, sia in riferimento alla Bibbia che alla Costituzione. In un altro studio, la stessa Ponzo ha mostrato come gli stessi versetti biblici sul fenomeno delle lingue vengano letti in modo opposto da Evangelici conservatori e Carismatici: i primi si affidano a una lettura piana e letterale, mentre i secondi cercano un’esperienza diretta del fenomeno spirituale narrato, al punto che il successo interpretativo viene misurato in termini performativi (felicitous secondo la terminologia di Austin).
Il confronto tra stili non riguarda solo i contenuti, ma anche i criteri interpretativi esplicitamente dichiarati, che diventano parte dell’argomentazione. Nei discorsi fondamentalisti, ad esempio, l’interpretazione di un passo può servire più alla legittimazione di una tesi che non all’applicazione coerente di una metodologia. Come osserva Ponzo, ciò rende il conflitto tra stili una questione eminentemente politica: chi ha il diritto di interpretare? Con quali parametri si legittima l’interpretazione? Chi ha il potere di “sanzionare” (Greimas) una lettura?
Umberto Eco (1990) distingue due principali tendenze interpretative nella cultura occidentale: una razionale, fondata sul modus ponens, e una ermetica, segnata da mistero, segretezza e polisemia. All’interno della cultura cattolica romana, spiega Ponzo, si possono identificare due stili analoghi: da un lato quello intellettuale e razionale, tipico del discorso teologico, del Magistero e del diritto canonico; dall’altro quello esperienziale e misterioso, proprio del discorso mistico.
La Chiesa, pur riconoscendo la possibilità di rivelazioni individuali, sottopone tali esperienze a un esame severo basato su criteri razionali e giuridici: autenticità, coerenza dottrinale, compatibilità con il depositum fidei. Questo vale in modo ancora più rigoroso quando le interpreti sono donne. La figura della mistica donna, infatti, si colloca in un’area di tensione tra legittimazione popolare e sospetto istituzionale.
Come sottolineava già Eco, nel medioevo la Chiesa fondava la propria autorità ermeneutica sulla Tradizione, la quale però coincideva con la stessa serie delle “buone” interpretazioni delle Scritture. La Tradizione trae legittimità dall’interpretazione dei Testi, ma è anche ciò che fonda il diritto a controllarli. “Quis custodiet custodes?” si chiede Eco: chi legittima chi ha il potere di legittimare?
La risposta, osservava Eco, è pratica e politica: sono i “vincitori” – coloro che riescono a imporre la propria interpretazione – a dettare le regole del gioco.
Riferimento bibliografico: Jenny Ponzo, Mystics and politics: women and the interpretation of the Scriptures, Semiotica, vol. 2025, no. 265, pp. 121–136. https://doi.org/10.1515/sem-2025-0093
Procedo con il secondo articolo?