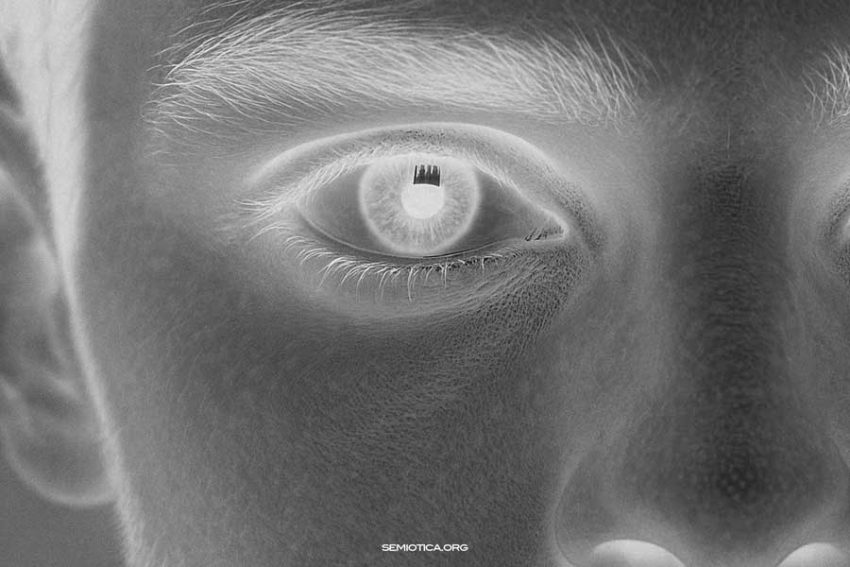Claudio Paolucci individua nell’emergere di una “nuova sensibilità” la svolta decisiva che conduce alla nascita della semiotica come disciplina autonoma. È la sensibilità evocata da Umberto Eco, quella capace di dar forma a una “cultura semioticamente orientata”. A renderla operativa è un mutamento epistemologico che investe il modo stesso di pensare il rapporto tra oggetto e rappresentazione, tra fatto e teoria.
La maggior parte del pensiero scientifico contemporaneo si costruisce attorno alla distinzione tra l’ordine dell’oggettività e quello della sua rappresentazione teorica. Filosofia analitica, scienze cognitive, epistemologia e persino l’ermeneutica si definiscono a partire dalle modulazioni di questo rapporto: ora con netta opposizione, ora con integrazione, ora con ambivalenza. Eppure, secondo Paolucci, ciò che definisce propriamente la semiotica è la scoperta di un terzo ordine, irriducibile a entrambi.
Questo ordine è ciò che Charles Sanders Peirce ha chiamato Terzità: una dimensione strutturalmente triadica, che non può essere ricondotta né al fatto né alla teoria. Se l’oggetto è Due e il representamen è Uno, è l’interpretante a costituire il Tre, cioè l’elemento propriamente semiotico. La semiosi, spiega Peirce, è un’azione “che è, o implica, una cooperazione di tre soggetti, il segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale che questa influenza tri-relativa non si possa in alcun modo risolvere in rapporti tra coppie” (CP 5.484).
Paolucci sottolinea come questa triadicità implichi una complessità strutturale che non può essere ridotta a nessun rapporto binario. È proprio nella Logica dei Relativi che Peirce dimostra come tutte le relazioni, anche quelle a più valenze, possano essere generate a partire dalle triadi. È dunque la Terzità dell’interpretazione a rendere pensabile l’intero processo semiosico, incluso il rapporto tra oggetto e rappresentazione.
Anche Louis Hjelmslev, pur da un’altra angolazione, scopre un terzo ordine, propriamente glossematico. Tutti gli elementi teorici della linguistica – dal paradigma al sintagma, dalla sostanza alla forma – sono per lui epifenomeni di un solo principio differenziale: la classe. Questa entità glossematica non si confonde con i fatti di linguaggio né con le teorie sul linguaggio, ma costituisce una dimensione autonoma, irriducibile e originaria.
Paolucci sottolinea come la glossematica hjelmsleviana rappresenti una forma originale di analisi trascendentale: ciò che è costitutivo dell’esperienza linguistica non deriva da essa, ma ne rappresenta la condizione di possibilità. Hjelmslev può così sostenere che l’“immanenza e la trascendenza si uniscono in un’unità superiore sulla base dell’immanenza”.
In questa prospettiva, anche il fonema non è né un’entità sonora né un’immagine acustica, ma un’unità differenziale definita solo dai rapporti che intrattiene con altri fonemi. La relazione bollo/pollo, ad esempio, è l’effetto di un dispiegamento strutturale, in cui una distinzione sul piano del significante (b vs p) produce una differenza sul piano del significato. È questa logica strutturale, fondata su differenze interne, a costituire il piano d’immanenza del linguaggio.
Paolucci mostra come la glossematica spinga questa logica fino al punto in cui anche le teorie e i fatti del linguaggio appaiono come manifestazioni fenomeniche di un unico principio differenziante: la classe. La trascendenza delle teorie e dei fatti è possibile solo a partire da questa immanenza originaria, che li rende leggibili.
La “nuova sensibilità” di cui Eco parlava si configura allora come l’emergere di un ordine terzo, che differenzia radicalmente la semiotica da ogni filosofia del linguaggio precedente. Non è più in gioco una teoria della rappresentazione, ma una teoria della costituzione dei differenziali strutturali, che operano oltre il fatto e oltre la sua rappresentazione. La domanda diventa allora: quali sono le entità che popolano questo terzo ordine? E quali relazioni instaurano tra loro, se non sono né fatti né rappresentazioni? È qui che prende forma una nuova ontologia del senso.
Riferimento bibliografico: Claudio Paolucci, Strutturalismo e interpretazione. Ambizioni per una semiotica “minore”, Milano, Bompiani, 2010.