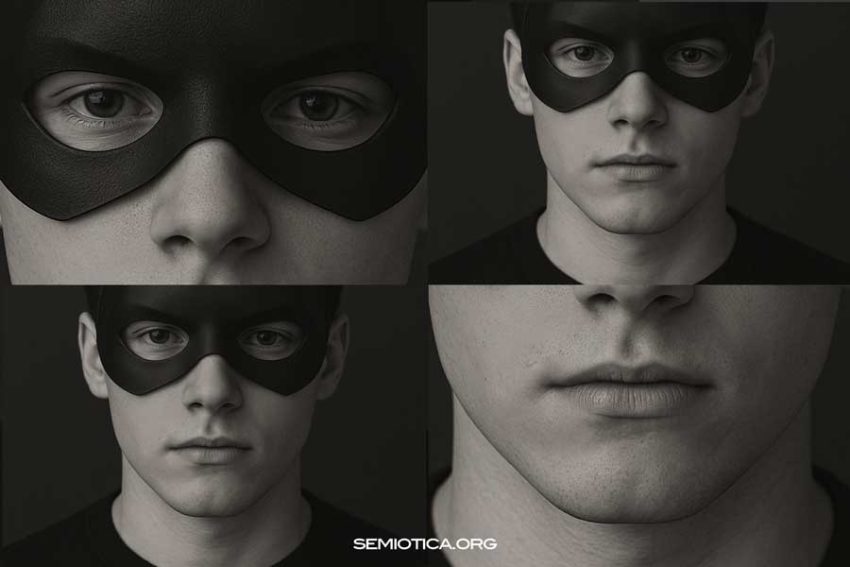Claudio Paolucci riconosce nella seconda parte del Trattato di semiotica generale una delle elaborazioni più potenti e ancora attuali della teoria dell’enunciazione. Secondo lui, la “teoria dei modi di produzione segnica” formulata da Eco coincide, sotto molti aspetti, con ciò che in altre tradizioni è stato definito teoria dell’enunciazione in atto o prassi enunciativa.
Paolucci chiarisce che tale approccio non va confuso con la teoria dell’enunciazione “testualizzata”, che ricostruisce l’istanza dell’enunciazione a partire dalle tracce presenti nell’enunciato. Al contrario, la teoria di Eco assume che l’enunciazione sia un atto operativo: una produzione materiale e situata del discorso. In questo senso, afferma, è pienamente “benvenistiana”. L’enunciazione, secondo Benveniste, è “un atto di mediazione che produce il discorso”; e la teoria echiana dei modi di produzione è esattamente questo: una teoria della mediazione semiotica.
Nel momento in cui si passa dalla teoria dei codici alla teoria dei modi di produzione, la semiotica non si limita più a descrivere sistemi, ma si configura come una teoria della prassi. Paolucci insiste sull’idea che il Trattato proponga una semiotica “incarnata”, in cui un soggetto operatore costruisce commensurabilità tra espressione e contenuto attraverso un gesto produttivo. Il codice, in questo contesto, non è un sistema astratto, ma un dispositivo attualizzato dall’operazione stessa.
A conferma di questa lettura, Paolucci richiama un passaggio cruciale dell’introduzione del Trattato, dove Eco afferma che la disciplina va intesa come “conoscenza teorica solo ai fini di una prassi dei segni”. La metafora proposta è esplicita: non un teatro dove si rappresentano significati, ma una fabbrica che produce segni, dispositivi comunicativi, possibilità di menzogna e di simulazione.
Questa visione della semiotica come “fabbrica” si lega direttamente a una forte critica dell’ideologia, contenuta anch’essa nella seconda parte del Trattato, e anticipa molte delle questioni oggi discusse nei dibattiti contemporanei. Paolucci, per esempio, mette in relazione la riflessione di Eco con quella di Gianfranco Marrone, citando un passo in cui si propone di disimplicare la maniera in cui le figure dell’espressione prendono forma a partire dal substrato materiale delle iscrizioni e dal gesto che ve le ha iscritte.
Secondo questa prospettiva, l’interpretazione consiste nel ritrovare le forme di un’altra esperienza che ha lasciato la sua impronta. La prassi enunciativa è dunque ciò che consente di articolare, attraverso un gesto produttivo, l’espressione e il contenuto. Ed è proprio questa operatività — questa attenzione al “modus operandi” — che fa della teoria dei modi di produzione una delle intuizioni più avanzate del Trattato, capace ancora oggi di parlare al presente della semiotica.
Fonte: Claudio Paolucci, Tavola rotonda sull’eredità del “Trattato di semiotica generale” di Umberto Eco, organizzata in occasione del XXXIV congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS) nel 2006.