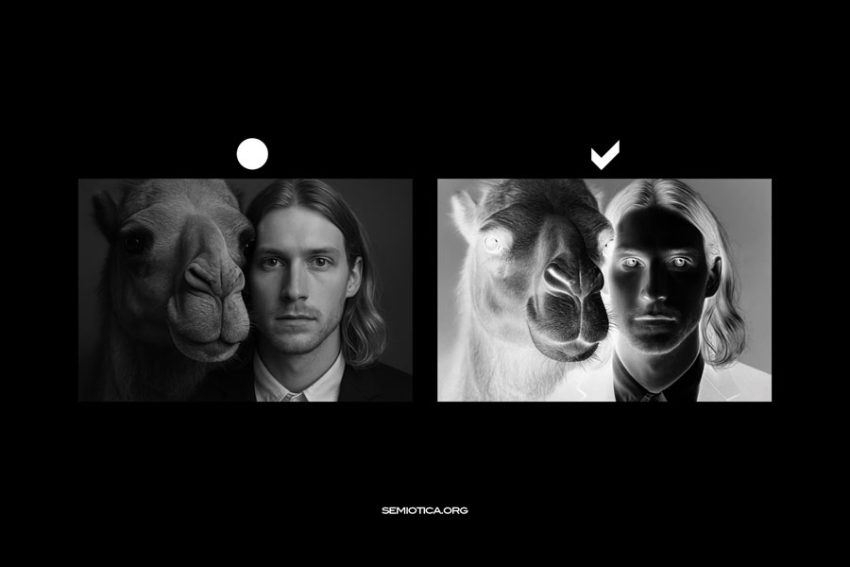Il significato non è un’entità secondaria o derivata, ma nasce insieme ai termini che lo costituiscono, come effetto della loro relazione strutturale. Non ci sono prima le cose e poi i loro significati. Al contrario, scrive Daniele Barbieri, “senza significati non ci sono cose, senza cose (strutturalmente definite per Opposizioni) non ci sono significati”.
Questa prospettiva si fonda sull’idea che, nel momento in cui si pone un’opposizione tra due termini, non solo li si definisce, ma li si crea. In linea con il principio saussuriano secondo cui il valore di un termine dipende dalla sua posizione nel sistema, Barbieri osserva:
Poiché non esistono enti in sé, enti dati, i termini stessi iniziano a esistere nel momento in cui entrano a far parte di un’Opposizione, e si definiscono reciprocamente nei termini di quella specifica Opposizione.
La formazione dell’opposizione genera anche le due direzioni della Complementarietà nel quadrato semiotico:
– verso il basso, si pone una implicazione fondata sulla pura Alterità (ad esempio: a implica non-b),
– verso l’alto, si genera una relazione di significato locale, come non-b comporta a (e viceversa).
Entrambe le direzioni corrispondono a forme di implicazione, ma con statuti diversi:
– la prima si basa su una regola data,
– la seconda su un’ipotesi formulata nel contesto della Trasformazione.
La Trasformazione non è semplicemente un passaggio da uno stato all’altro, ma è ciò che pone i termini stessi e li lega in modo significativo. Quando si attribuisce a una coppia di termini una relazione oppositiva, si costruisce simultaneamente il senso e i suoi poli.
Anche la complementarietà ascendente, pur essendo fondata su un’ipotesi, può funzionare come un’implicazione operativa. Un esempio chiave è dato dalla relazione tra non-vita e morte. L’enunciato “quando si smette di vivere si muore” veicola una Trasformazione talmente condivisa da legittimare — almeno localmente — l’affermazione non-vita implica morte. In questo caso, la relazione ascendente funziona come una bi-implicazione, che rende l’opposizione vita/morte simile a una contraddizione logica.
Questo avviene in contesti locali, come quello dell’identità tra felino e gatto […] dove si può ignorare la nebulosa di significati dei due lessemi, che rende in generale impossibile considerarli contraddittori.
La forza della significazione ascendente dipende dalla frequenza delle Trasformazioni che la supportano. Quando le narrazioni che oppongono vita e morte sono molteplici e culturalmente radicate, esse contribuiscono a consolidare la relazione come se fosse universalmente vera. Tuttavia, a differenza delle implicazioni logiche, le relazioni culturali devono essere continuamente riaffermate. Solo così restano vive. Ciò può avvenire in forma esplicita — per esempio attraverso enunciati del tipo “quando non si vive più si muore” — oppure attraverso narrazioni in cui la Trasformazione è implicita e può essere portata alla luce attraverso l’analisi.
Secondo Barbieri, il quadrato semiotico, concepito in questa prospettiva, non è semplicemente una griglia concettuale, ma uno strumento operativo per analizzare la natura ipotetica e relazionale del senso. Ogni significato, anche il più elementare, nasce da un atto di costruzione trasformativa. E ogni opposizione, per essere tale, deve essere posta, non semplicemente rilevata.
Riferimento bibliografico: Daniele Barbieri, Strutturalismo processuale? Il quadrato semiotico e la genesi del senso, in «E|C», Serie Speciale – Anno XIII, n. 25, 2019.