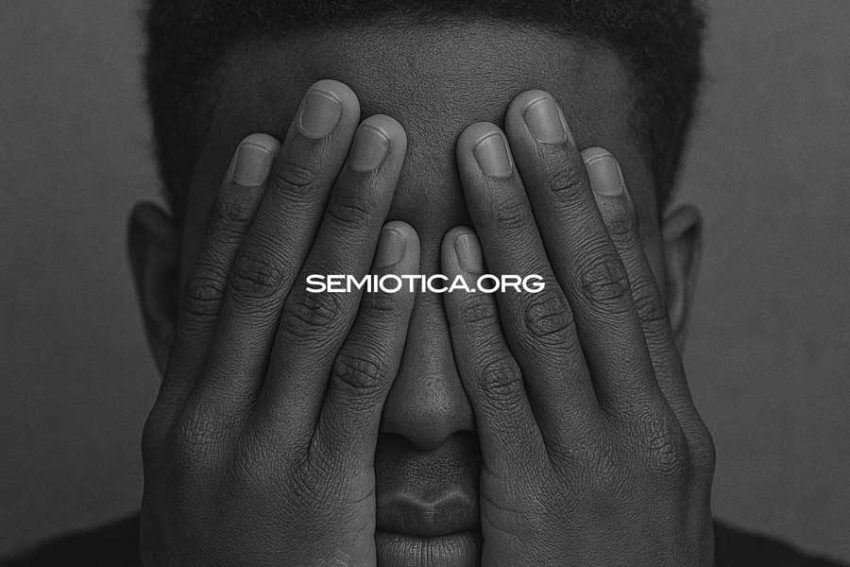Nel saggio teorico che conclude Mythologies, Roland Barthes elabora una definizione rigorosa del mito come sistema semiologico di secondo livello, fondato su una rilettura in chiave saussuriana del segno. L’operazione teorica è ritenuta cruciale per la comprensione della natura ideologica delle rappresentazioni borghesi.
Barthes parte dalla nozione saussuriana di segno come unione di significante e significato. In questo quadro, qualsiasi elemento comunicativo (una parola, un’immagine, un gesto, un oggetto, ecc.) può costituire un segno di primo livello. Ma quando questo segno viene riutilizzato per veicolare un altro significato, allora esso diventa significante di secondo livello: nasce così il mito.
Un esempio fondamentale: il soldato nero sulla copertina
Barthes propone un esempio: una rivista mostra la fotografia di un giovane nero in uniforme francese, nell’atto di fare il saluto militare alla bandiera tricolore. A un primo livello, l’immagine ha un significante (la foto stessa) e un significato (“un soldato nero che saluta la bandiera”). Questo è il segno di primo livello.
Ma tutto questo segno diventa a sua volta un significante mitico, che veicola un altro significato: “la Francia è un grande impero, accogliente verso tutte le razze; anche un africano può amarla e servire la sua bandiera”. Questo è il secondo segno, il segno mitico, quello che svuota il primo per imporgli una nuova lettura.
Il mito svuota il segno e lo deforma
Il secondo segno, spiega Barthes, non è prodotto dal soggetto rappresentato, ma da chi costruisce e manipola l’immagine: “Il segno mitico non è prodotto da quel soldato nero reale […] ma dalla redazione del giornale che usa quell’immagine per la propria copertina” (come osserva giustamente Marrone, citato da Traini).
Il mito, dunque, è parassitario: sfrutta il significato originario, lo sospende, e vi sovrappone un altro senso. Questa ambiguità è necessaria: “il mito deve nascondersi nel primo livello”, afferma Barthes. Il mito non nasconde, ma deforma: è un’operazione di camouflage ideologico.
Naturalizzare la storia: esempi di primo e secondo livello
Barthes riprende esempi già analizzati nel volume per chiarire la struttura a due livelli del mito:
- Le fotografie dei matrimoni, segni di primo livello, diventano veicolo mitico per affermare che il matrimonio è l’esito naturale dell’unione amorosa.
- Le foto dell’inondazione, a livello primario, documentano un fatto. Ma rielaborate dalla stampa, producono un mito della solidarietà e della festa collettiva.
Scrive Barthes: “Il mito trasforma la storia in natura […]: tutto avviene come se l’immagine provocasse naturalmente il concetto, come se il significante fondasse il significato”.
Il ruolo del mitologo: svelare la costruzione
Il compito dell’analista, o mitologo, è proprio quello di scomporre questi livelli, individuare la deformazione, e restituire al segno la sua complessità. Il mitologo deve rifiutare la passività della ricezione e decostruire il meccanismo che fa apparire come ovvio ciò che è storicamente determinato.
Riferimento Bibliografico:
Stefano Traini. Le due vie della semiotica: Teorie strutturali e interpretative (Strumenti Bompiani)