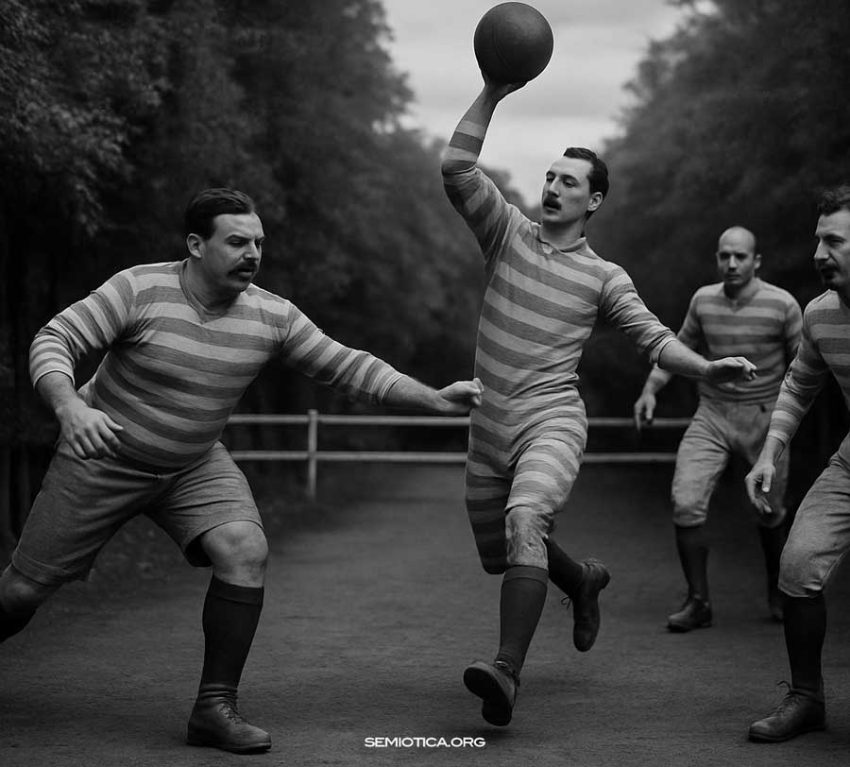Nel momento in cui osserviamo un testo nella sua interezza, possiamo riconoscere al “punto di vista della fine” un valore particolare. Daniele Barbieri sottolinea che, una volta conclusa la fruizione, il testo viene interpretato sulla base delle strutture che è possibile individuare a partire dalla sua conclusione. Questo punto di vista consente interpretazioni più stabili rispetto a quelle provvisorie, formulate durante la lettura, ma la loro validità non è assoluta: il testo può contenere porzioni che, anche alla fine, non trovano completa risoluzione.
Barbieri propone di affiancare alla nozione di termine percettivo quella di forma. Ogni forma è una configurazione percettiva o concettuale cui attribuiamo un senso di completezza. Essa si distingue dal termine percettivo per il fatto di possedere una chiusura: una condizione di compiutezza che interrompe la tensione. Un termine percettivo può rimandare a una forma, ma può non coincidere con essa. Per esempio, nella poesia L’infinito di Leopardi, “Ma sedendo e” non è una forma, perché non costituisce un’unità compiuta a nessun livello rilevante del testo; è solo un termine percettivo che promette uno sviluppo.
Ogni configurazione percettiva è almeno un termine percettivo, perché percepiamo qualcosa solo nel momento in cui siamo in grado di riconoscerlo come parte di una forma. Ma tale riconoscimento dipende dal contesto e dal sistema culturale: una stessa configurazione può essere interpretata diversamente secondo i codici in gioco. Questo conferisce al termine percettivo una natura relazionale e dinamica.
Nel corso della fruizione testuale, ci imbattiamo in numerosi termini percettivi e in numerose forme. Non tutte troveranno conferma. Alcuni termini percettivi risultano fuorvianti: rinviano a forme che non si realizzano. In questi casi, Barbieri spiega che il fruitore può trovarsi in una condizione di disorientamento cognitivo — un breakdown interpretativo — che, se ben gestito, può generare effetti di sorpresa o ripensamento. La correzione interpretativa è alla base del piacere testuale: ciò che all’inizio sembrava una forma A si rivela essere una forma B, meno probabile ma possibile. Questo meccanismo di ricalcolo interpretativo è anche alla radice dell’evoluzione stilistica.
I testi estetici giocano con queste aspettative sorprendendo il fruitore, ma in modo plausibile. L’elemento innovativo — la forma B — deve risultare riconoscibile, sebbene inattesa. È questa tensione tra improbabilità e plausibilità che garantisce la riuscita retorica del testo. Barbieri osserva che, una volta acquisita la forma B, essa può entrare a far parte del repertorio condiviso, divenire norma, e aprire lo spazio per una futura forma C.
Questa dinamica si innesta sulla natura architettonica delle forme, che sono organizzate secondo gerarchie. Forme semplici (come le parole) costituiscono forme più complesse (come i sintagmi, le proposizioni, i periodi). A ciascun grado di complessità corrisponde una chiusura formale. Ma non tutte le chiusure coincidono: una chiusura sintattica può non coincidere con quella metrica o semantica. Quando, invece, più chiusure coincidono, il luogo testuale acquisisce un rilievo particolare.
Il luogo di massima coincidenza delle chiusure è la fine del testo: qui tutte le forme ancora aperte trovano conclusione. È in questo punto che avviene il passaggio dal significato ipotetico a quello evidente, e dove certi giochi vengono “smascherati”. E tuttavia, finché non tutte le forme sono chiuse, il testo può generare una reinterpretazione retrospettiva: il significato evidente resta provvisorio fino alla chiusura globale.
Un esempio paradigmatico di questo meccanismo è fornito dalla narrativa poliziesca. Fino a che il colpevole non è svelato, ogni elemento può essere riletto in modo differente. Il lettore di Agatha Christie sa bene che ogni dettaglio, ogni frase apparentemente neutra, può cambiare significato alla luce del finale. Barbieri cita il caso del dottor Sheppard in Assassinio di Roger Ackroyd: le sue parole iniziali si rivelano ambigue solo retrospettivamente.
Il testo estetico costruisce quindi un sistema stratificato di forme e chiusure, capace di generare aspettative e riformulazioni, tensioni e risoluzioni. Ed è proprio questo gioco tensivo che costituisce il fulcro della sua efficacia retorica.
Riferimento bibliografico: Daniele Barbieri, Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo, Milano, Bompiani, 2004.