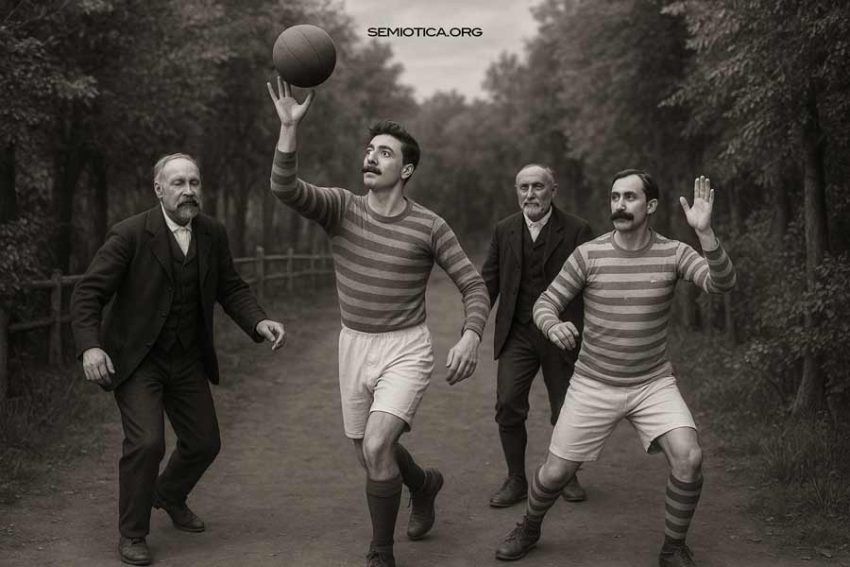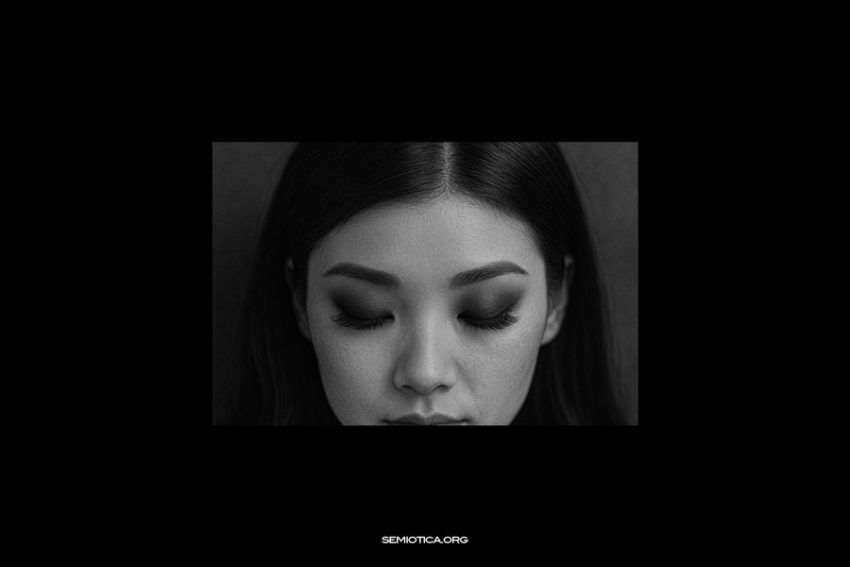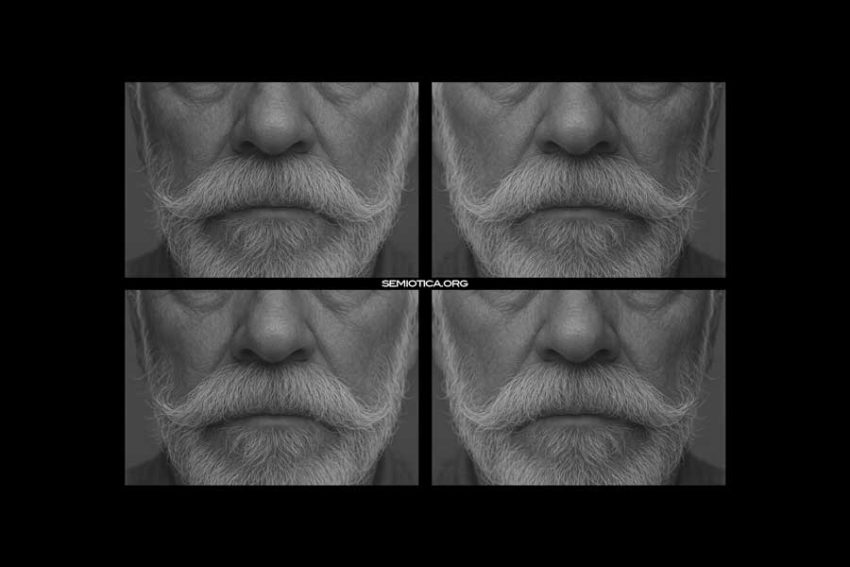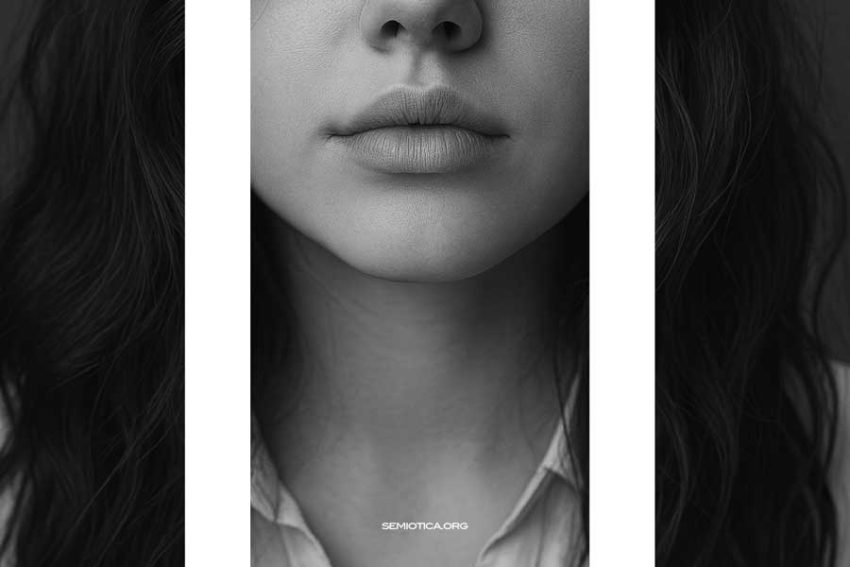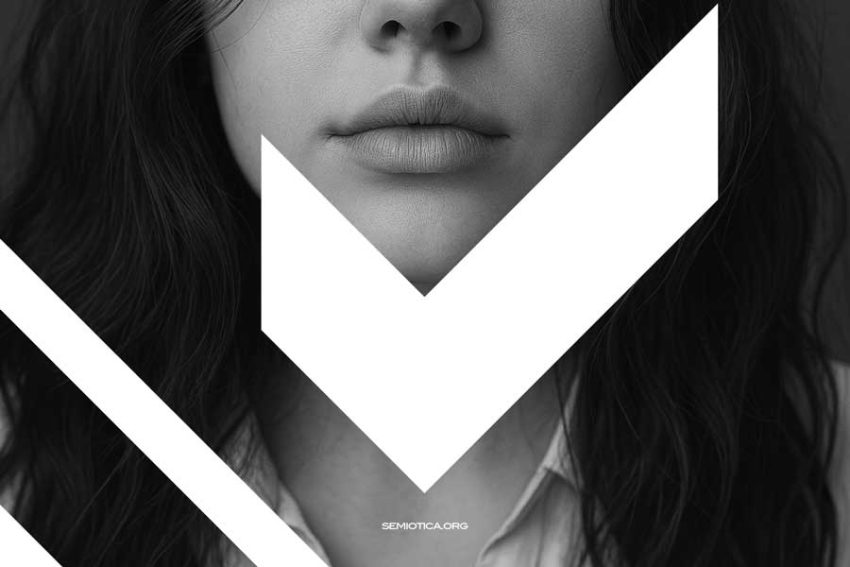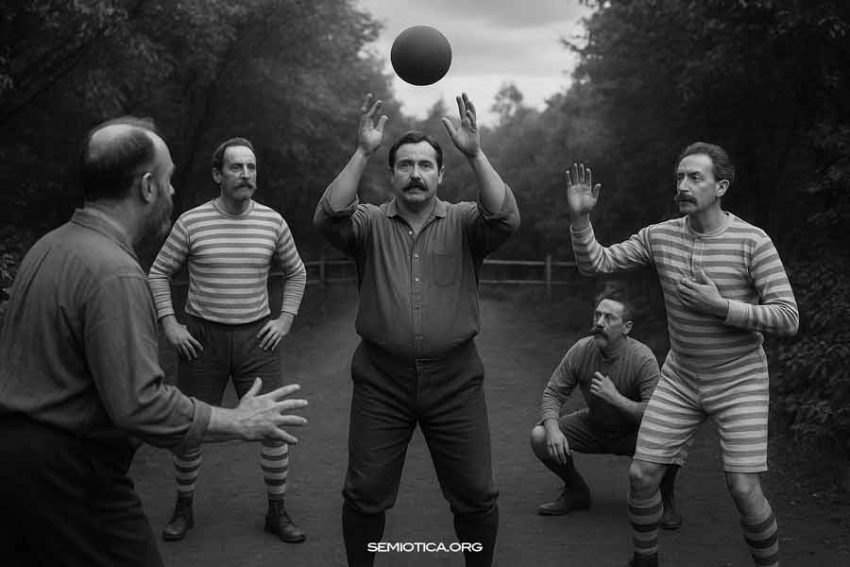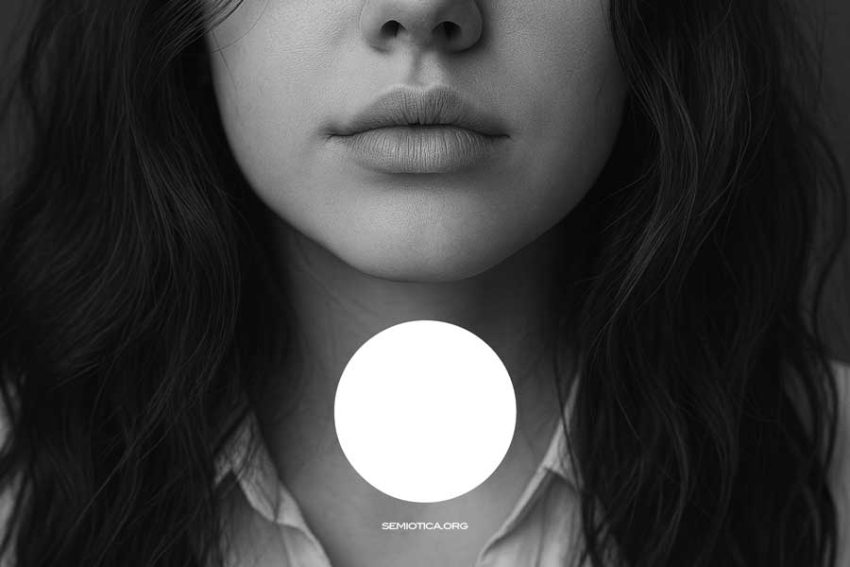Nel quadro degli sviluppi più recenti del campo interpretativo, Stefano Traini sceglie di soffermarsi sulla teoria semantica di Patrizia Violi così come formulata nel volume Significato ed esperienza (1997). Benché questa teoria accolga influenze di varia provenienza — dalla linguistica strutturale alla filosofia analitica, dalla psicologia cognitiva alla narratologia generativa —, molti dei suoi presupposti si pongono…
Mese: Luglio 2025
Linguaggio stratificato: analogico e digitale oltre i due emisferi
Paolo Fabbri affronta la questione della distinzione tra analogico e digitale, centrale nella teoria dell’informazione e nella riflessione linguistica del secondo Novecento. Questa dicotomia — che associa l’analogico alla continuità e il digitale alla discrezione — ha influenzato a lungo il modo in cui si concepisce il funzionamento dei linguaggi, anche in semiotica. Ma per…
Naturalismo e invenzione: tra poesia, zoologia e parodia scientifica
Il Nasobēm avanza con grazia, poggiato sul suo naso, seguito dal suo piccolo. È una creatura immaginaria, ma non un mostro: è una specie. Con questa affermazione, il poeta tedesco Christian Morgenstern, nel componimento Das Nasobēm (1905), mette in discussione il confine tra finzione e realtà naturalistica, tra creazione poetica e classificazione zoologica. Il nome stesso dell’animale – una…
Tre tendenze interpretative: Autore, Opera, Lettore
Roberto Pellerey propone una tipologia delle teorie dell’interpretazione, distinguendole in base al peso attribuito ai tre elementi fondamentali coinvolti in ogni atto interpretativo: Autore (o Emittente), Opera (o Testo), Lettore (o Destinatario). «Vi è infatti chi ha ritenuto che interpretare il senso di un testo significhi innanzi tutto capire l’autore». Secondo questa prima tendenza, comprendere un’opera…
Modelli operativi della semiotica: paradigmi, sintagmi, interpretazione
Nella riflessione di Alessandro Zinna, l’applicazione della teoria semiotica non è mai una semplice esecuzione meccanica, ma un processo articolato che implica la selezione, la trasformazione e la descrizione dell’oggetto. È in questo contesto che emergono tre modelli operativi distinti, ciascuno fondato su un diverso rapporto tra sistema e processo, tra virtuale e realizzato: il modello…
Ugo Volli. La semiosi dell’ideologia: segni, interpretanti, deriva
Affrontando il concetto di “ideologia” da una prospettiva semiotica, Ugo Volli insiste sulla necessità di evitare le idées reçues che circondano il termine. Per farlo, propone una riflessione preliminare sul modo in cui la semiotica affronta i concetti culturali: anche “ideologia”, come ogni altro termine studiato dalla disciplina, è un’unità culturale, e dunque un segno, secondo la definizione…
Jakobson e le tre forme della traduzione: oltre il linguaggio verbale
Nel suo celebre saggio del 1959, Roman Jakobson individua tre forme fondamentali di traduzione: la traduzione intra-linguistica (o riformulazione), la traduzione inter-linguistica (quella comunemente intesa come passaggio da una lingua a un’altra) e infine la traduzione inter-semiotica (o trasposizione), in cui un contenuto espresso con un sistema linguistico viene trasferito in un sistema non linguistico,…
Il conflitto tra stili interpretativi: razionalità e mistero
Nelle culture fondate su testi sacri o fondativi, il contrasto tra stili interpretativi differenti rappresenta il cuore di questioni politiche fondamentali: chi ha diritto di interpretare i testi sacri, e quindi di esercitare un’autorità sulla comunità? Quali destinanti hanno il potere di sanzionare tali interpretazioni? Jenny Ponzo propone di immaginare tali culture come semiosfere (Lotman) con una struttura semplice: al centro…
Il ritmo come principio di senso: percezione, fiducia e forma estetica
Verónica Estay Stange sviluppa una riflessione sul ritmo come principio trasversale e fondativo del piano dell’espressione, all’interno di una prospettiva che potremmo definire semio-fenomenologica. Il ritmo viene qui inteso non come mera misura o conteggio, ma come organizzazione dinamica del sensibile, capace di generare forme, condurre la percezione, e fondare la fiducia nell’“esserci” dell’opera. A…
Misticismo e ideologia semiotica: un confronto critico con Max Weber
Max Weber, nel tentativo di individuare idealtipi religiosi funzionali alla propria interpretazione dello sviluppo capitalistico, elabora una contrapposizione tra ascesi e misticismo. Il primo viene associato all’attività, il secondo alla passività, secondo uno schema che egli stesso articola così: Ascesi / Misticismo = Attivo / Passivo. Da questo punto di vista, il mistico appare a…