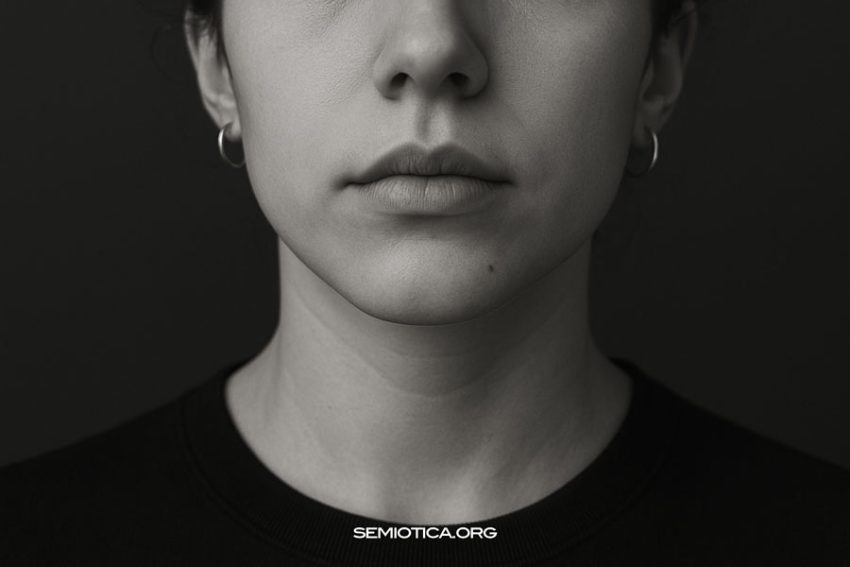Claudio Paolucci sviluppa una densa riflessione sul concetto di interpretazione, interrogandosi sulla natura dell’abito culturale e sul punto preciso in cui può darsi un atto interpretativo. In questa prospettiva, l’interpretazione non è considerata come un semplice riconoscimento del senso, ma come un momento di crisi, di sospensione dell’automatismo, in cui l’abito non funziona più in modo trasparente.
Secondo Paolucci, l’abito è una regolarità che struttura la cultura. È una forma di acquisizione automatizzata, uno schema che guida il comportamento e la comprensione senza dover essere esplicitamente tematizzato. Tuttavia, perché l’interpretazione possa avere luogo, è necessario che questo abito venga interrotto, cioè che l’oggetto culturale incontri un limite di leggibilità che costringe l’interprete a porsi domande, a ripensare le proprie coordinate di senso.
L’interpretazione si produce precisamente al confine dell’abito, in quel punto in cui una regolarità precedentemente operativa non è più sufficiente a garantire la comprensione. È questo margine, fragile e instabile, che Paolucci individua come luogo teorico dell’atto interpretativo. Non si tratta di una semplice applicazione di norme, ma di una messa in questione delle norme stesse. È lì, nella frizione tra l’abito e il nuovo, che si genera lo spazio semiotico dell’alterità.
L’autore sottolinea che l’interpretazione non è mai un atto solitario o decontestualizzato. Essa si colloca in una cultura, ossia in un ambiente semiotico strutturato da regole, stereotipi, convenzioni. La cultura, in questo senso, funziona come una semiosfera, per riprendere il concetto lotmaniano: un sistema chiuso con frontiere flessibili, dove l’incontro con l’alterità si produce nei punti di contatto con altri sistemi.
Il punto in cui l’abito fallisce è anche il punto in cui può essere trasformato. È lì che si apre la possibilità di un nuovo abito, di una nuova regolarità culturale. L’interpretazione si manifesta dunque come passaggio tra abiti, come soglia in cui l’elemento non interpretato si converte in significato attraverso un lavoro di ricomposizione e traduzione.
Questo processo, spiega Paolucci, non è mai completamente controllabile. È esposto al rischio, all’inadeguatezza, all’incompiutezza. La cultura, in quanto sistema di abiti, produce senso proprio nella misura in cui è capace di sospendere se stessa, di mettere a distanza le proprie automatizzazioni e di trasformarle in oggetti di interpretazione.
In questa prospettiva, l’interpretazione è un fenomeno liminale, un’operazione sui confini: non appartiene più pienamente all’abito precedente, e non è ancora del tutto assorbita in un nuovo abito. È un’interferenza, una discontinuità che apre il campo dell’invenzione semiotica.
Paolucci individua qui un importante punto di discontinuità con la semiotica generativa. Se quest’ultima tendeva a spiegare l’interpretazione attraverso la ricostruzione delle regole, il paradigma interpretativo – faneroscopico e strutturalista insieme – si concentra sull’atto stesso della sospensione, su quel momento critico in cui le regole devono essere riformulate. È in questo punto cieco, in questa frattura, che la semiotica minore trova il proprio oggetto privilegiato.
Riferimento bibliografico: Claudio Paolucci, Strutturalismo e interpretazione. Ambizioni per una semiotica “minore”, Milano, Bompiani.